Qual è la vera funzione del titolo di un’opera d’arte? Le risposte dell’esperta
Per il nuovo appuntamento di “Dialoghi di Estetica”, intervistiamo Chiara Ianeselli, che ha dedicato il suo ultimo libro a un problema fondamentale delle opere d’arte: i titoli. E soprattutto la loro assenza, come accade da settant’anni a questa parte, con il famigerato “Senza titolo”

Storica dell’arte e curatrice, Chiara Ianeselli ha lavorato nel dipartimento curatoriale di dOCUMENTA (13), alla 14° Biennale di Istanbul, ed è stata assistente al padiglione condiviso di Lituania-Cipro e del padiglione del Cile per la 55. Biennale di Venezia. Nell’ultima edizione di documenta fifteen ha ricoperto il ruolo di coordinatrice curatoriale. La sua ricerca di dottorato si è concentrata sul potere delle didascalie e dei titoli delle opere d’arte, progetto poi sviluppato ulteriormente tramite una postdoc fellowship all’Istituto di Studi Museali a Berlino. Attualmente collabora con il MAXXI per lo sviluppo di un nuovo progetto museale. Ianeselli ha pubblicato di recente il libro “Sulla necessità del Senza titolo. Il silenzio come linguaggio dell’arte” con la casa editrice Postmedia Books di Milano, ne abbiamo parlato con lei in questo dialogo.
Intervista a Chiara Ianeselli
Nel suo libro lei affronta il problema della presenza e dell’assenza di un titolo per un’opera d’arte: perché ha deciso di occuparsene?
Mi sono sempre chiesta come il titolo possa influenzare l’esperienza del visitatore, come il linguaggio verbale si riesca a rapportare ad una struttura così complessa come l’opera d’arte: perché talvolta il titolo diventa imprescindibile mentre in altri casi è totalmente irrilevante? È interessante anche dal punto di vista del fruitore: c’è chi entra in un museo concentrandosi sul titolo, chi ignora ogni parola scritta, e chi prova frustrazione se la didascalia manca. Mentre alcuni artisti mi chiedono suggerimenti per i titoli, altri, come Robert Ryman, li sceglievano sfogliando le Pagine Gialle. La presenza dei titoli delle opere è in realtà un elemento recente nella storia dell’arte. Come scrivo nel libro, il titolo è stato introdotto tra il XVIII e il XIX Secolo, aggiungendo un livello di esperienza dell’opera d’arte, diventando poi un elemento fondamentale nel XX Secolo. Perché dunque a un certo punto gli artisti scelgono di non intitolare le opere o intitolarle Senza titolo? Si tratta di un tema scarsamente trattato in letteratura, con una bibliografia esigua, ma è un’area incredibilmente interessante per artisti e i fruitori. Un elefante nella stanza.

Incanti, il settimanale sul mercato dell'arte Informazioni, numeri, tendenze, strategie, investimenti, gallerie e molto altro.

Render, il bisettimanale sulla rigenerazione urbana Nuovi progetti, tendenze, strategie virtuose, storie da tutto il mondo, interviste e molto altro.

PAX, il bisettimanale sul turismo culturale Approfondimenti sul turismo culturale come chiave di comprensione dei territori e delle comunità che li abitano.

Solitamente, che funzione ha un titolo rispetto alla nascita e alla storia di un’opera d’arte?
Il titolo oggigiorno equivale al nome di battesimo, ed è qualcosa che sigilla ciascuna opera d’arte, la controlla, la ammansisce e in certi casi ne facilita il processo interpretativo. Ovviamente va operata una distinzione tra i titoli attribuiti, e i titoli definiti nel saggio come autoriali, ovvero concepiti dagli artisti stessi. La relazione tra immagine e parola è una delle più complicate ed avvincenti nella storia, e l’equilibrio tra le due è in continua oscillazione: è stato violato in un senso o nell’altro. Nel Surrealismo e nel Dadaismo, ad esempio, il titolo è stato imprescindibile per la fruizione: l’opera era quasi un’illustrazione, un’immagine di quanto scritto nel titolo. A volte il titolo è diventato quasi l’opera stessa, come nel celebre Erased de Kooning Drawing (1953) di Robert Rauschenberg.
Oltre a questi aspetti, lei sottolinea anche la relazione tra i titoli e le possibili interpretazioni delle opere: di che tipo di relazione si tratta?
Il titolo apre a molte questioni: costituisce una via più autentica attraverso la quale guardare l’opera d’arte? Il fatto che sia definito, eventualmente, dall’autore, lo rende più rilevante rispetto ad altre interpretazioni, dei critici o del pubblico stesso? Nel saggio ho esplorato l’ambito del titolo considerandolo come un’area di controllo e di potere, area in cui in maniera diversa gli artisti, i critici o i curatori sono intervenuti. Parlandone non posso fare a meno di menzionare un passo tratto dagli scritti di Clyfford Still (del 1976): “Le persone dovrebbero guardare l’opera in sè e determinarne il significato per loro […] Preferisco la reazione innocente di coloro che potrebbero pensare di vedere forme di nuvole nei miei dipinti a ciò che Clement Greenberg dice di vedere in essi”.
Questione singolare, quella dell’assenza di un titolo per un’opera d’arte. Oltre ai casi di una sua eventuale mancata realizzazione, il tema che lei porta in primo piano è anche quello di una scelta precisa dell’artista che ne fa a meno. Come si spiega questa necessità?
Già dalle prime decadi del Novecento alcuni artisti iniziano a preferire ai titoli evocativi quelli descrittivi — come paesaggio, olio su tela, ritratto, composizione o astrazione — Miró chiedeva al suo gallerista Pierre Matisse di utilizzare titoli il più neutri possibile. Solo negli Anni Quaranta e Cinquanta, però, la scelta diventa più consapevole: gli artisti eliminano ogni riferimento, optando per Senza titolo o per numerazioni casuali. In un contesto di crescente mercato dell’arte e di ampliata visibilità dell’artista, di diffusione dei mezzi di stampa e di potenza comunicativa, in maniera solo apparentemente paradossale si diffonde l’uso del Senza titolo. Clyfford Still e Mark Rothko, ad esempio, adottano il Senza titolo per evitare “allusioni che interferiscano o assistano lo spettatore” (Still, 1949). Il primo si infuriò tremendamente quando Peggy Guggenheim e André Breton intitolarono le opere esposte alla sua mostra Clyfford Still, First exhibition paintings, era il 1946; mentre Rothko si divertiva a numerare le opere in maniera arbitraria, lasciando poi agli storici dell’arte che si occuparono di ricostruire il suo percorso un grande enigma. Pollock stesso, i cui titoli sono stati molto frequentemente attribuiti da critici e collezionisti, preferiva un approccio passivo degli spettatori: “penso che non dovrebbero cercare, ma guardare passivamente – e cercare di ricevere ciò che il dipinto ha da offrire e non portare un soggetto o un’idea preconcetta di ciò che devono cercare” (Pollock, 1950).
 1 / 5
Carlo Benvenuto, Senza titolo (2010)
1 / 5
Carlo Benvenuto, Senza titolo (2010)
![Yves Klein (Untitled Anthropometry [ANT 56])](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2025/11/5-768x234.png) 2 / 5
Yves Klein
(Untitled Anthropometry [ANT 56])
2 / 5
Yves Klein
(Untitled Anthropometry [ANT 56])
![Edvard Munch, [Title under consideration ], conosciuto come Negro with Green Scarf, olio su tela,1916. Photo (C) Munchmuseet](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2025/11/4-3-768x1060.jpg) 3 / 5
Edvard Munch, [Title under consideration
], conosciuto come Negro with Green Scarf,
olio su tela,1916. Photo (C) Munchmuseet
3 / 5
Edvard Munch, [Title under consideration
], conosciuto come Negro with Green Scarf,
olio su tela,1916. Photo (C) Munchmuseet
 4 / 5
Simon Maris, Isabella
(1906)
4 / 5
Simon Maris, Isabella
(1906)
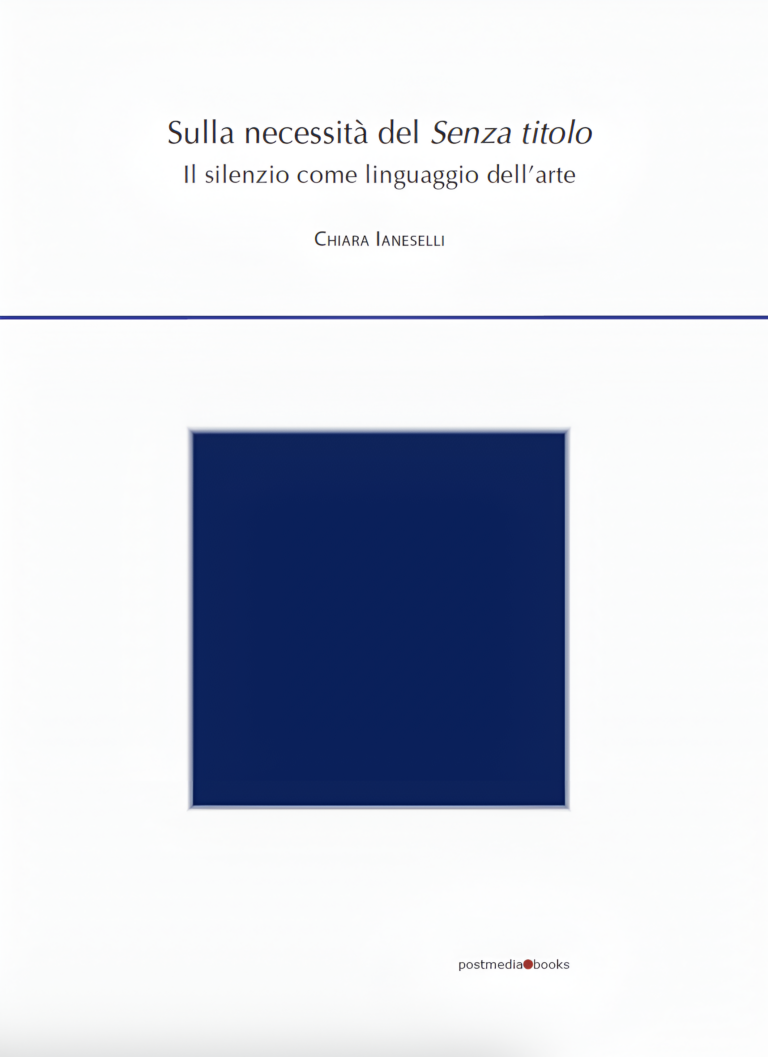 5 / 5
Sulla necessità del Senza titolo (Postmedia books, 2025)
5 / 5
Sulla necessità del Senza titolo (Postmedia books, 2025)

![Edvard Munch, [Title under consideration ], conosciuto come Negro with Green Scarf, olio su tela,1916. Photo (C) Munchmuseet](https://www.artribune.com/wp-content/uploads/2025/11/4-3-109x150.jpg)


Nella seconda metà del Novecento la controversia sulla presenza di un titolo prende anche altre forme.
Ad Reinhardt si è espresso chiaramente: la sua arte era “non oggettiva, non rappresentativa, non figurativa, non immaginista, non espressionista, non soggettiva. L’unico modo per dire che cos’è l’arte astratta o l’arte come arte è dire che cosa non è” (Reinhardt, 1994): ne deriva dunque la scelta del Senza titolo. Un sentimento di rivolta verso lo status quo, di estrema sperimentazione si registra all’epoca in diverse forme e linguaggi. L’attenzione alla negazione emerge già negli anni Cinquanta: penso a John Cage con la sua Lecture on Nothing (1950), a Yves Klein con la spoliazione della galleria Iris Clert nel 1958 (“La specializzazione della sensibilità allo stato grezzo della materia in sensibilità pittorica stabilizzata, Il vuoto”), al Manifesto contro il niente del 1960 e, nel 1966, alla pubblicazione di Contro l’Interpretazione di Susan Sontag.
Nel libro, gli esempi che ha scelto per illustrare i diversi problemi legati all’assenza dei titoli sono tratti dalla produzione artistica del secondo dopoguerra: da quella di taluni pittori dell’Espressionismo astratto e da quella delle pratiche di orientamento concettualista, spaziando tra minimalismo e Arte Povera. Vi sono differenze o anche eventuali somiglianze nei modi che hanno questi artisti di fare a meno dei titoli?
Pur apparendo identico nei diversi movimenti, il Senza titolo nasce da circostanze, motivazioni e matrici molto diverse: dalla rivolta contro le mitologie dell’opera e il ruolo profetico dell’artista nell’Espressionismo, all’attenzione per la dimensione industriale e linguistica del Minimalismo, fino alla centralità dei materiali e della natura nell’Arte povera. In quest’ultima, il Senza titolo è spesso accompagnato dall’indicazione dei materiali — come nel caso di Giovanni Anselmo, Senza titolo, 1967 (ferro, legno, polietilene trasparente) — assumendo un valore tautologico. Come scriveva Germano Celant (1967) gli artisti dell’Arte povera “intendono schiantare ogni scuola concettuale con la loro pura presenza. Rinunciano volutamente a ogni complicazione retorica, a ogni convenzione semantica. Vogliono osservare e registrare l’univocità della realtà, e non la sua ambiguità come in passato”.
Proviamo a fare un passo avanti e consideriamo l’arte odierna: le esigenze che muovono chi fa arte oggi e sceglie di non dare un titolo alla propria opera, sono le medesime individuate nel suo studio o altre ancora?
Negli ultimi decenni, soprattutto in ambito museale, la presenza di materiale testuale nelle esposizioni è aumentata significativamente. La maggiore consapevolezza di curatori e dipartimenti di mediazione verso le esigenze del pubblico — si pensi alle didascalie introdotte da Bradburne alla Pinacoteca di Brera — e la crescente concezione dell’artista come ricercatore hanno moltiplicato i livelli di stratificazione testuale. Tuttavia, molti artisti continuano a rifiutare di orientare l’esperienza visiva. Alcuni artisti mantengono il Senza titolo fino a quando l’opera non riceve il suo titolo definitivo, a questi si contrappongono, ironicamente le opere intitolate Con titolo di Gino De Dominicis. Sempre più spesso il Senza titolo è accompagnato da parentesi che aprono ulteriormente l’opera: quelle di Félix González-Torres contengono riferimenti affettivi o biografici: Untitled (Perfect Lovers), Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 1991; quelle di Dan Flavin indicano dediche personali: Untitled (to Barnett Newman) one, 1971; mentre le parentesi di Glenn Ligon riportano dichiarazioni politiche o statements: Untitled (I Am a Man), 1988.
E come si rapportano le istituzioni con la questione dei titoli?
Negli ultimi anni si registra una crescente consapevolezza e sensibilità del ruolo del titolo, soprattutto in relazione al dibattito postcoloniale. Molte opere conservano titoli come Ritratto di nero, frutto di visioni del mondo di epoche e contesti culturali passati. Interventi come quelli di Fred Wilson sulle didascalie, o le attualizzazioni dei titoli al Rijksmuseum e al Museo di Dresda, mostrano una maggiore attenzione all’uso di termini potenzialmente discriminatori. Attualmente le mie ricerche sono dedicate a questo campo di indagine.
Davide Dal Sasso
(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Gli episodi precedenti
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati

Lettera, la newsletter quotidiana Non perdetevi il meglio di Artribune! Ricevi ogni giorno un'e-mail con gli articoli del giorno e partecipa alla discussione sul mondo dell'arte.

Davide Dal Sasso
Davide Dal Sasso è ricercatore (RTD-A) in estetica presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca. Le sue ricerche sono incentrate su quattro soggetti principali: il rapporto tra filosofia estetica e arti contemporanee, l’essenza delle pratiche artistiche, la natura del catalogo…



