Dialoghi di Estetica. Parola a Enrico Rava
Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli Anni Sessanta, imponendosi rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana e artistica lo pone al di fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. Questo dialogo inizia con alcune riflessioni sul ritmo e la dimensione narrativa della musica e prosegue valutando il rapporto con la tecnologia, le potenzialità dell’elettronica, lo spazio del jazz e le eventuali simmetrie tra suoni e colori.

Più volte nelle tue riflessioni sulla musica ti sei soffermato sul ritmo, un elemento essenziale tanto per la creazione artistica quanto per un possibile avvio al dialogo che esso può favorire. Che cos’è per te il ritmo?
Il ritmo è la base di tutto. Prima che nella musica, possiamo riconoscerlo nei battiti del cuore, nel respiro, nel tempo che passa. In fondo, il ritmo appartiene alla comunicazione. Penso, infatti, che i diversi modi che abbiamo introdotto nei secoli per materializzare il ritmo siano tutti tentativi per comunicare qualcosa. Le diverse musiche prodotte nel corso della storia lo confermano: il ritmo è imprescindibile, è l’elemento vitale che viene trasmesso attraverso la musica.
In che modo il ritmo diventa centrale nella produzione musicale, attraverso la sua traduzione?
La traduzione del ritmo in musica non esprime solo la vitalità ma anche le diversità tra forme culturali. Per esempio, la musica classica europea ha un ritmo ben più rigido di quella africana. Sono proprio le differenze di ritmo che hanno favorito la diffusione di diversi generi musicali del Novecento. Tra questi, il jazz conserva ancora un ‘ricordo’ di quel ritmo di origini africane, che però rimane appunto solo sullo sfondo. Il ritmo andrebbe considerato anche in rapporto al pensiero, come accade nelle musiche di provenienza indiana. La mia idea è che la possibile condivisione dei ritmi rimandi alla provenienza geografica e culturale della musica. Le difficoltà di condivisione di un ritmo musicale rivelano diversi modi di essere, diversi orientamenti culturali.
Il legame tra ritmo, vitalità e produzione culturale che hai tracciato fin qui ci permette di considerare il tuo interesse per la dimensione narrativa che la musica potrebbe condividere con altre forme artistiche.
Assolutamente. Tra queste, penso in particolare alla letteratura, alle potenzialità dei racconti. Ma occorre fare alcune precisazioni. Un racconto ha un incipit, uno sviluppo in una o un’altra direzione e poi una conclusione. Nella musica posso provare a seguire queste tappe, però, a differenza di altre forme d’arte – la letteratura o il cinema –, i riferimenti della musica non sono riconoscibili.
Come si caratterizza questa condizione della musica?
Se dico che con la musica racconto qualcosa, giustamente la prima osservazione che mi viene fatta è: ok, ma che cosa racconti? Il fatto è che la musica può raccontare qualcosa, ma si tratta di uno sviluppo narrativo profondamente diverso da quello che possono offrire altre forme d’arte. Questo perché la musica agisce su una dimensione diversa.
Di che dimensione si tratta?
Non posso descriverla in modo chiaro. È una dimensione altra del sentire e del capire. Una dimensione radicata nell’uomo da sempre, tant’è che la maggior parte delle persone ha una relazione di ricezione che passa necessariamente attraverso di essa. Ma, se dico che si tratta di un modo di capirla, dico comunque ancora qualcosa di poco chiaro.
Però, c’è un senso in cui proprio voi musicisti siete i primi a capire la musica – la sua essenza, le vie della composizione, le possibilità di variazione…
Sì, c’è una sensibilità che è certamente all’origine del fare musica. Io, per esempio, ho coltivato la mia passione per la musica entrando anzitutto in relazione con i suoi meccanismi. Ho capito come funzionano gli assoli, la centralità dei cicli armonici e le possibilità di introdurre variazioni ecc. Ma si tratta di una specie di stranezza, perché lo stesso mi accade davvero raramente con altre discipline. E, soprattutto, questa dimensione di apprendimento cambia da musicista a musicista.
In fondo, potremmo pensarla come una comprensione delle sue strutture ossia, come hai scritto tu più volte, delle logiche della musica che permettono di poter compiere delle variazioni.
Sì sono d’accordo, è questione di comprenderne le strutture. Chiaramente più si approfondiscono lo studio e la pratica, più questa comprensione si arricchisce. Il musicista viene a conoscenza di un certo numero di codici senza i quali rimarrebbe in superficie. Penso, infatti, che capire le strutture voglia dire non fermarsi a una sensazione immediata, alla ‘pelle del suono’, ma poter entrare in profondità nella musica.
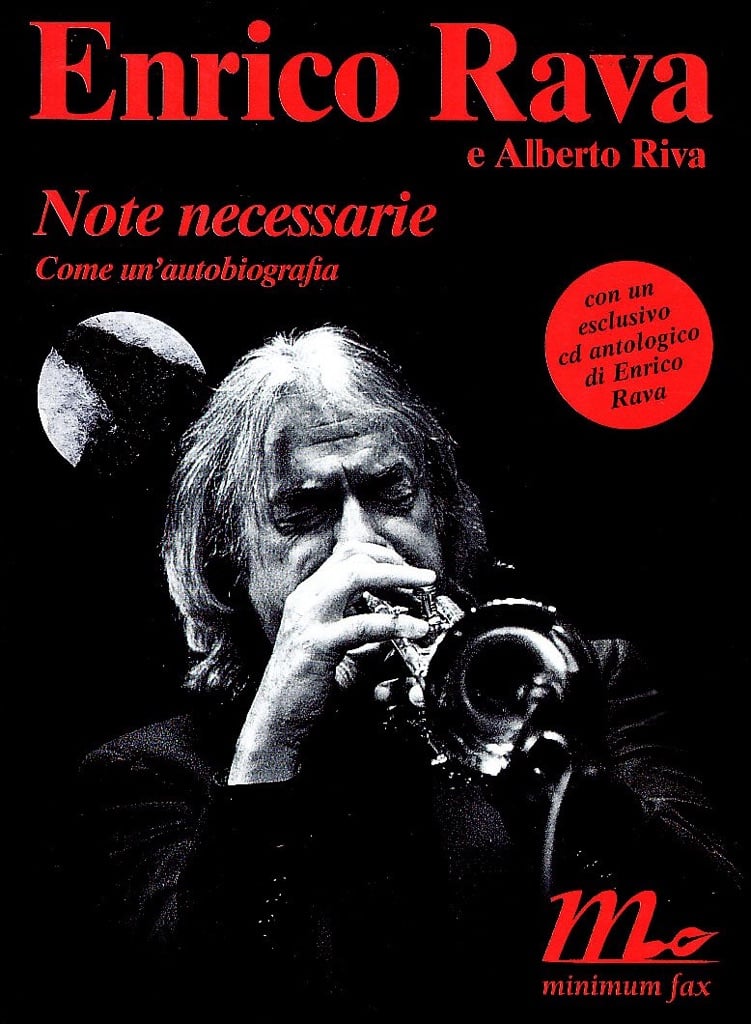
Enrico Rava & Alberto Riva, Note necessarie. Come un’autobiografia (Minimum Fax, 2005)
Leggendo i tuoi libri mi sembra che il tuo interesse per la dimensione narrativa della musica tragga origine anche da quello per il cinema – penso, per esempio, ai tuoi ricordi sui film di Bergman e Fellini che vedevi al cinema Romano di Torino.
Sono ricordi che rivelano anche come sia cambiato il nostro rapporto con le arti. C’era la coda per vedere i film di Bergman, Godard e altri registi d’essai. Oggi però tutto questo è lentamente cambiato. Non solo perché si va a vedere altro ma, soprattutto, perché è in corso una sorta di regressione nella relazione con le arti.
Lo consideri come un cambiamento che investe sia la produzione sia la ricezione?
Sì. Sono cambiati i modi di esprimersi e parallelamente si sono trasformati anche i modi di sentire. In tutto questo la tecnologia svolge un ruolo decisivo. Per esempio, la diffusione degli schermi ha modificato il nostro rapporto con la ricezione dei diversi contenuti. Se da una parte la tecnologia è importantissima, dall’altra mi sembra che sia anche all’origine di una regressione sensibile.
La tecnologia è più una questione di affidamento o di rivoluzione delle possibilità?
Penso che noi ci affidiamo, anche perché la tecnologia ci offre importanti possibilità che altrimenti non avremmo. Numerose facilitazioni. Prendiamo le nostre ricerche: possiamo trovare moltissimo in pochi istanti. Però, mi sembra che questi vantaggi oggi tendano a facilitare anche la possibilità di adagiarsi, di delegare troppo alla tecnologia. Così, per estremo, si arriva alla possibilità che il computer sappia per me qualcosa che alla fine io non ho avuto il tempo o la voglia di imparare.

Enrico Rava, Easy Living (ECM, 2004)
Se dovessi individuare una caratteristica della tecnologia, quale indicheresti?
Direi il fatto che fa parte delle nostre vite, conviviamo con la tecnologia quotidianamente. Da bambino, a sei sette anni, in pieno centro a Torino, giocavo agli scodellini in mezzo alla strada con i miei amici. Ogni mezz’ora venivamo interrotti perché passava una macchina. Oggi, ogni tre secondi rischieremmo di essere tutti quanti stirati – le auto sono di più di allora e il ritmo dei nostri incontri con le tecnologie è cresciuto vertiginosamente.
E rispetto alle arti, come consideri il rapporto tra musica e tecnologia?
In continua trasformazione. Nella musica l’uso dell’elettronica mostra che le possibilità di oggi sono maggiori di un tempo. Non si tratta solo di poter ampliare le vie della combinazione, ma di rinnovare i modi di produzione del senso. Su questo secondo fronte, sono però ancora importantissime la conservazione dell’errore, dell’approssimazione e della casualità. Ossia di quelle tracce umane all’origine della musica. Certo, l’incontro tra strumenti ed elettronica apre a numerose possibilità; ma delle coincidenze e delle casualità non si può fare a meno.
Che cosa pensi della musica elettronica?
Mi piace. È una pratica misteriosa, come insegna il lavoro di Matthew Herbert con cui collaboro. L’elettronica favorisce una continua mutazione dei ritmi, delle possibilità linguistiche e, alla fine, dei modi di suonare. Apre un vastissimo campo di possibilità che è importante continuare a esplorare. Il suo potenziale sta, soprattutto, nel dialogo che continua a rinnovarsi tra il musicista, le macchine e gli strumenti.
Le attuali sperimentazioni dalla musica elettronica potrebbero essere considerate eredità delle ricerche di avanguardia della seconda metà del Novecento?
Solo in parte. In molte di quelle ricerche – nelle arti visive così come in musica e in letteratura – si insiste soprattutto sul gesto, sull’azione, sulla possibilità di stravolgere e contraddire linguaggi preesistenti. Spesso però il risultato penalizza l’apprezzamento. Credo che invece la musica si possa continuamente trasformare attraverso l’elettronica perché c’è un continuo rinnovamento del senso. Questa è una via diversa, attraverso la quale si produce bellezza e si favorisce l’apprezzamento. Fare qualcosa di bello vuol dire fare qualcosa che ha senso.
Spesso hai osservato che fare musica vuol dire anche formare uno spazio. Nella musica, e in particolare nel jazz, come lo possiamo considerare questo spazio?
Beh, sul palcoscenico è uno spazio privato ma principalmente di dialogo. Quando il jazz funziona, questo dialogo diventa profondamente democratico. Si crea uno spazio in cui tutti i partecipanti danno e ricevono ciò di cui c’è bisogno. Affinché si ottenga quella che mi piace chiamare una ‘democrazia perfetta’ – ben lontana da qualcosa di realizzabile nella realtà – è importante che nessuno rinunci al proprio ego e nessuno lo imponga agli altri. Se questa dimensione comunitaria tra i musicisti funziona bene, lo spazio che si crea la proietta sul pubblico che la avverte e coglie il potenziale del jazz.
Rispetto alle strutture della musica pensi che si possa ragionare su una possibile simmetria tra la grammatica dei colori e quella dei suoni?
A volte, durante i workshop, per spiegare ad alcuni dei miei allievi come potrebbero andare le cose, faccio questo esempio: immaginate di lavorare su una parete bianca e, per farne qualcosa di efficace e di riuscito, di dover scegliere quali colori usare e quali no, come accostarli e il modo di disporli nello spazio. L’idea è che noi in musica dobbiamo fare la stessa cosa: riempire uno spazio scegliendo cosa mettervi. I suoni si scelgono, un po’ come si fa con i colori da una tavolozza.
‒ Davide Dal Sasso
 1 / 7
1 / 7
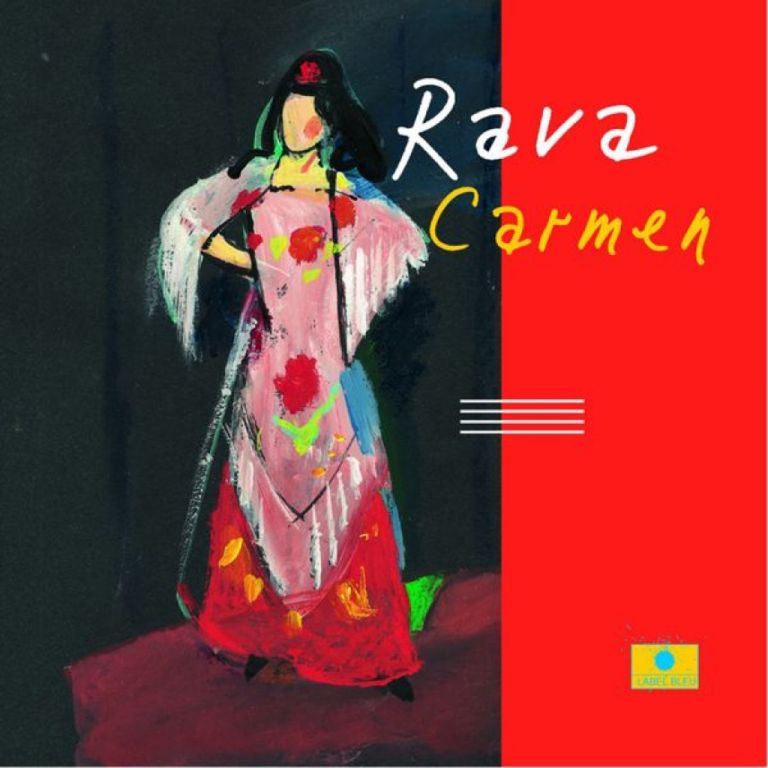 2 / 7
2 / 7
 3 / 7
3 / 7
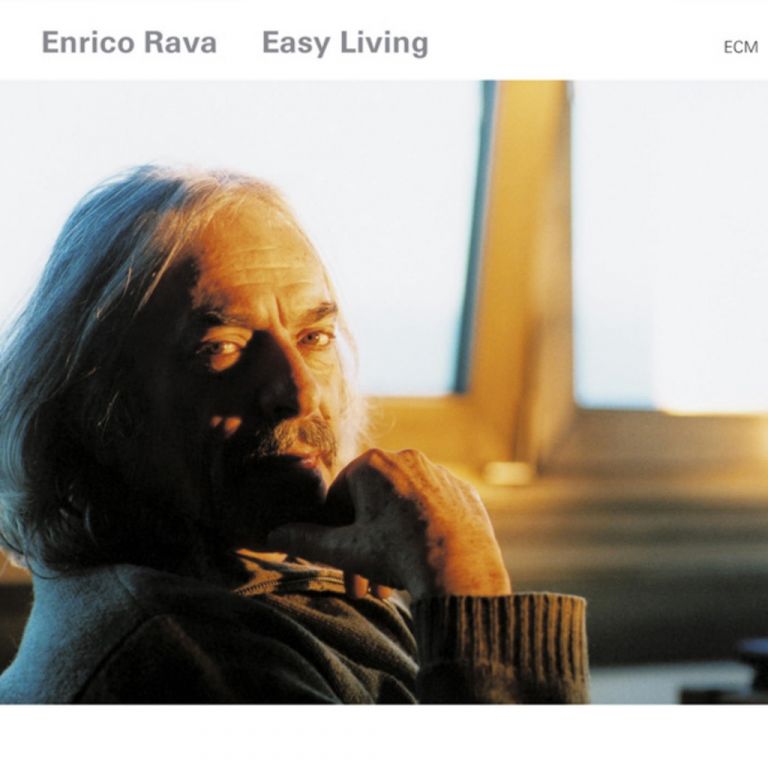 4 / 7
4 / 7
 5 / 7
5 / 7
 6 / 7
6 / 7
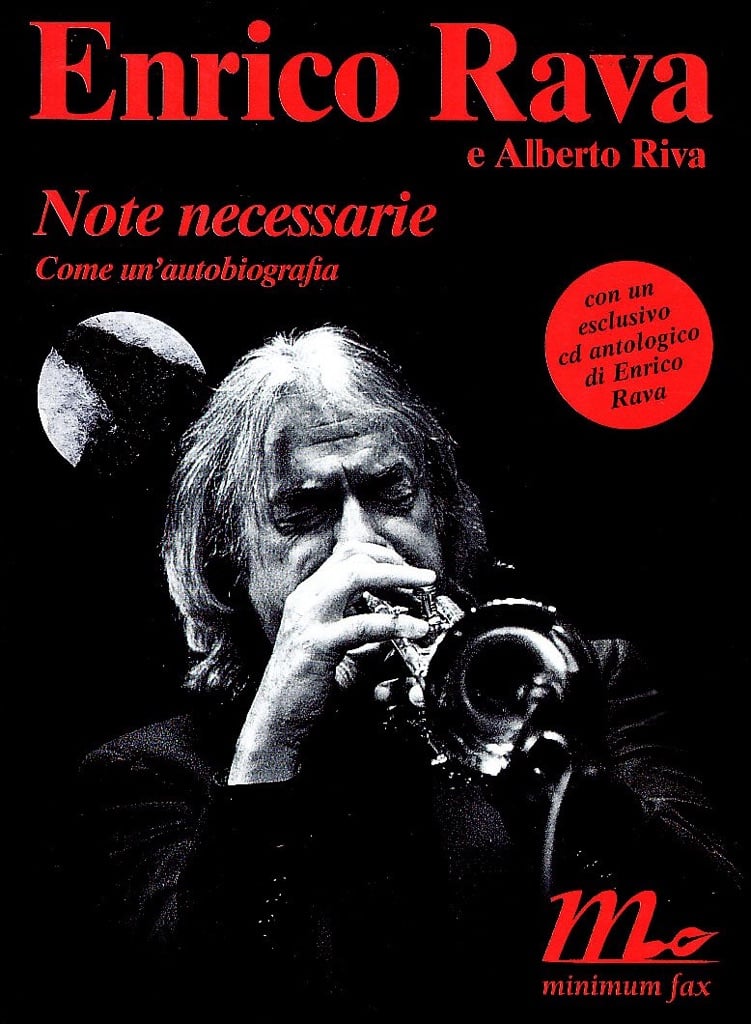 7 / 7
7 / 7
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati












