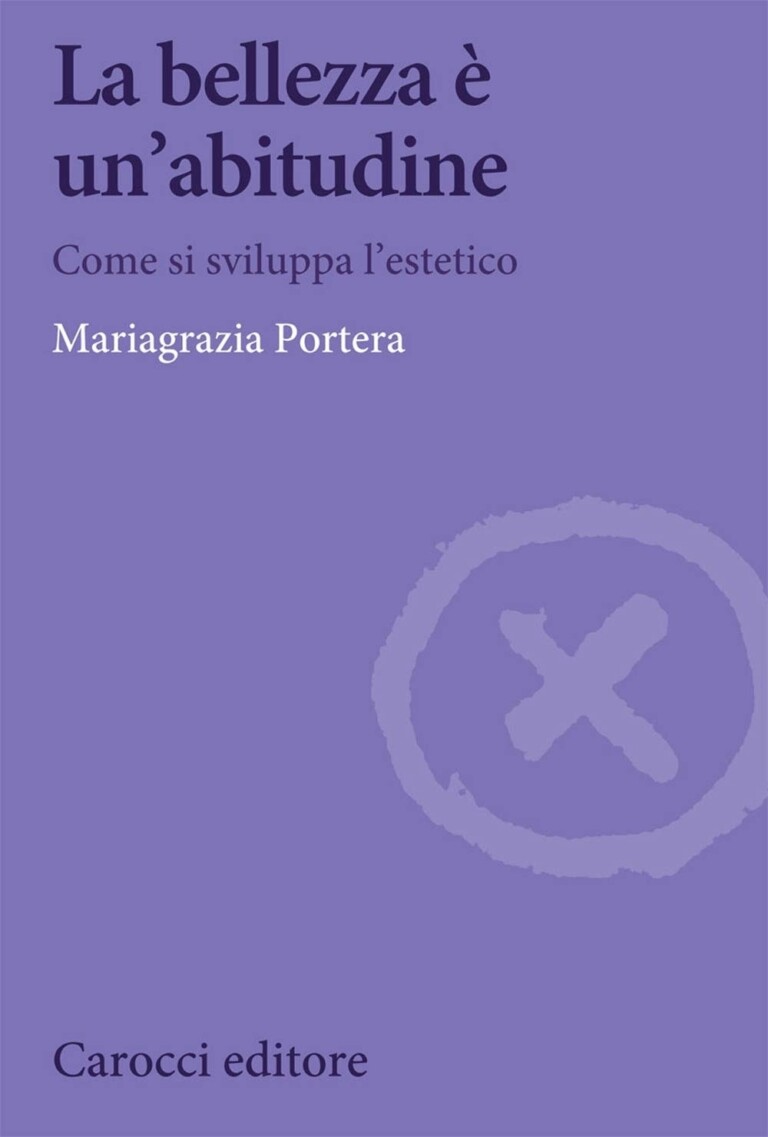Estetica e contemporaneità. Intervista a Mariagrazia Portera
I “Dialoghi di Estetica” questo mese sostano al confine tra filosofia e biologia. E lo fanno in compagnia della ricercatrice Mariagrazia Portera, che da poco ha pubblicato un libro su abito e abitudine

Mariagrazia Portera (Cefalù, 1981) è ricercatrice in estetica presso l’Università degli Studi di Firenze. I suoi principali oggetti di indagine sono la storia dell’estetica (in particolare tra Sette e Ottocento, in area tedesca – con riferimento specifico alla fase di passaggio tra proto-romanticismo e idealismo – e in area inglese) e gli approcci interdisciplinari alle questioni estetiche nel dibattito contemporaneo (in particolare l’estetica evoluzionista, l’estetica cognitiva, l’estetica ambientale). Portera fa parte della redazione della rivista Aisthesis ed è responsabile scientifica dei progetti Unveiling, assessing and taking advantage of the aesthetic dimension in conservation practices: butterflies as a case study, between new theoretical insights and practical applications e Smart beauty. Teoria e pratica del ruolo della dimensione estetica nelle strategie di conservazione delle specie a rischio (entrambi in cooperazione con il dott. Leonardo Dapporto, del Dipartimento di Biologia dell’Università di Firenze).

Mariagrazia Portera
LE RIFLESSIONI DI MARIAGRAZIA PORTERA
È l’autrice del saggio Estetica della contingenza. Exattamenti e pennacchi tra biologia e filosofia (Palermo 2013; vincitore del Premio Nuova Estetica della Società Italiana d’Estetica), dei volumi Poesia vivente. Una lettura di Hölderlin (Palermo 2010) e L’evoluzione della bellezza. Estetica e biologia da Darwin al dibattito contemporaneo (Milano 2015), e curatrice, insieme a Fabrizio Desideri, della raccolta di saggi di Ellen Dissanayake intitolata L’infanzia dell’estetica. L’origine evolutiva delle pratiche artistiche (Mimesis, 2015). Sta sviluppando le sue ricerche attorno al nesso di estetica e scienze della vita, con specifica attenzione alla questione dell’origine evolutiva dell’attitudine estetica umana e al ruolo della dimensione estetica nelle strategie di tutela della biodiversità. Di recente ha cominciato a lavorare all’elaborazione di un modello di estetico umano che abbia nella nozione di habit(us) il suo fulcro. Questo dialogo si sofferma su taluni dei suoi oggetti di indagine, tenendo come riferimento il suo ultimo libro: La bellezza è un’abitudine. Come si sviluppa l’estetico (Carocci, 2021).
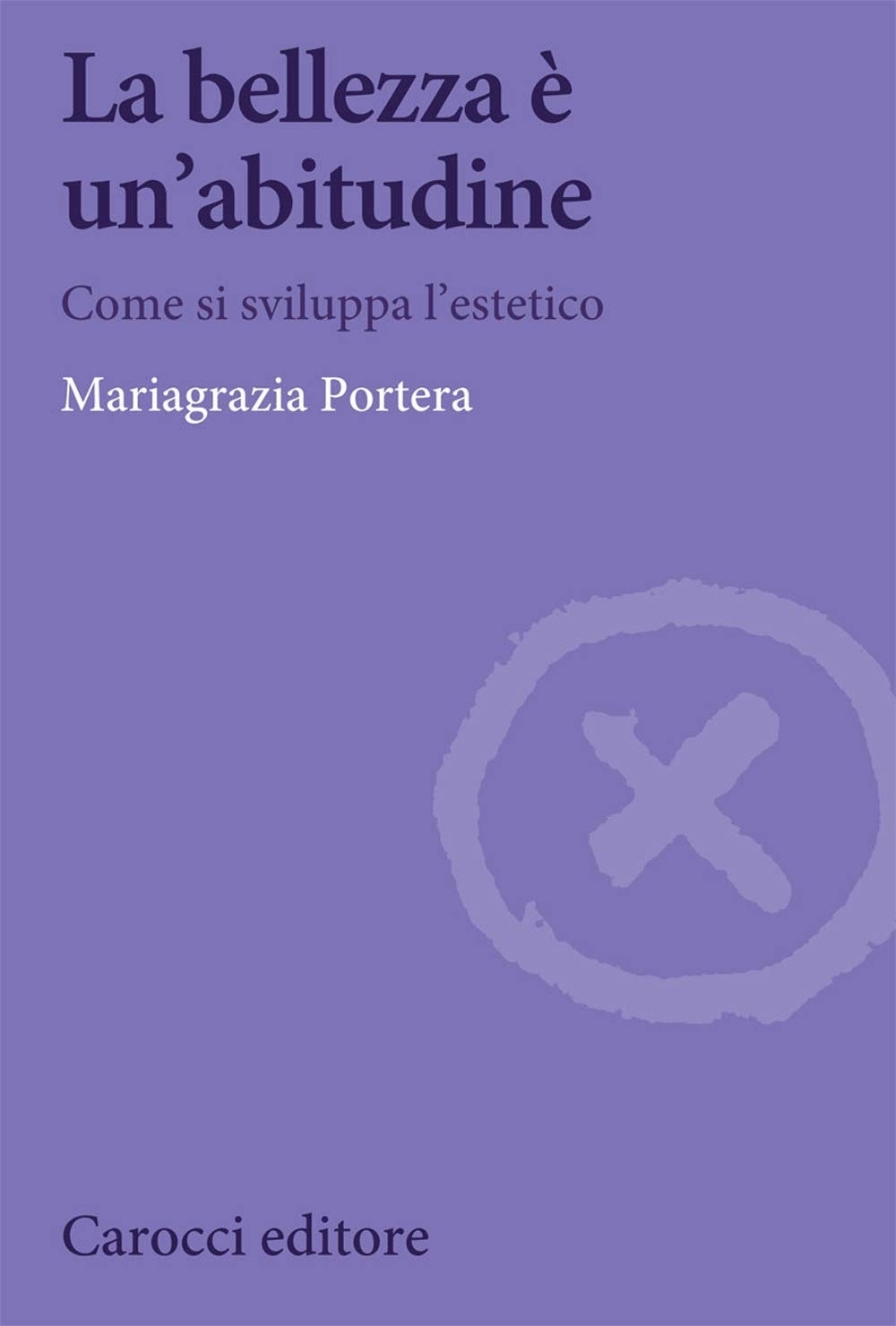
Mariagrazia Portera La bellezza è un’abitudine. Come si sviluppa l’estetico (Carocci, Roma 2021)
INTERVISTA A MARIAGRAZIA PORTERA
L’estetico – inteso come attitudine, come abito – è studiato nelle ricerche contemporanee ponendo attenzione alla sua origine e alle specificità delle esperienze che lo rendono possibile. Nel tuo libro proponi invece uno studio “longitudinale”, basato sul tempo ontogenetico dello sviluppo individuale, sul legame con la vita e la sua naturale mutevolezza. Perché ritieni sia più proficuo impostare la ricerca in questo modo?
Credo occorra anzitutto precisare il perché del mio interesse, dalla prospettiva dell’estetica, per le nozioni di “abito” e “abitudine”. Abbiamo assistito, negli ultimi anni, a un vivace revival d’attenzione per questi concetti, anzitutto in area anglosassone (a partire dalla prima traduzione inglese, nel 2008, del classico De l’habitude di Ravaisson), con una crescita importante di contributi, convegni, ricerche sul tema, in chiave spiccatamente interdisciplinare. Pochi studi, tuttavia, hanno messo in luce il ruolo specifico di abiti e abitudini per l’estetica. Credo invece che queste nozioni (che io accosto principalmente, ma non esclusivamente, attraverso la diade aristotelica di hexis ed ethos) servano a portare in primo piano un aspetto dell’attitudine estetica umana ancora un po’ trascurato, cioè il suo “tempo lungo”. Se è vero che l’estetico non è nulla di innato (pur affondando le sue radici in predisposizioni che precedono largamente l’umano), che può essere coltivato e modulato e che le sue “componenti” di base, cioè – per semplificare un poco – percezione, emozione, immaginazione, cognizione, si modificano e modulano esse stesse nel corso della vita, quali sono i modi e i termini di queste dinamiche di sviluppo? In altri termini, come diventiamo homines aesthetici, visto che non lo siamo già alla nascita? Che cosa muta in noi quando accumuliamo, una sull’altra e nel lungo periodo, esperienze estetiche e che cosa rimane, di converso, immutato? È possibile affermare, credo, che ci “abituiamo” all’estetico, cioè ce ne formiamo un abito, al modo in cui secondo Aristotele acquistiamo la virtù abituandoci a compiere azioni virtuose. Si tratta di questioni “di sviluppo” spesso finite in secondo piano, nella ricerca, rispetto agli interrogativi sull’origine oppure sui meccanismi di funzionamento, al modo dell’istantanea o del fotogramma. L’abito (hexis/ethos), inteso come quella disposizione incarnata frutto di ripetizione e pratica ma non riducibile a mera ripetizione e pratica, è assimilabile non a un’istantanea ma a un filmato disteso, e consente di guardare all’estetico in senso longitudinale, dinamico, nonché interdisciplinare. Come cerco di suggerire nel libro, tale attenzione per la natura abituale dell’estetico sembra tanto più rilevante oggi, entro una cornice di estetizzazione diffusa e iper-mediazione tecnologica, se è vero che già Walter Benjamin, nell’Opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, discuteva del valore canonico guadagnato nei “periodi di svolte storiche” dalla modalità percettiva secondo abitudini.
Insieme alle ricerche svolte in filosofia per i tuoi studi sono cruciali anche quelle condotte in ambito scientifico, in particolare in biologia. Alla luce di questa inclinazione teorica come hai affrontato i temi dell’abito e dell’abitudine?
All’incirca da dieci anni mi occupo di temi che stanno a metà tra le scienze della vita e l’estetica, prima con alcuni lavori di ricostruzione del pensiero estetico darwiniano e più di recente, presso l’Università di Firenze, con un paio di progetti legati al tema dell’estetica della biodiversità e al ruolo della componente estetica nella messa a punto di strategie di tutela delle specie a rischio, in cooperazione con il Dipartimento di Biologia. Anche da questo punto di vista, il concetto di “abitudine” – habit – è cruciale. Gli habits, infatti, svolgono un ruolo di primissimo piano nella fase germinale di costruzione della teoria darwiniana dell’evoluzione per selezione naturale, rappresentando addirittura lo strumento concettuale cui si affida un giovanissimo Charles Darwin per rendere ragione del modificarsi delle specie. In relazione alle ricerche in corso sull’estetica nelle strategie di conservazione, quello che stiamo cercando d’indagare con un gruppo di biologi dell’Ateneo fiorentino è il ruolo degli abiti di apprezzamento estetico nella decisione di tutelare determinate specie animali anziché altre, in condizioni di pari rischio d’estinzione. Il progetto si chiama Unveiling e il case study specifico è costituito dalle 496 specie di farfalle europee; si può contribuire alla raccolta dati attualmente in corso, sottoponendosi a un breve questionario, sul sito www.unveiling.eu. Sembra infatti che, persino a livello di stesura delle red lists internazionali delle specie bisognose di tutela, agisca un bias estetico che contrasta le necessità oggettive di protezione. L’obiettivo, in ogni caso, non è (sol)tanto quello di portare a emergenza eventuali bias estetici determinati quanto piuttosto riflettere sulla pervasività della dimensione estetica nell’esperienza umana in generale del mondo vivente, e mettere in atto strategie efficaci, inclusive e comprensive per progetti di (ri-)educazione estetica in ottica di conservazione biologica e tutela della fauna, della flora e in genere degli ambienti naturali in pericolo.

Polyommatus bellargus
Ridurre la relazione tra abito, abitudine ed estetico a schemi corporei abituali basati su automatismo e ripetizione sarebbe ben poco fruttuoso. In alternativa, quale pensi che sia un approccio teorico promettente?
Non sono mancate, nel corso della riflessione moderna e contemporanea di matrice filosofica e psicologica sugli habits, letture in senso meccanicistico, che hanno fatto delle abitudini un automatismo a fini di economicizzazione delle risorse (cognitive, fisiche, emotive…), del tutto privo di consapevolezza e organizzato secondo stimolo-risposta. Prospettive di questo tipo, com’è chiaro, mal si adattano all’estetico. Nel libro faccio agire una distinzione, funzionale all’argomento ma che tuttavia generalizzerei solo con alcuni distinguo, tra la nozione di abito e quella di abitudine, intendendo con la prima una disposizione salda, incarnata, risultato di pratica e ripetizione ma aperta all’improvvisazione (come suo “alter ego”) e dotata di una pur germinale componente di riflessività; con la seconda, invece, l’abitudine tendenzialmente automatica ed esteriorizzata, in qualche modo nella direzione del nudging o spinta gentile nell’economia comportamentale contemporanea. Questo non significa, si badi, che nel tempo lungo della vita individuale un abito estetico “in senso proprio” non possa irrigidirsi in abitudine o un’abitudine distendersi e fluidificarsi in abito estetico. Il confine tra le due nozioni, pur distinte tra loro, è mobile. Sta qui, credo, quell’ineliminabile doppiezza dell’estetico (la cosiddetta “doppia legge” dell’abito è, sin dal Settecento inglese, l’architrave della riflessione filosofica su questo tema) per cui l’aisthesis è a un tempo promessa di salvezza e minaccia, redenzione possibile e anticipazione della follia del già sentito. Credo che una prospettiva teorica che riesca a tener fede a questa duplicità di sguardo e di natura sull’estetico in quanto abito possa risultare feconda e, in qualche misura almeno, promettente.
Dal punto di vista della sua evoluzione l’attitudine estetica è legata anche a esiti concernenti l’educazione e la formazione degli esseri umani. Quali sono i principali aspetti che pensi siano rilevanti da considerare rispetto a questi due ambiti?
C’è un aspetto di “socialità” necessaria, in abiti e abitudini, che era già ben chiaro ad Aristotele. Come esposto nell’Etica Nicomachea (ad esempio II, 1103b 2-6 e X 9, 1179b 34 ss.), non è possibile dotarsi di buone abitudini da soli, cioè senza che qualcuno mostri il buon esempio con leggi o, almeno, senza un contesto (fisico, sociale, culturale) adeguatamente arrangiato per favorire la fioritura di abitudini. Al netto delle differenze ovvie tra i due domini, lo stesso mi pare valga per l’estetico, il cui sviluppo – ad esempio nei bambini – è strettamente legato all’inserimento in nicchie adeguate, a componente biologica-culturale-sociale. Questo punto comporta, in termini evolutivi, che si possa ipotizzare un legame dell’estetico umano – quanto alla sua prima emergenza specifica all’interno del nostro genere (o precipuamente in Homo sapiens) – con le dinamiche di cura parentale o, più in generale, con le dinamiche sociali all’interno di proto-comunità umane. È quanto ha mostrato l’antropologa evoluzionista Ellen Dissanayake in un ampio sforzo di teorizzazione delle origini “bambine” dell’estetico, a partire dalle interazioni tra infante e caretaker note come baby talk. Pur se la ricerca di Dissanayake resta limitata ai pre-requisiti o alle condizioni di sfondo dell’estetico umano, più che all’estetico in senso proprio, credo che il suo punto di vista offra un contributo importante per l’integrazione degli studi biologico-evoluzionistici, antropologici ed etologici in estetica.
Il concetto di “nicchia di sviluppo” può essere cruciale per rendere ragione dell’emergenza di una capacità estetica nei bambini. Quali sono i principali vantaggi che offre questo concetto dal punto di vista delle formulazioni teoriche sulle origini dell’estetico?
Si tratta di un concetto rilevante proprio nella prospettiva “longitudinale” cui accennavo sopra. La nozione di nicchia, anche con riferimento alla teoria biologico-evoluzionistica della costruzione della nicchia, è mutuato dall’ecologia e dalla teoria evoluzionistica, dove indica il processo attraverso cui un organismo, uomo incluso, apporta delle modifiche all’ambiente in cui vive ed è a sua volta da esse modificato, a vari livelli. Si instaura, detto altrimenti, un loop di feedback per cui l’azione trasformativa dell’organismo (sia in senso fisico-biologico sia, specificamente con gli esseri umani, in senso culturale) ha effetti di ritorno sull’assetto biologico-naturale dell’organismo stesso. Nel caso umano, questo comporta una circolarità virtuosa tra natura e culturale, al limite dell’assottigliarsi o svanire della differenza tra i due. La “nicchia di sviluppo” è una specificazione ulteriore del concetto generale di nicchia e fa riferimento all’ambiente adeguatamente arredato in senso sociale, culturale, fisico che agisce come condizione necessaria per lo sviluppo di una capacità (anche estetica) nei bambini. In questo senso, la nicchia di sviluppo è vicina al concetto di scaffolding o “impalcatura” di sviluppo. In breve, nessuno diventa homo aestheticus da solo, in un ambiente privo di affordances fisico-culturali-sociali, in assenza di una comunità (per quanto minimo) di supporto.
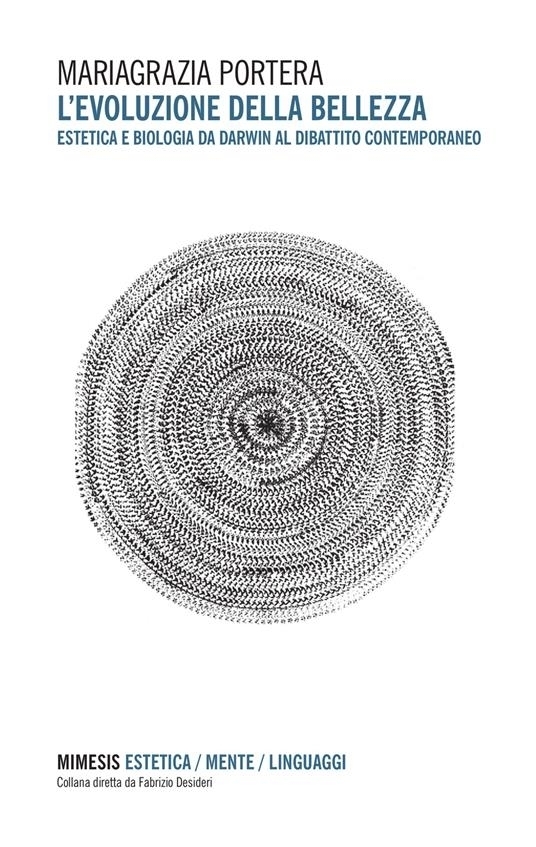
Mariagrazia Portera L’evoluzione della bellezza (Mimesis, Milano Udine 2015)
Un ulteriore prezioso contributo promosso attraverso le ricerche svolte in queste direzioni riguarda l’oggetto estetico. Come si specifica e che relazione ha con l’abito estetico?
Credo che uno dei tratti più interessanti del concetto di abito, in relazione all’estetico, sia il suo posizionarsi su un terreno mediano – o mediale – che dinamicizza la stessa distinzione tra soggetto ed oggetto. È un’ovvietà che l’esperienza estetica non sia riconducibile né esclusivamente al lato soggettivo (come una proiezione del soggetto) né al lato oggettivo (come l’effetto esclusivo di proprietà da esso godute), bensì si collochi nel “tra” che è punto d’incontro di entrambi. L’estetico in quanto abito, così, si sviluppa e si coltiva sia per effetto dell’accumularsi di esperienza dalla parte del soggetto sia per effetto di un attivo agire – agency – dell’oggetto di relazione, entro un orizzonte che persino precede la sedimentazione della distinzione stessa di soggetto e oggetto. Abito è, a un tempo, e traccia sedimentantesi di disposizioni a livello soggettivo e – come rivela l’uso del termine in mineralogia, ad esempio – l’aspetto complessivo di un oggetto-cristallo, cioè la sua immagine o forma, che dipende tanto dalla simmetria del reticolo cristallino tanto dalle condizioni particolari in cui si trova il cristallo durante il suo accrescimento. È importante rilevare, in questo senso, il tratto di mai completa disponibilità per il soggetto “abitualizzato” dell’oggetto con cui è in relazione estetica, a nessun livello della tassonomia e sino al limite della imposizione o assoggettamento. C’è, detto altrimenti, un senso del “subire” l’esperienza estetica prescindendo da quale non si potrebbe neppure rendere ragione del nostro esserne soggetti attivi; questo essere assoggettati e questa passività, alle quali si accede solo dopo aver attivamente coltivato l’abito, ha i tratti di una visitazione – più o meno accentuata – che apre appunto alla non-disponibilità dell’oggetto e non (solo) alla co-implicazione a parità di piano. La cosiddetta “doppia legge dell’abito”, ad esempio in alcune pagine luminose di Félix Ravaisson (ma anche di John Dewey), suggerisce bene questa dinamica a polarità reciproche. Da questo punto di vista, credo che guardare all’abito estetico e all’oggetto estetico come due facce della stessa medaglia possa fornire utili spunti per approfondire ulteriormente, in senso mobile e dinamico, ciò che intendiamo per “esperienza estetica”.
‒ Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati