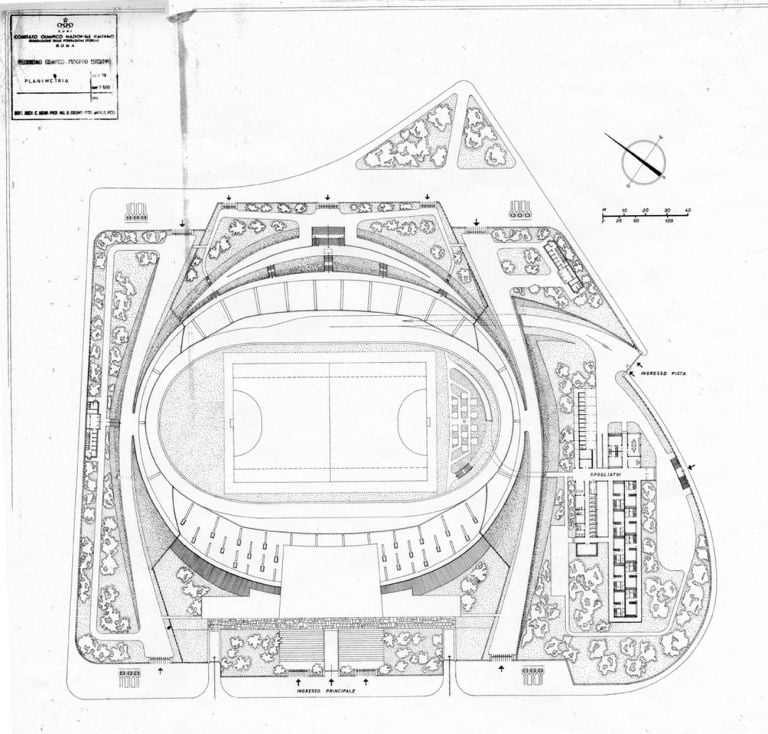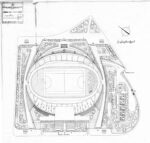Architetti d’Italia. Cesare Ligini, lo sfortunato
Quasi dimenticato dalla critica, Cesare Ligini torna alla ribalta nel racconto di Luigi Prestinenza Puglisi, che ricorda i suoi più ambiziosi progetti architettonici. Fra spinte minimali e input barocchi.

Era stato Renato Nicolini a porre l’attenzione su Cesare Ligini. Ci tornava spesso, per difenderne l’opera nella rubrica che curava nella PresS/Tletter. E anche le volte che lo vedevo trovava sempre un modo di parlare di questo zio di parte materna, insieme agli altri due architetti che avevano dato lustro alla famiglia. Erano il padre, Roberto Nicolini, e uno zio acquisito, Mario De Renzi. La sorella di Cesare Ligini, Ida, aveva infatti sposato Roberto, il padre di Renato, e una cugina, figlia della sorella della nonna, aveva sposato Mario De Renzi.
Nonostante Ligini avesse realizzato edifici di straordinario interesse, il suo nome, nei primi anni del Duemila, era conosciuto da pochi addetti ai lavori. E le due opere principali, costruite a Roma, barbaramente demolite. Nel 2008 era stato abbattuto il Velodromo disegnato in occasione dei giochi olimpici a Roma, considerato il migliore impianto nel suo genere al mondo e, a partire dal concorso per il vicino nuovo Palazzo dei Congressi, se non prima, era iniziato il calvario, con successivi parziali smantellamenti, per le torri del ministero delle Finanze dell’Eur, probabilmente uno dei più interessanti complessi di edifici a destinazione terziaria della Capitale.
CHI ERA CESARE LIGINI
Cesare Ligini appariva come l’architetto segnato da un destino cinico. Più sfortunato di lui, probabilmente, era stato solo Minoru Yamasaki, il progettista autore del complesso residenziale Pruitt-Igoe a St. Louis e delle Torri Gemelle di New York. La demolizione di Pruitt-Igoe, secondo Charles Jencks, aveva sancito la definitiva crisi del Modernismo negli Stati Uniti e l’abbattimento delle Twin Towers la fine dell’euforia degli Anni Novanta. Nel caso di Ligini, l’abbattimento delle sue due opere migliori segnava il momento di peggiore insensibilità nei confronti di una tradizione, quella degli Anni Sessanta, che aveva fatto la fortuna dell’architettura italiana. E, insieme, la damnatio memoriae di un architetto di valore che aveva contribuito, nella Capitale, alla creazione di un mondo che prima o poi, quando cesserà questa moda ecologista, tradizionalista e moralista, dovremo riscoprire.
Cesare Ligini nasce a Roma nel 1913 da Alfredo Ligini ed Enrica Sarrocchi. Il padre si occupa di installazioni in legno per le mostre della Quadriennale e, successivamente, apre una falegnameria. Nel laboratorio paterno Cesare impara le arti della scenografia e dell’allestimento che gli saranno utili per le numerose mostre che curerà durante la carriera professionale. Si laurea nel 1939 e dal 1940 al 1944 è impegnato come ufficiale di artiglieria al fronte. Terminata la guerra, partecipa al concorso per il Monumento ai Caduti delle Fosse Ardeatine con Beniamino Barletti e il cognato Roberto Nicolini. Apre uno studio professionale a via Leccosa con il suo amico e collega Silvano Ricci. Punta ai concorsi banditi in quegli anni per la realizzazione delle opere pubbliche di cui l’Italia ha bisogno. I risultati sono lusinghieri: alcune vittorie e numerose segnalazioni che premiano l’impegno profuso, anche dal punto di vista del disegno ‒ Ligini ha una bella mano. Tra questi ricordiamo il concorso per il cimitero di Prima Porta a Roma (1945), per la Chiesa di sant’Antonio a Recoaro (1948), per l’Ospedale Traumatologico Ortopedico a Roma (1948), per il Quartiere della Fiera del Mare a Taranto (1950-52), per le scuole elementari a 5 aule (1955).
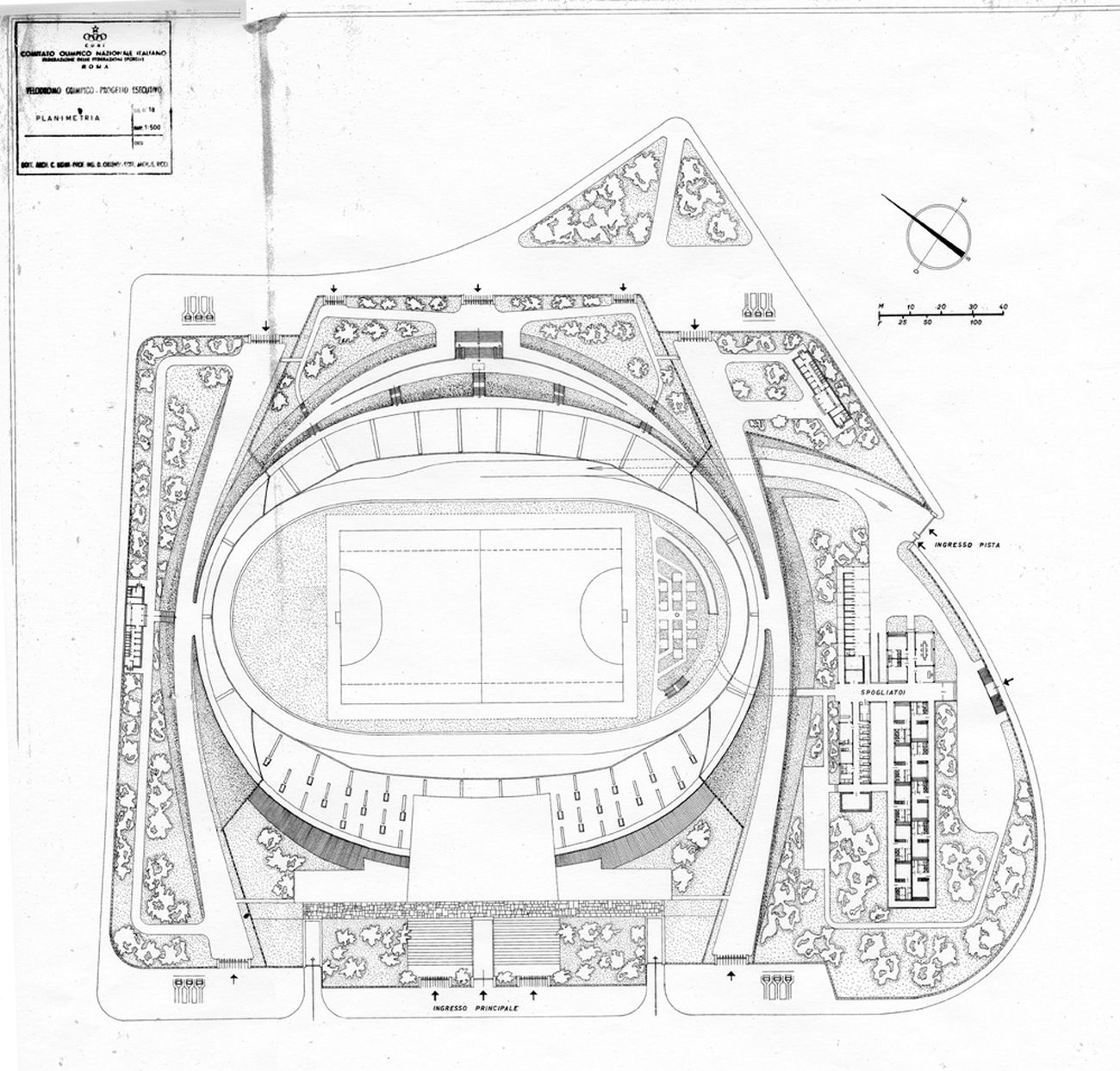
Cesare Ligini, Velodromo Olimpico, Roma, planimetria
IL PROGETTO PER IL VELODROMO DI ROMA
È la vittoria al concorso per il Velodromo per la Capitale, bandito nel 1955 pensando ai Giochi Olimpici del 1960, che lancia lo studio Ligini e Ricci, insieme a Dagoberto Ortensi. Lo stadio per 20.000 spettatori si caratterizza per l’ineccepibile eleganza. Così lo descrive Bruno Zevi in una recensione entusiasta: “Forma chiusa, continua a doppio crescent, ma più sviluppata dalla parte del rettilineo di arrivo”. I progettisti evitano la retorica che punta sui muscoli gonfiati, cioè all’estetica delle strutture in cemento armato. Puntano sulla leggerezza. A partire dalla scelta di edificare le gradinate su collinette artificiali in modo da diminuire l’impatto visivo della struttura rispetto all’intorno. “L’arte” ‒ continua Zevi ‒ “non è mai chiassosa”. Il velodromo si caratterizza inoltre per uno studio meticoloso delle visuali, ottenuto variando, oltre che l’andamento trasversale delle tribune, anche quello longitudinale, in modo da garantire, in ogni punto, la perfetta visuale della pista. Unanime il giudizio della stampa: “Il velodromo più perfetto e più bello del mondo” titola per esempio il Corriere Sportivo del 2 novembre 1958, sottolineando il rapporto unico e indissolubile tra pista e tribune e l’essenzialità complessiva di un edificio fatto di terra e di cemento, perfettamente armonizzato nel paesaggio.
IL CONCORSO PER IL MINISTERO DELLE FINANZE
Nel 1956 Ligini con Amedeo Luccichenti, Pier Luigi Nervi e altri partecipa al concorso per l’Aeroporto di Fiumicino a Roma e, sempre con Dagoberto Ortensi e Silvano Ricci, per la ricostruzione dello Stadio Nazionale a Roma. Ma è nell’anno successivo, il 1957, che vince con Cafiero, Marinucci, Venturi e Boccianti il concorso per il Ministero delle Finanze. Si tratta di tre prismi vetrati e un edificio basso a pianta quadrata tra viale Cristoforo Colombo e viale America ubicati in un lotto di 16.000 metri quadrati. Anche questa opera entusiasma la critica e in primis Bruno Zevi, che scrive un commento estremamente favorevole. Finalmente, sostiene, il linguaggio contemporaneo approda all’Eur. Un organismo perfetto in cui la qualità distributiva coincide con il rigore funzionale. Nota l’influsso miesiano e si sofferma sulla scelta volumetrica che privilegia il vuoto, esistente tra i tre prismi vetrati, sul pieno.
Osservando il Velodromo e il Ministero delle Finanze, potremmo pensare che Ligini si muova all’interno di un’estetica minimalista. In realtà, come molti architetti romani della propria generazione, non esita a sperimentare forme ed etimi tra loro diversi. Comprese suggestioni organiche, espressioniste e barocche. La soluzione ai problemi non passa mai per uno stile preconcetto. E neanche per la rispondenza a parametri parziali. Lo si capisce leggendo uno scritto che dedica all’allora di moda architettura parametrica, dove mostra con dovizia di argomentazioni che proprio applicando parametri matematici considerati inoppugnabili si arriva al disegno di uno stadio completamente inservibile dal punto di vista pratico.

Le Torri Ligini viste dalla vicina stazione della metropolitana EUR Fermi nel 1967. Photo Archivio Paolo Monti
GLI ALTRI PROGETTI DI LIGINI
Introverso e solitario (a differenza del collega e socio Silvano Ricci), Ligini è convinto che ogni edificio sia un caso a sé e che il calcolo matematico e le considerazioni funzionali non bastano a risolvere i problemi dell’architettura. Lo mostra nel concorso per la nuova sede del Palazzo di Giustizia di Lecce (1961-62 con Beniamino Barletti), dove riprende i temi della città barocca corrodendo il sistema assiale e ideando fronti ricoperti da cancellate in ferro battuto, e lo dimostra nel concorso per i nuovi uffici della Camera dei Deputati a Roma (1967), dove realizza un giardino verticale, ottenuto attraverso un sistema di terrazze verdi che negano la chiusura tradizionale di un prospetto chiuso e ben disegnato. Un progetto che anticipa gli edifici verdi di Emilio Ambasz per non parlare delle esperienze recenti di verde verticale. Vi è poi il padiglione per l’Expo di Osaka del 1970, una struttura appesa a due grandi pilastri a forma di I, che fungono da richiamo per il pubblico. Il padiglione, ideato con Vincenzo ed Edoardo Monaco, Alessandro Martini e altri, vince il primo premio al concorso grazie a un ingegnoso sistema di tamponature curve in plexiglas, a un tetto disegnato da Giuseppe Capogrossi, e a un ristorante sospeso, ma viene rifiutato, insieme a quello di Sacripanti, giunto secondo, per presunte difficoltà di realizzazione.
Il progetto che personalmente preferisco di Ligini è la Chiesa a Gela del 1965, una interpretazione in chiave romana delle architetture medioevali e di Antoni Gaudí. Giocata in altezza, si caratterizza per tre pinnacoli visibili dalla campagna sottostante. Decorazioni e giochi di luce innestati su una pianta a matrici curve la avrebbero resa, se realizzata, un’opera indimenticabile. È l’altra anima di Cesare Ligini, surreale e barocca, che l’architetto perseguiva attraverso una attività parallela di pittore.
‒ Luigi Prestinenza Puglisi
LE PUNTATE PRECEDENTI
Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano
Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas
Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri
Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti
Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi
Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini
Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue
Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi
Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti
Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi
Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella
Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini
Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini
Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota
Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari
Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei
Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali
Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey
Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo
Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini
Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti
Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva
Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra
Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia
Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini
Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi
Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi
Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti
Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi
Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini
Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin
Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi
Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co
Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido
Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri
Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi
Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone
Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti
Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli
Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo
Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci
Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci
Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa
Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi
Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca
Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti
Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella
Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta
Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti
Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi
Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola
Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico
Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto
Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni
Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini
Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani
Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni
Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini
Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari
Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino
Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti
Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass
Architetti d’Italia #64 – Franco Albini
Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini
Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini
Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio
Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi
Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri
Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci
Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli
Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo
Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura
Architetti d’Italia #74 ‒ Ugo e Amedeo Luccichenti
Architetti d’Italia #75 – Walter Di Salvo
Architetti d’Italia #76 – Luigi Cosenza
Architetti d’Italia #77 – Lina Bo Bardi
Architetti d’Italia #78 – Adriano Olivetti
Architetti d’Italia #79 – Ernesto Nathan Rogers
Architetti d’Italia #80 – Mario Galvagni
Architetti d’Italia #81 – Ludovico Quaroni
Architetti d’Italia #82 – Adalberto Libera
Architetti d’Italia #83 – Vittoriano Viganò
Architetti d’Italia #84 – Cesare Leonardi
Architetti d’Italia #85 – Leonardo Savioli
Architetti d’Italia #86 – Giuseppe Vaccaro
Architetti d’Italia #87 – Eugenio Gentili Tedeschi
Architetti d’Italia #88 – Luigi Figini e Gino Pollini
Architetti d’Italia #89 – Mario Ridolfi
Architetti d’Italia #90 – Giuseppe Samonà
Architetti d’Italia #91 – Giorgio Grassi
Architetti d’Italia #92 – Riccardo Morandi
Architetti d’Italia #93 – Giuseppe Pagano
Architetti d’Italia #94 – Luigi Caccia Dominioni
Architetti d’Italia #95 – Vittorio Mazzucconi
Architetti d’Italia #96 – Pier Luigi Nervi
Architetti d’Italia #97 – Paolo Riani
Architetti d’Italia #98 –Giuseppe Perugini e Uga de Plaisant
Architetti d’Italia #99 ‒ Francesco Palpacelli
Architetti d’Italia #100 ‒ Carlo Melograni
Architetti d’Italia #101 – Gabetti e Isola
Architetti d’Italia #102 – Alvaro Ciaramaglia
Architetti d’Italia #103 – Gianfranco Franchini
Architetti d’Italia #104 – Carlo Aymonino
Architetti d’Italia #105 ‒ Giovanni Klaus Koenig
Architetti d’Italia #106 – Sandro Lazier
Architetti d’Italia #107 – Giovanni Muzio
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati