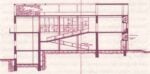Architetti d’Italia. Ugo e Amedeo Luccichenti, i rimossi
La loro architettura è stata dimenticata e rimossa, ma Luigi Prestinenza Puglisi riporta all’attenzione il lavoro dei fratelli Luccichenti.

Tra i dimenticati dell’architettura italiana primeggiano i fratelli Luccichenti: Ugo e Amedeo. Di loro, nel momento in cui scrivo, non esiste una voce Wikipedia. C’è qualche accenno su Amedeo, il più giovane dei due, nel profilo dedicato a Vincenzo Monaco che fu il suo socio. Ma si tratta di informazioni povere e frammentarie.
La critica, tanto prodiga con architetti potenti e mediocri, ai Luccichenti, che erano bravi anzi bravissimi, non perdonò nulla. Il verdetto inappellabile: palazzinari. Con l’aggravante che Ugo a Roma era stato l’autore dell’albergo Hilton a Montemario, contro il quale Antonio Cederna aveva condotto una furiosa polemica culminata con azioni giudiziarie. E Amedeo era stato uno degli architetti prediletti dalla Democrazia Cristiana e dal Presidente della Repubblica, Giovanni Gronchi, i quali pare avessero ottenuto per lui e il socio importanti commissioni di opere pubbliche tra cui il palazzo di rappresentanza nella tenuta presidenziale di San Rossore, i lavori in concomitanza con la XVII Olimpiade a Roma e l’aeroporto di Fiumicino. Vi era infine la macchia della realizzazione nel 1938, da parte dei giovanissimi ‒ uno aveva 27 anni e l’altro 31‒ Vincenzo Monaco e Amedeo Luccichenti, della villa Petacci: la casa della famiglia dell’amante di Mussolini con una alcova destinata ai due. Pazienza che fosse una costruzione di grande interesse, uno dei testi migliori del razionalismo italiano. Su essa doveva cadere una invalicabile cortina di silenzio, sia per l’imbarazzo che produceva ai fascisti bigotti pubblicizzare la casa dell’amante del Duce, che per il successivo tabù antifascista di elogiare un’opera politicamente compromettente.
Anche durante la ricostruzione, davanti ad altre opere, edifici residenziali tra i migliori prodotti in Italia, l’imbarazzo non è venuto meno. Ho tra le mani alcune pagine di un articolo cauto e dubbioso dedicato a Ugo sul numero 15 del gennaio 1957 de L’architettura. Cronache e storia, a firma di Beata di Gaddo: “Il panorama delle opere che vedete nella pagina a sinistra costituisce una chiara presentazione del mondo in cui Luccichenti opera e della clientela che serve. Dimostra anche il raggio del suo linguaggio, e i limiti di esso”. E come se non bastasse, a mettere le mani avanti, è il titolo: Opere di Ugo Luccichenti, professionista romano. Professionista e non poeta. Romano per delimitare ed evitare un riconoscimento su scala nazionale. Eppure, la produzione di Ugo e Amedeo ancora oggi ci racconta il livello di qualità della architettura in Italia tra gli Anni Cinquanta e i Settanta.

Amedeo Luccichenti & Vincenzo Monaco, Palazzina in Via Salaria, Roma
PERSONALITÀ DIVERSE
I due fratelli Luccichenti non lavorarono mai insieme. Probabilmente per la differenza di età. Otto anni: Ugo era nato nel 1899 e Amedeo nel 1907. O forse per un’indole diversa, come può capitare. Ugo era un temperamento artisticamente solitario: preciso e poco incline a delegare, tanto che i progetti, dall’impostazione di massima al dettaglio esecutivo, preferiva disegnarli lui stesso. Amedeo credeva nel lavoro di squadra e lo dimostra il fatto che lavorerà per tutta la vita con il socio Monaco all’interno di uno studio professionale gestito con moderni criteri organizzativi.
Ugo parte lentamente con opere non diverse dalle costruzioni residenziali che si realizzavano in quegli anni nella Capitale. Volumi solidamente strutturati, senza colpi di coda. Occorrerà aspettare gli Anni Quaranta per un capolavoro: la palazzina a Piazzale delle Muse. Un edificio, oltremodo sobrio con un taglio classico ineccepibile, disegnato attraverso grandi vetrate che si alternano a esili pilastri incorniciati da lunghi balconi per dare alla costruzione un aspetto insieme solido e leggero. La sperimentazione con le forme del Movimento Moderno, in particolare con elementi ripresi dal repertorio purista, si sviluppa nel dopoguerra. Ugo costruisce e sforbicia le facciate, prova a inserirvi colori, gioca con le strutture sino a prospettare soluzioni ardite. Di formazione ingegnere, probabilmente è lui stesso che le calcola. Del resto, come dicevamo, è un perfezionista. Vuole avere il controllo completo del progetto e presenta ai costruttori disegni pensati in ogni dettaglio, per evitare che possano essere compromessi in fase di esecuzione. Dirà, un po’ scherzando e molto sul serio, che ha istituito il premio di una medaglia d’oro per l’impresa “che meglio riesce a eseguire un’opera senza nulla alterare con un procedimento che, cifre alla mano, si dimostra più conveniente anche sotto il profilo economico”. E difatti le costruzioni realizzate da Ugo, e sono moltissime, sono tutte straordinariamente sensate e razionali. Lontane dal gusto dell’arte per l’arte che la critica a lui contraria gli ha voluto appiccicare addosso, passandolo come un architetto eccentrico e disimpegnato, teso a titillare con stramberie il gusto decadente della borghesia romana.
La vicenda che lo scuote profondamente è probabilmente la sofferta realizzazione dell’Hotel Cavalieri Hilton. Certo è che, a partire da quegli anni, la produzione di Luccichenti rallenta e l’interesse dell’architetto si focalizza sull’arte ‒ è stato un discreto pittore ‒ e sulla realizzazione di opere di minore dimensione, soprattutto ville per gli amici. Attraverso le quali si muove sempre più decisamente lungo la sperimentazione spaziale e dei materiali. Si tratta di ville in cui non viene mai meno il controllo del budget, dei metri quadrati, dei dettagli. In cui si provano soluzioni che oggi definiremo antesignane se non d’avanguardia, come tetti in paglia.

Ugo Luccichenti, Piazzale delle Medaglie d’Oro, Belsito. Photo Carlo Ragaglini
DA VILLA PETACCI ALL’HOTEL JOLLY
Amedeo, come dicevamo, ha un carattere diverso. Lo si capisce dal fatto che la sua prima opera importante, eseguita con il socio Monaco, è una costruzione, villa Petacci, che oggi definiremo alla moda. Una realizzazione sicuramente sorprendente che ci fa pensare che il Duce, che certo già prima della realizzazione non doveva essere all’oscuro delle idee dei progettisti, avesse nei riguardi dell’architettura moderna un’apertura forse ancora maggiore di quella che gli è stata attribuita. La casa, non priva di ingenuità, di elementi fuori scala e di qualche pacchianeria, in linea con il carattere sia dei Petacci che di Mussolini, è comunque una tra le opere moderne migliori che si realizzano in quegli anni a Roma. Nel dopoguerra Monaco e Luccichenti si dedicano anch’essi alla realizzazione di palazzine di sapore post purista. Le loro opere si distinguono da quelle di Ugo per un approccio più elegante e più disimpegnato. Sicuramente meno sofferto. I due hanno una maggiore propensione a seguire le mode, anche se sempre a un livello elevato e, direi, anche anticipandole. Villa Gombo nella tenuta di San Rossore è, a mio avviso, un capolavoro, a partire dalla intelligente idea di staccarla dal terreno sospendendola su esili pilastri che, allo stesso tempo, delimitano una virtuale corte interna. L’apertura dello studio ai molteplici linguaggi dell’Italia della ricostruzione permette le più diverse e riuscite collaborazioni: per esempio nella realizzazione del villaggio Olimpico a Roma, un’opera a mio parere insuperata proprio perché è stato il felice frutto di una collaborazione a più mani di bravi architetti (oltre a Monaco e Luccichenti, Adalberto Libera, Luigi Moretti, Vittorio Cafiero).
Vi è poi uno dei più begli edifici della Capitale: l’Hotel Jolly in Corso Italia (1968-1971), caratterizzato dagli eleganti brise soleil in ferro. Segno di come lo studio sapesse guardare a quanto di meglio si realizzava fuori dai confini italiani. In particolare da parte della scuola di Eero Saarineen con gli edifici della John Deere World Headquarters. Ricordo ancora che stavo all’università quando il professore di materiali ci proiettò le diapositive del Jolly di Monaco e Luccichenti e dell’edificio a Piazza Cola di Rienzo di Alvaro Ciaramaglia (un altro grande progettista rimosso e dimenticato), citandoli come esempi di cattiva architettura e di pessimo uso dei materiali. A me, devo dire, questi edifici sembrano ancora bellissimi. E con il passare degli anni ne ho sempre più conferma.
P.S. Devo ringraziare Carlo Ragaglini per alcune preziose informazioni su Ugo Luccichenti avute per telefono e dalla lettura di una pagina Facebook da lui curata. Per chi voglia approfondire la coppia Monaco Luccichenti rimando all’eccellente libro di Paolo Melis edito da Electa.
‒ Luigi Prestinenza Puglisi
LE PUNTATE PRECEDENTI
Architetti d’Italia #1 – Renzo Piano
Architetti d’Italia #2 – Massimiliano Fuksas
Architetti d’Italia #3 – Stefano Boeri
Architetti d’Italia #4 – Marco Casamonti
Architetti d’Italia #5 – Cino Zucchi
Architetti d’Italia#6 – Maria Giuseppina Grasso Cannizzo
Architetti d’Italia#7 – Adolfo Natalini
Architetti d’Italia#8 – Benedetta Tagliabue
Architetti d’Italia#9 – Michele De Lucchi
Architetti d’Italia#10 – Vittorio Gregotti
Architetti d’Italia#11 – Paolo Portoghesi
Architetti d’Italia#12 – Mario Cucinella
Architetti d’Italia #13 ‒ Mario Bellini
Architetti d’Italia #14 ‒ Franco Purini
Architetti d’Italia #15 ‒ Italo Rota
Architetti d’Italia #16 ‒ Franco Zagari
Architetti d’Italia #17 ‒ Guendalina Salimei
Architetti d’Italia #18 ‒ Guido Canali
Architetti d’Italia #19 ‒ Teresa Sapey
Architetti d’Italia #20 ‒ Gianluca Peluffo
Architetti d’Italia #21 ‒ Alessandro Mendini
Architetti d’Italia #22 ‒ Carlo Ratti
Architetti d’Italia #23 ‒ Umberto Riva
Architetti d’Italia #24 ‒ Massimo Pica Ciamarra
Architetti d’Italia #25 ‒ Francesco Venezia
Architetti d’Italia #26 ‒ Dante Benini
Architetti d’Italia #27 ‒ Sergio Bianchi
Architetti d’Italia #28 ‒ Bruno Zevi
Architetti d’Italia #29 ‒ Stefano Pujatti
Architetti d’Italia #30 ‒ Aldo Rossi
Architetti d’Italia #31 ‒ Renato Nicolini
Architetti d’Italia #32 ‒ Luigi Pellegrin
Architetti d’Italia #33 ‒ Studio Nemesi
Architetti d’Italia #34 ‒ Francesco Dal Co
Architetti d’Italia #35 ‒ Marcello Guido
Architetti d’Italia #36 ‒ Manfredo Tafuri
Architetti d’Italia #37 ‒ Aldo Loris Rossi
Architetti d’Italia #38 ‒ Giacomo Leone
Architetti d’Italia #39 ‒ Gae Aulenti
Architetti d’Italia #40 ‒ Andrea Bartoli
Architetti d’Italia#41 ‒ Giancarlo De Carlo
Architetti d’Italia #42 ‒ Leonardo Ricci
Architetti d’Italia #43 ‒ Sergio Musmeci
Architetti d’Italia #44 ‒ Carlo Scarpa
Architetti d’Italia #45 ‒ Alessandro Anselmi
Architetti d’Italia #46 ‒ Orazio La Monaca
Architetti d’Italia #47 ‒ Luigi Moretti
Architetti d’Italia #48 ‒ Ignazio Gardella
Architetti d’Italia #49 ‒ Maurizio Carta
Architetti d’Italia #50 ‒ Gio Ponti
Architetti d’Italia #51 ‒ Vittorio Sgarbi
Architetti d’Italia #52 ‒ Fabrizio Carola
Architetti d’Italia #53 ‒ Edoardo Persico
Architetti d’Italia #54 ‒ Alberto Cecchetto
Architetti d’Italia #55 ‒ Fratelli Castiglioni
Architetti d’Italia #56 ‒ Marcello Piacentini
Architetti d’Italia #57 ‒ Massimo Mariani
Architetti d’Italia #58 – Giuseppe Terragni
Architetti d’Italia #59 – Vittorio Giorgini
Architetti d’Italia #60 – Massimo Cacciari
Architetti d’Italia #61 – Carlo Mollino
Architetti d’Italia #62 – Maurizio Sacripanti
Architetti d’Italia #63 – Ettore Sottsass
Architetti d’Italia #64 – Franco Albini
Architetti d’Italia #65 – Armando Brasini
Architetti d’Italia #66 – Camillo Botticini
Architetti d’Italia #67 – Antonio Citterio
Architetti d’Italia # 68 – Oreste Martelli Castaldi
Architetti d’Italia #69 – Paolo Soleri
Architetti d’Italia #70 – Giovanni Michelucci
Architetti d’Italia #71 – Lucio Passarelli
Architetti d’Italia #72 – Marcello d’Olivo
Architetti d’Italia #73 – Venturino Ventura
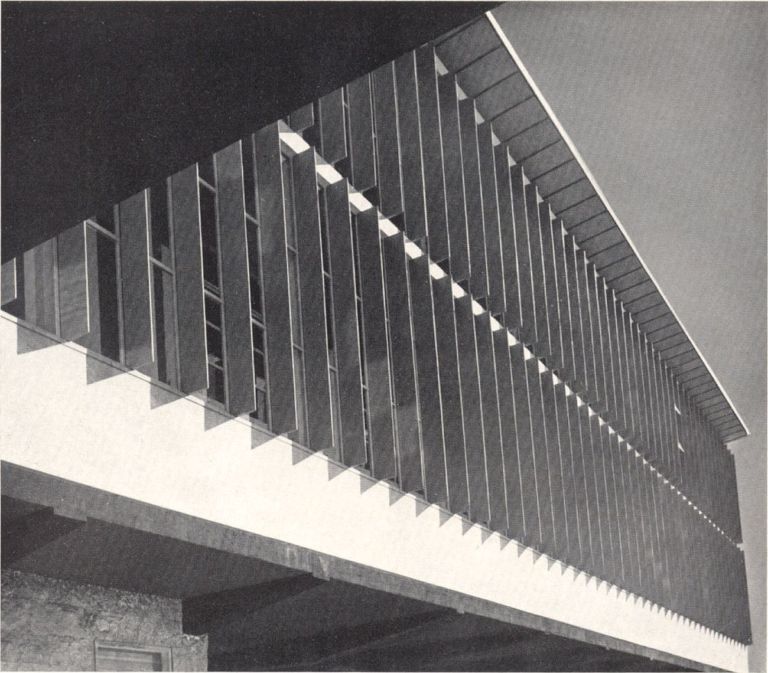 1 / 56
1 / 56
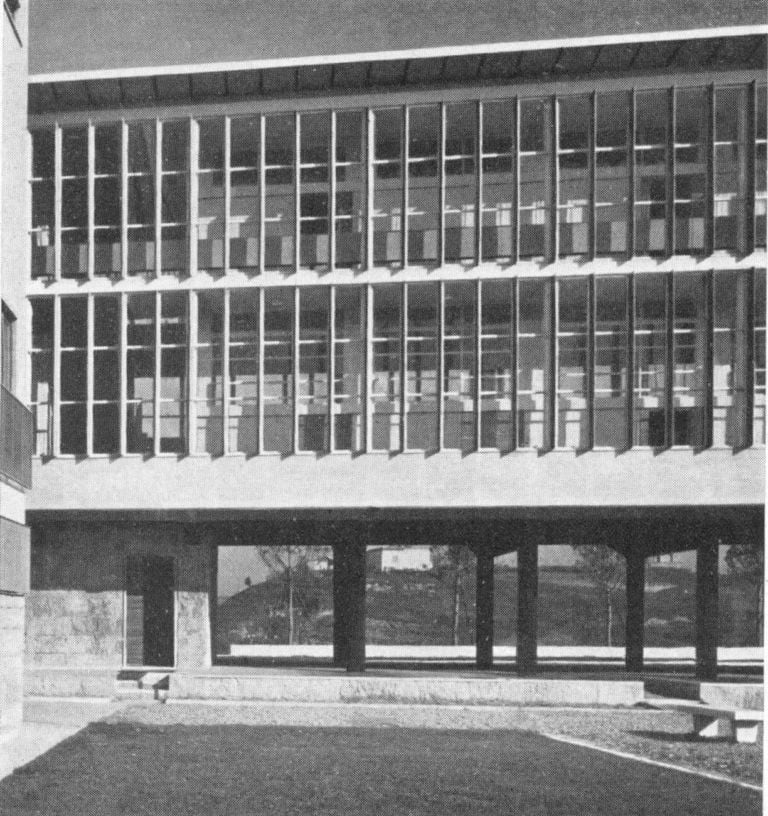 2 / 56
2 / 56
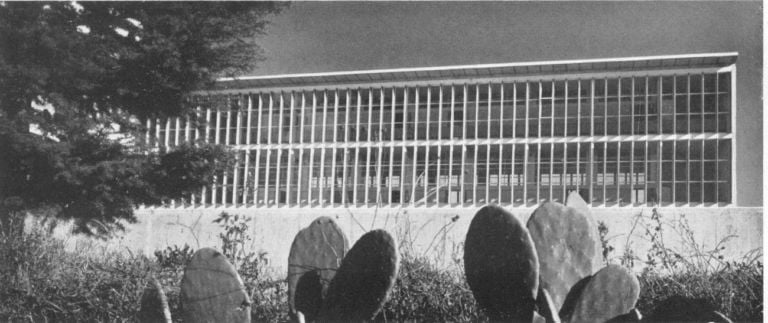 3 / 56
3 / 56
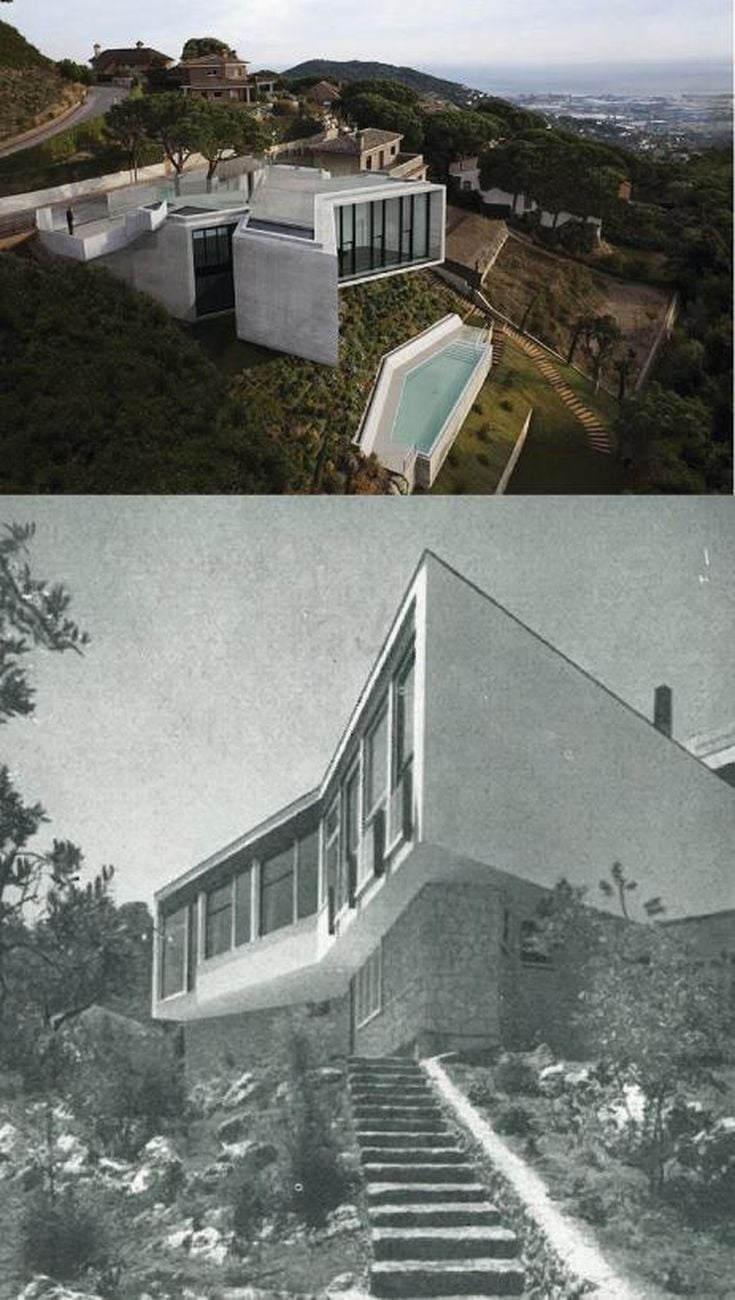 4 / 56
4 / 56
 5 / 56
5 / 56
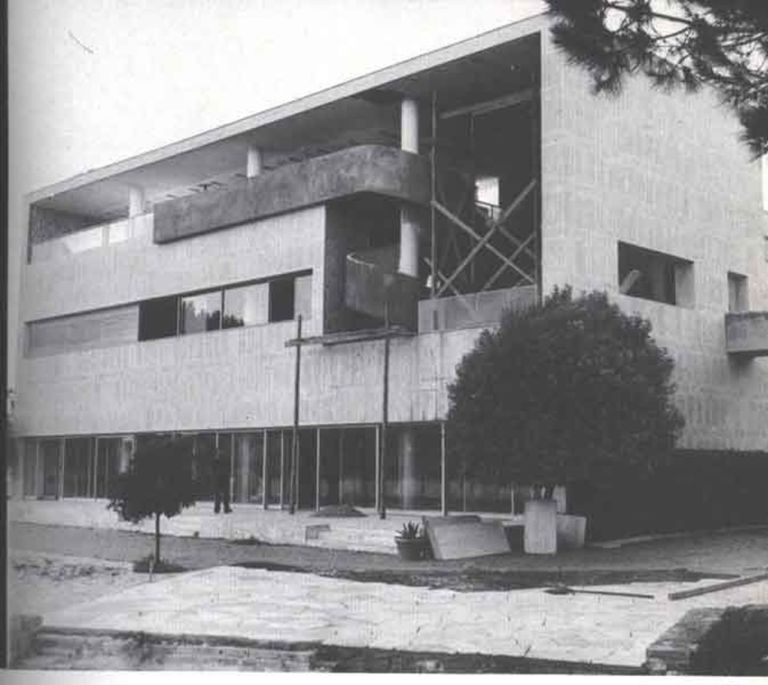 6 / 56
6 / 56
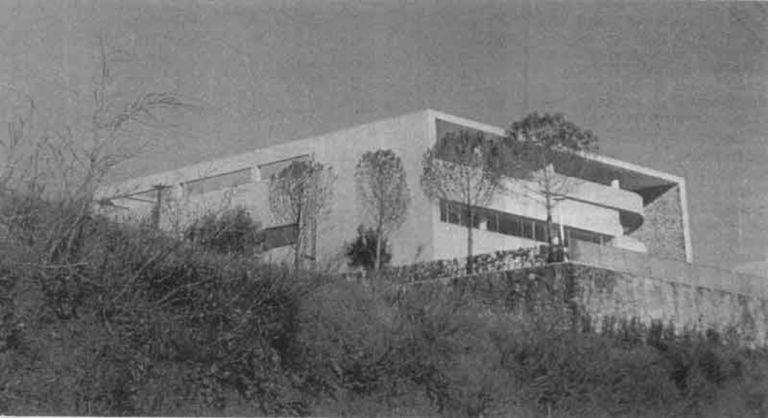 7 / 56
7 / 56
 8 / 56
8 / 56
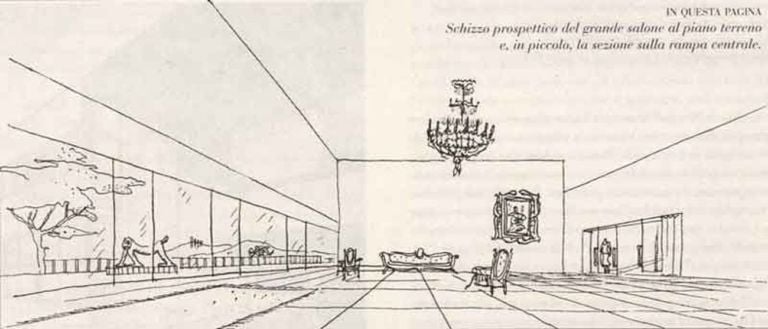 9 / 56
9 / 56
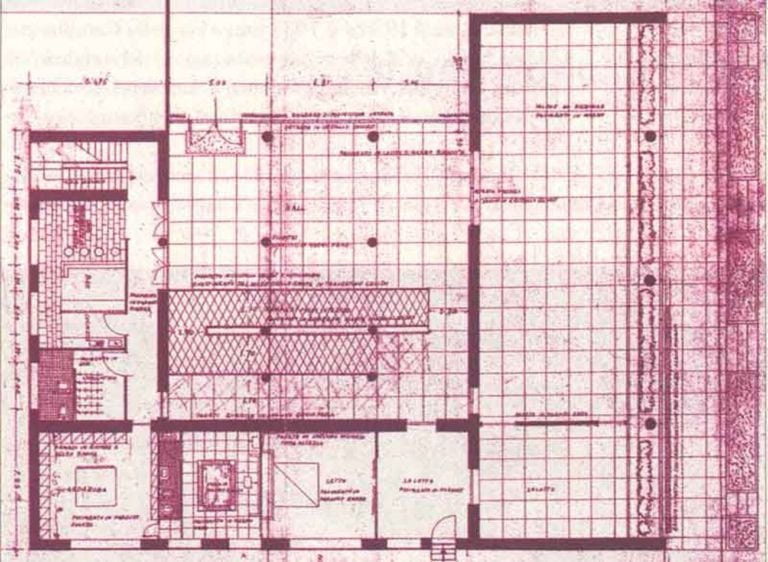 10 / 56
10 / 56
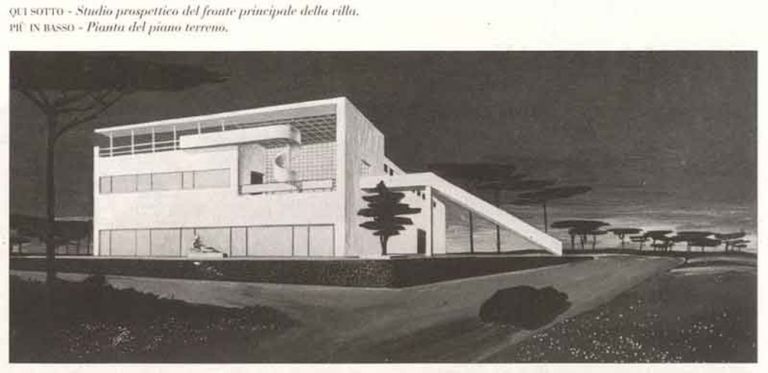 11 / 56
11 / 56
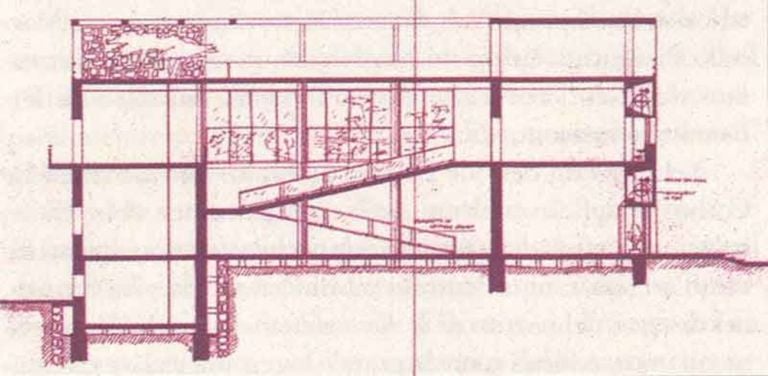 12 / 56
12 / 56
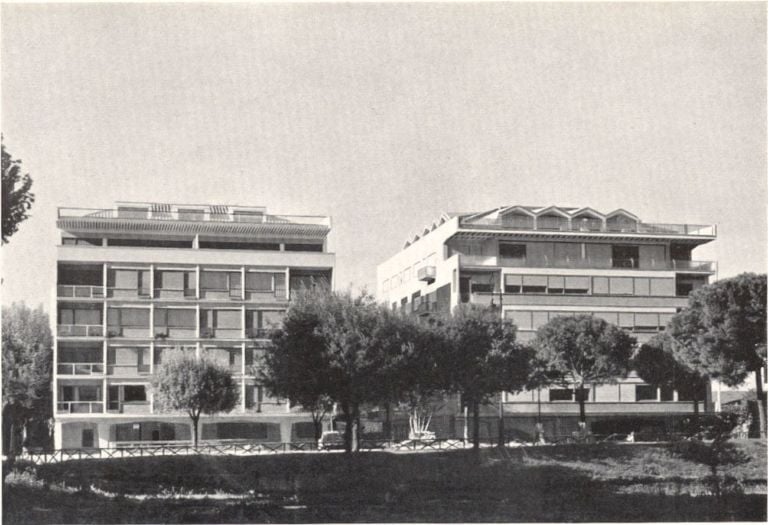 13 / 56
13 / 56
 14 / 56
14 / 56
 15 / 56
15 / 56
 16 / 56
16 / 56
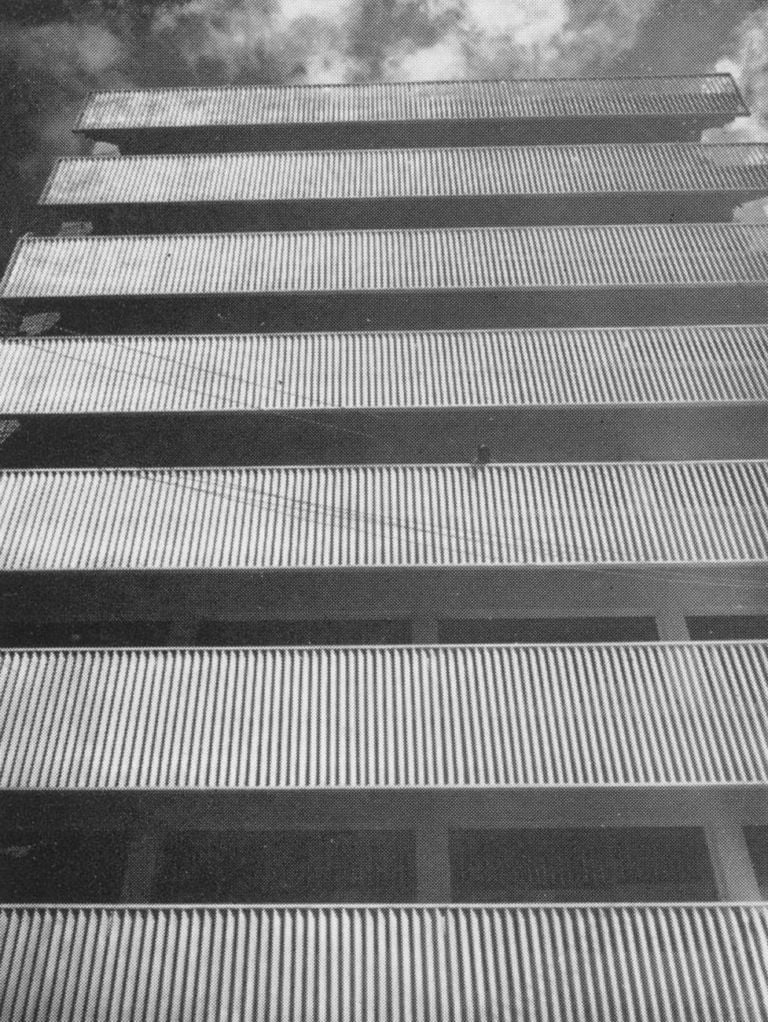 17 / 56
17 / 56
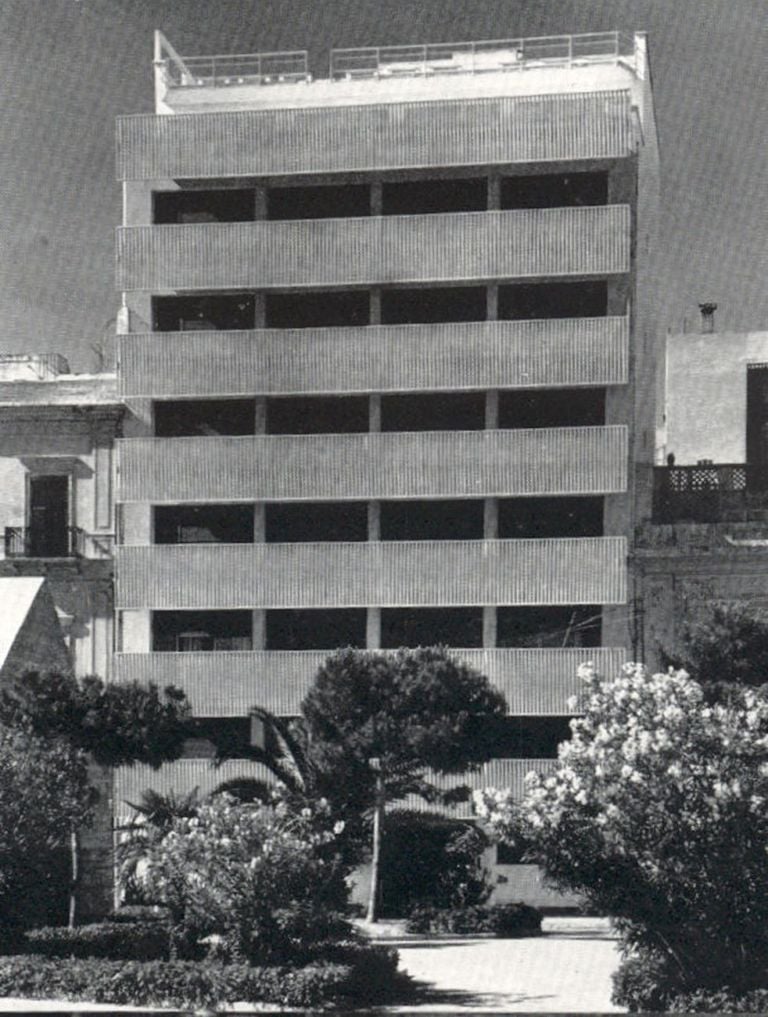 18 / 56
18 / 56
 19 / 56
19 / 56
 20 / 56
20 / 56
 21 / 56
21 / 56
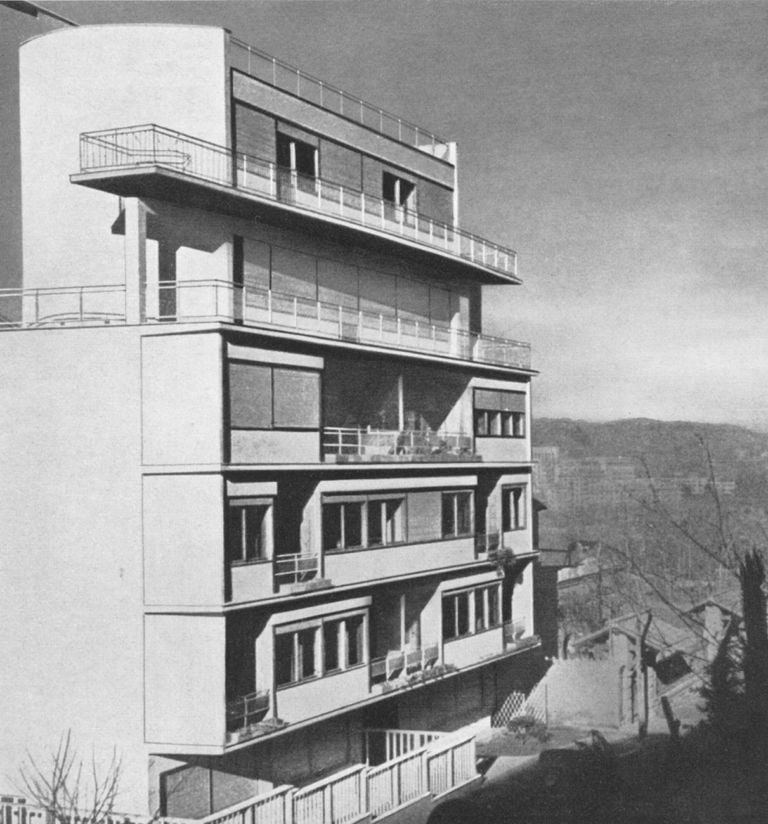 22 / 56
22 / 56
 23 / 56
23 / 56
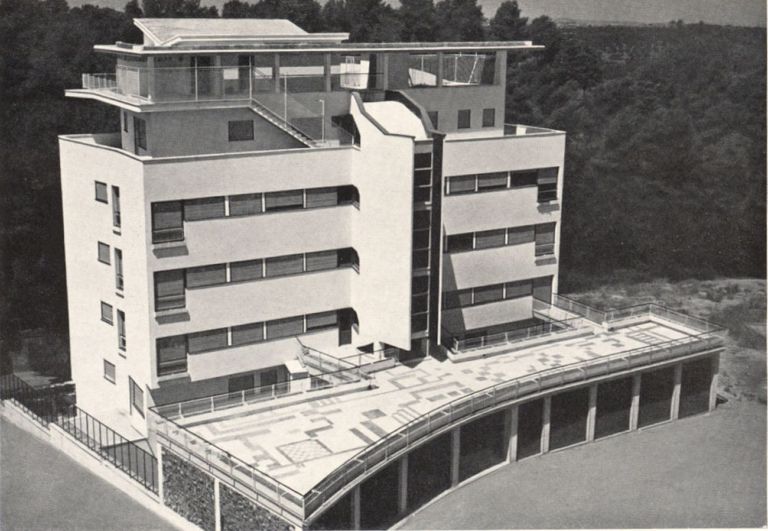 24 / 56
24 / 56
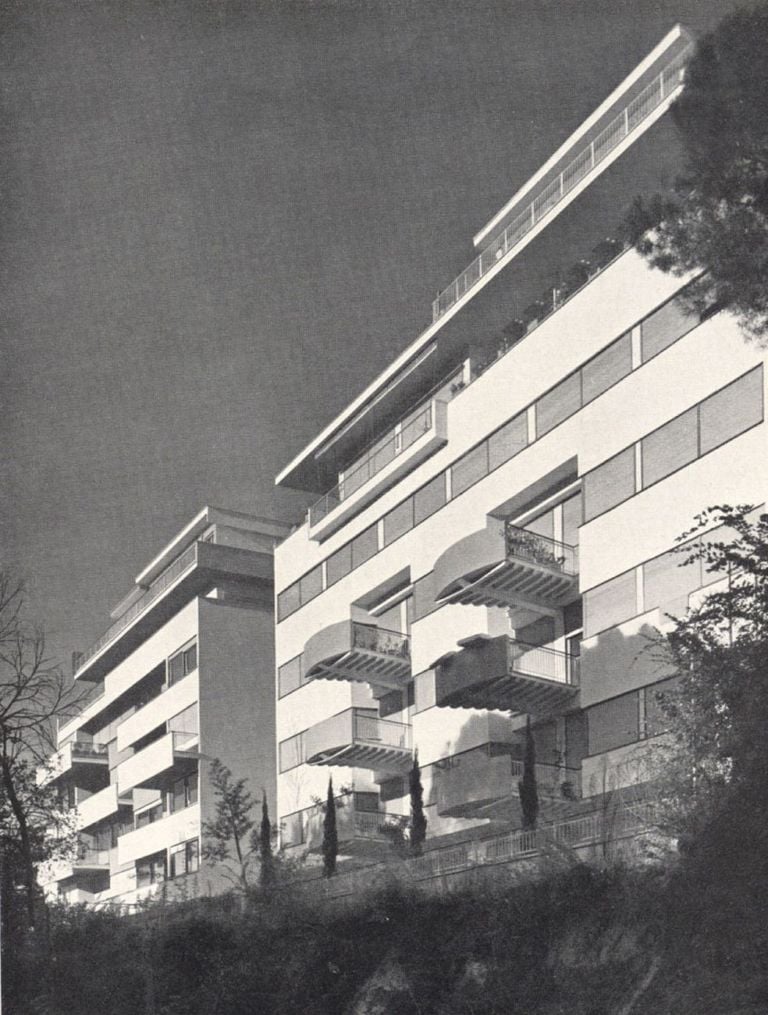 25 / 56
25 / 56
 26 / 56
26 / 56
 27 / 56
27 / 56
 28 / 56
28 / 56
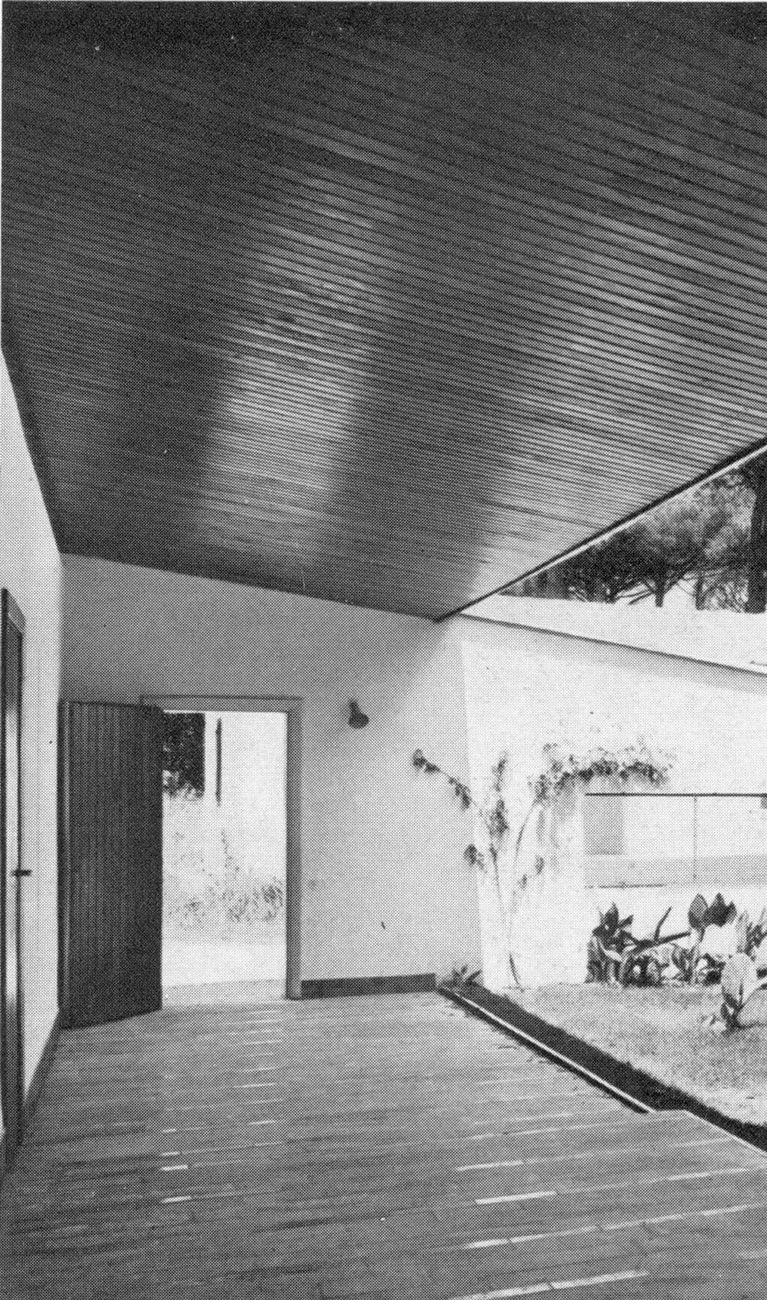 29 / 56
29 / 56
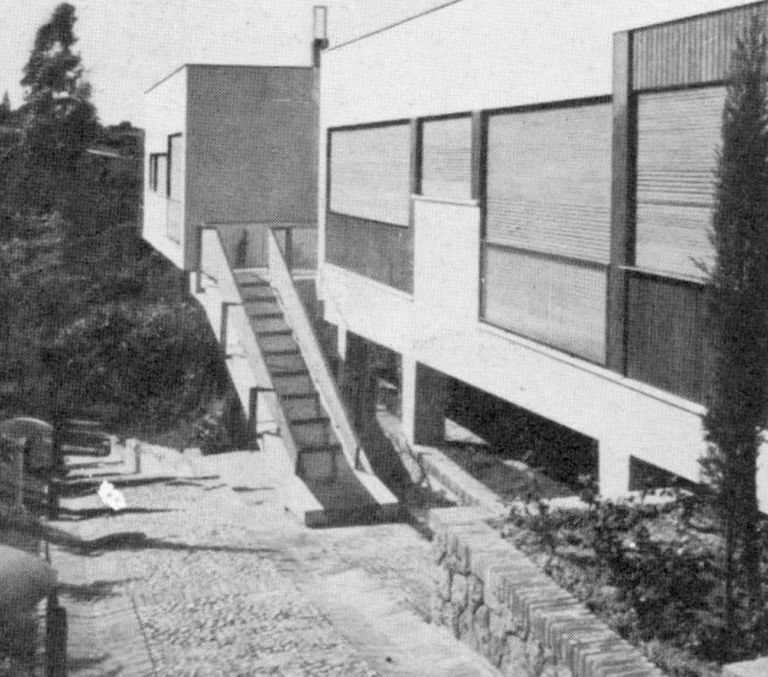 30 / 56
30 / 56
 31 / 56
31 / 56
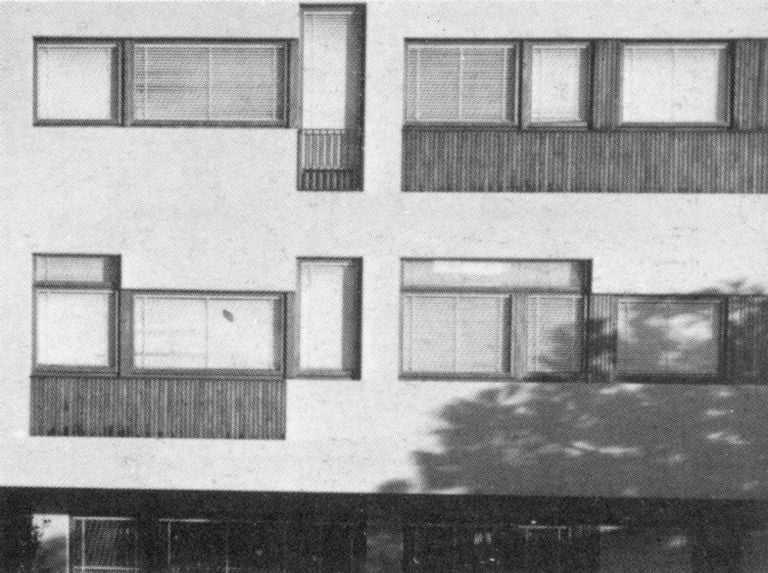 32 / 56
32 / 56
 33 / 56
33 / 56
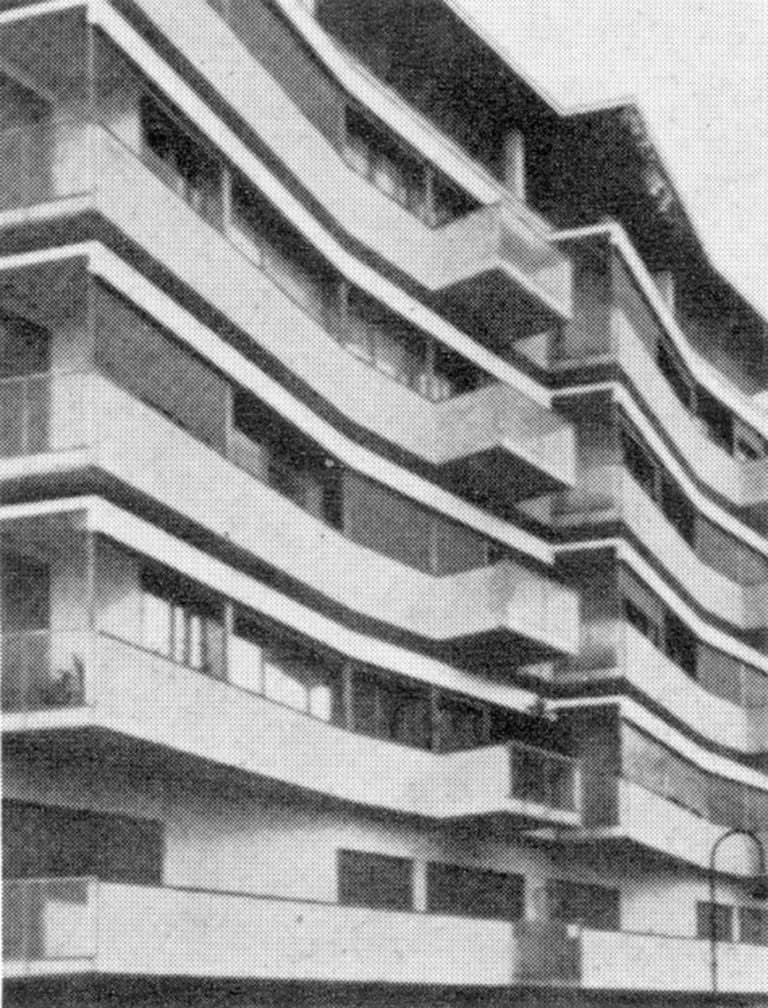 34 / 56
34 / 56
 35 / 56
35 / 56
 36 / 56
36 / 56
 37 / 56
37 / 56
 38 / 56
38 / 56
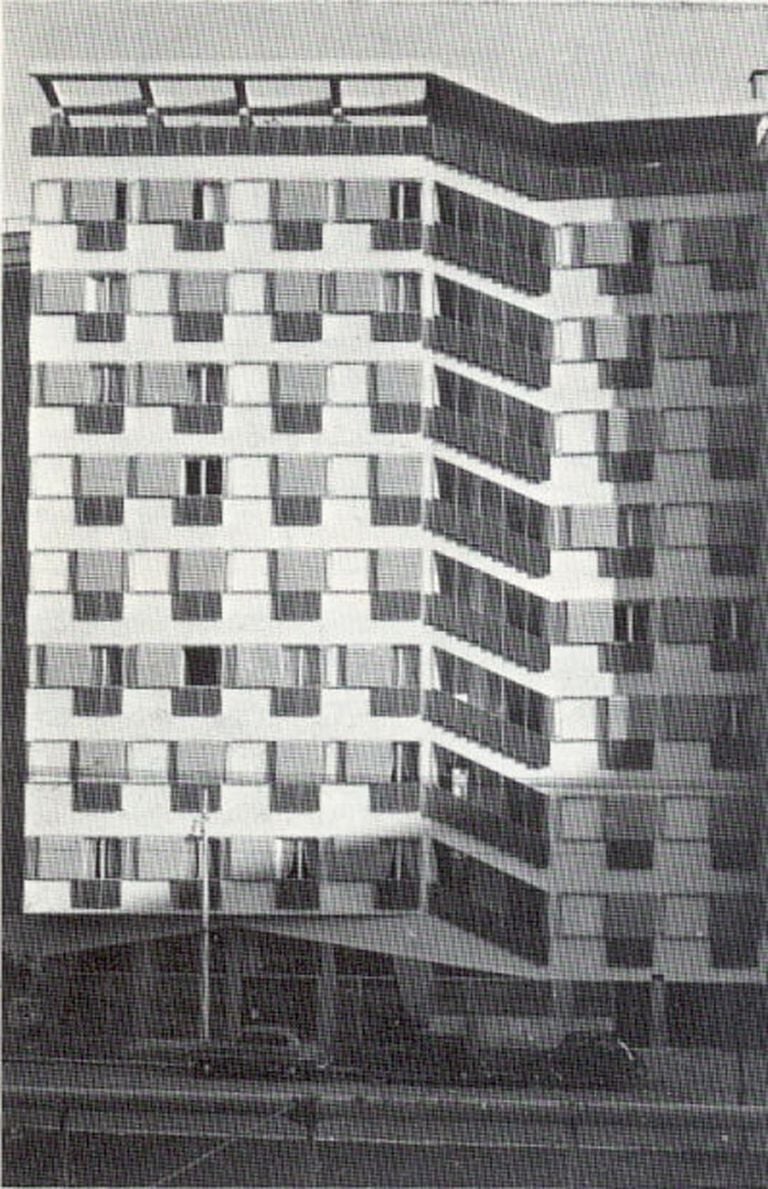 39 / 56
39 / 56
 40 / 56
40 / 56
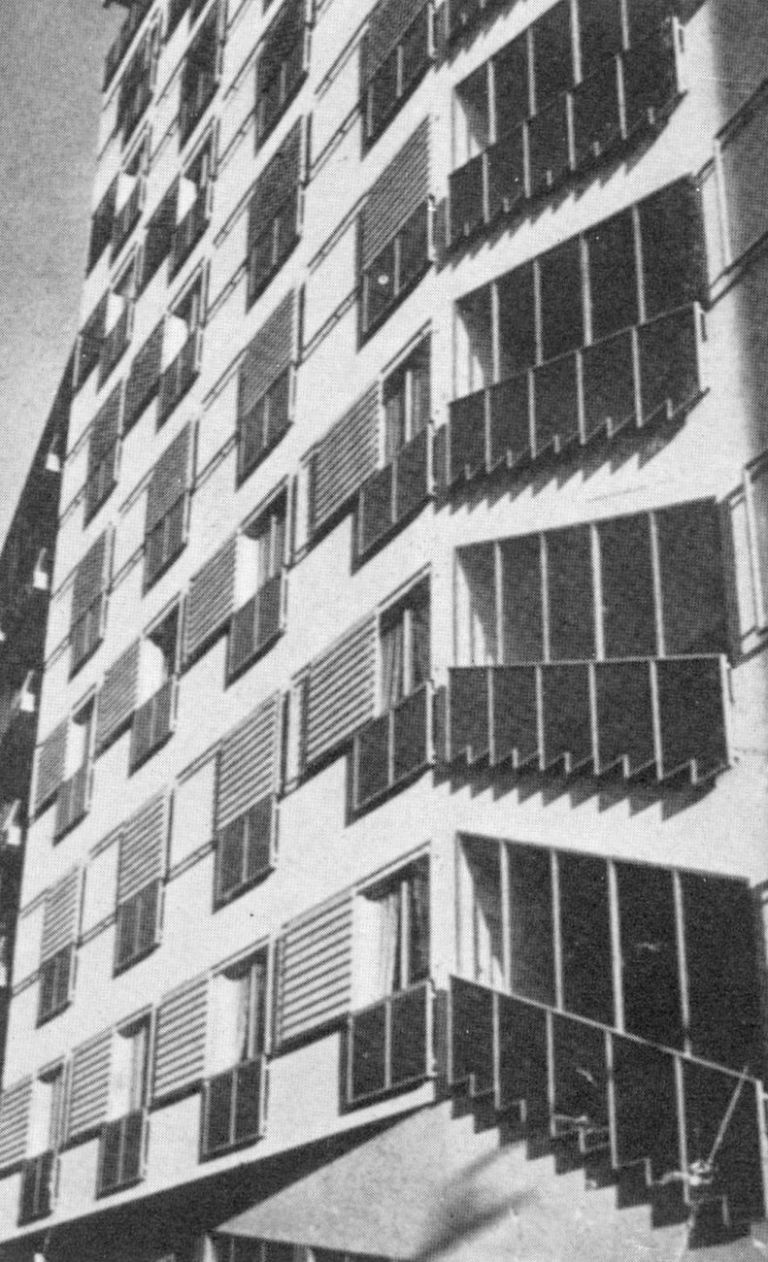 41 / 56
41 / 56
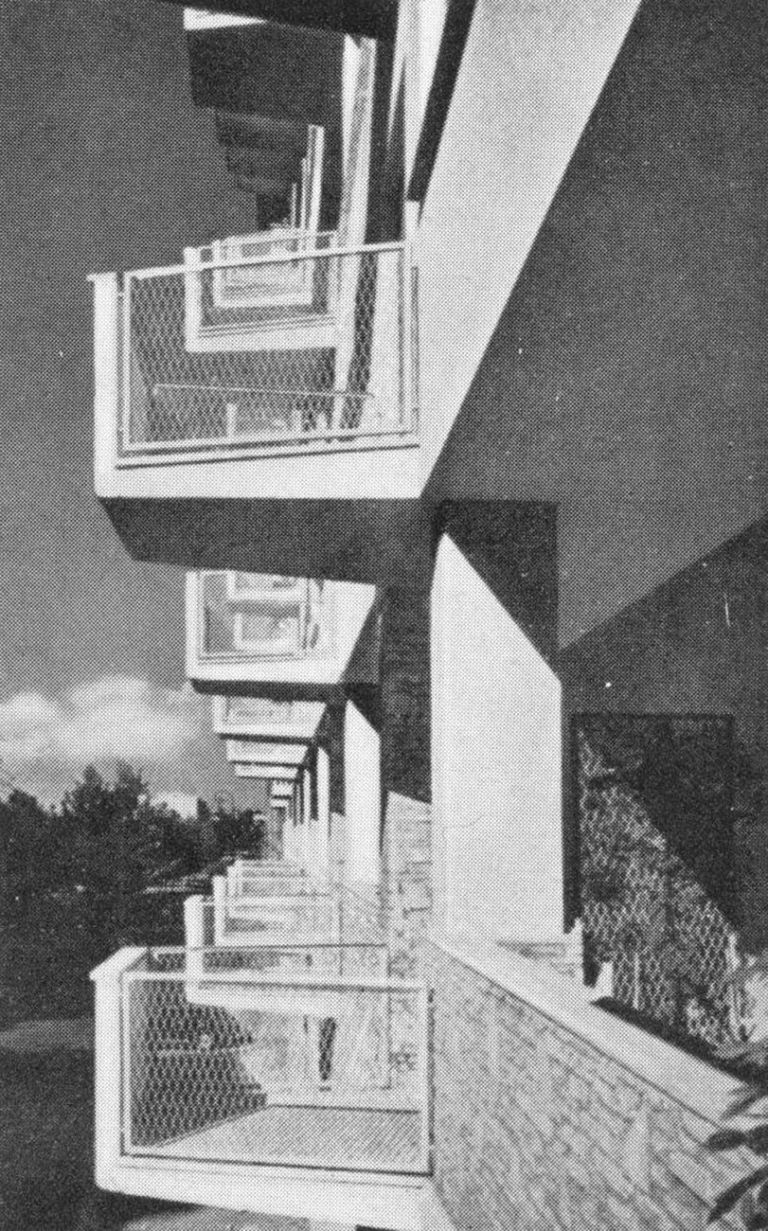 42 / 56
42 / 56
 43 / 56
43 / 56
 44 / 56
44 / 56
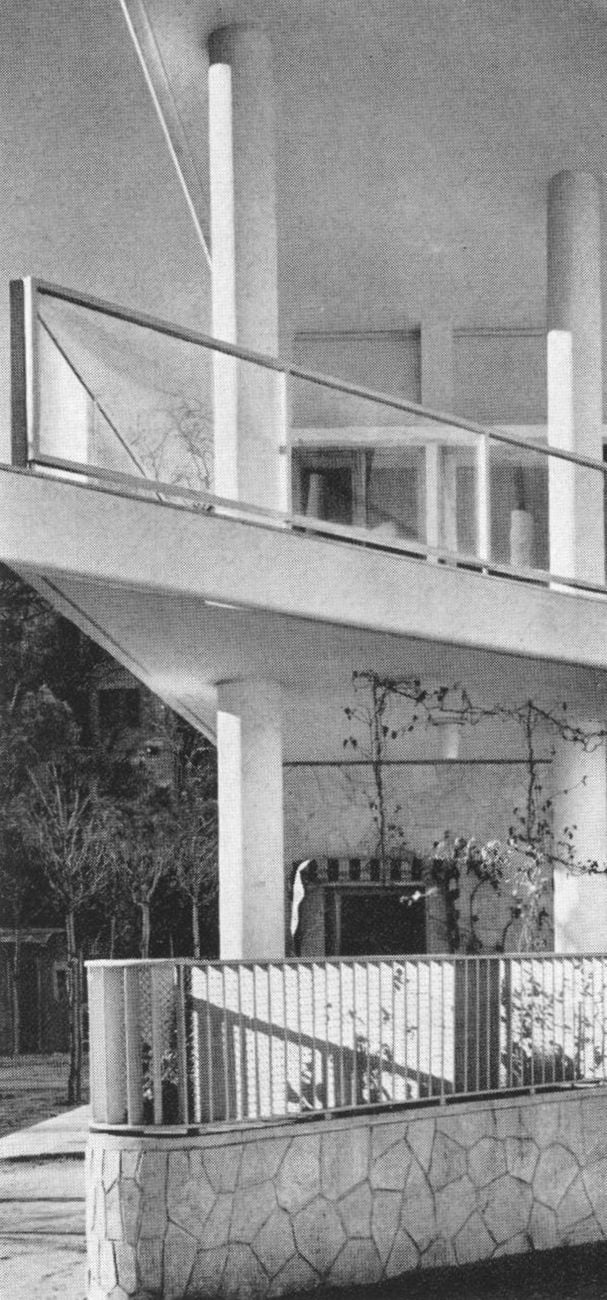 45 / 56
45 / 56
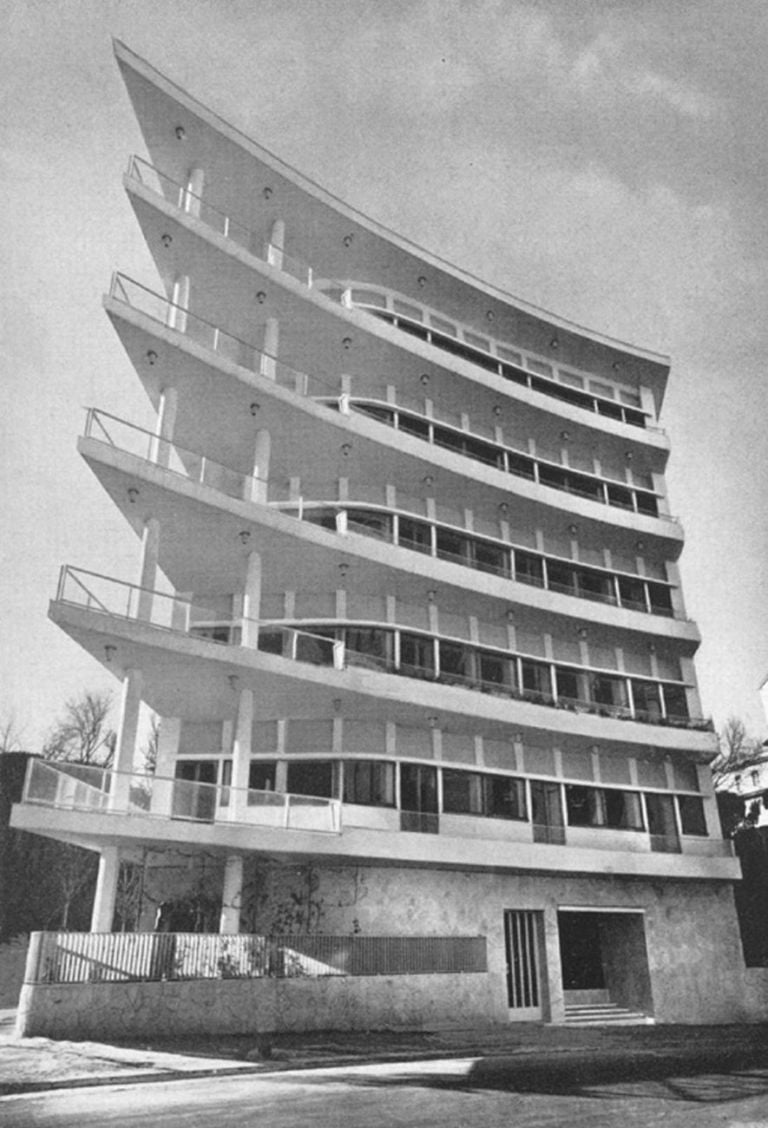 46 / 56
46 / 56
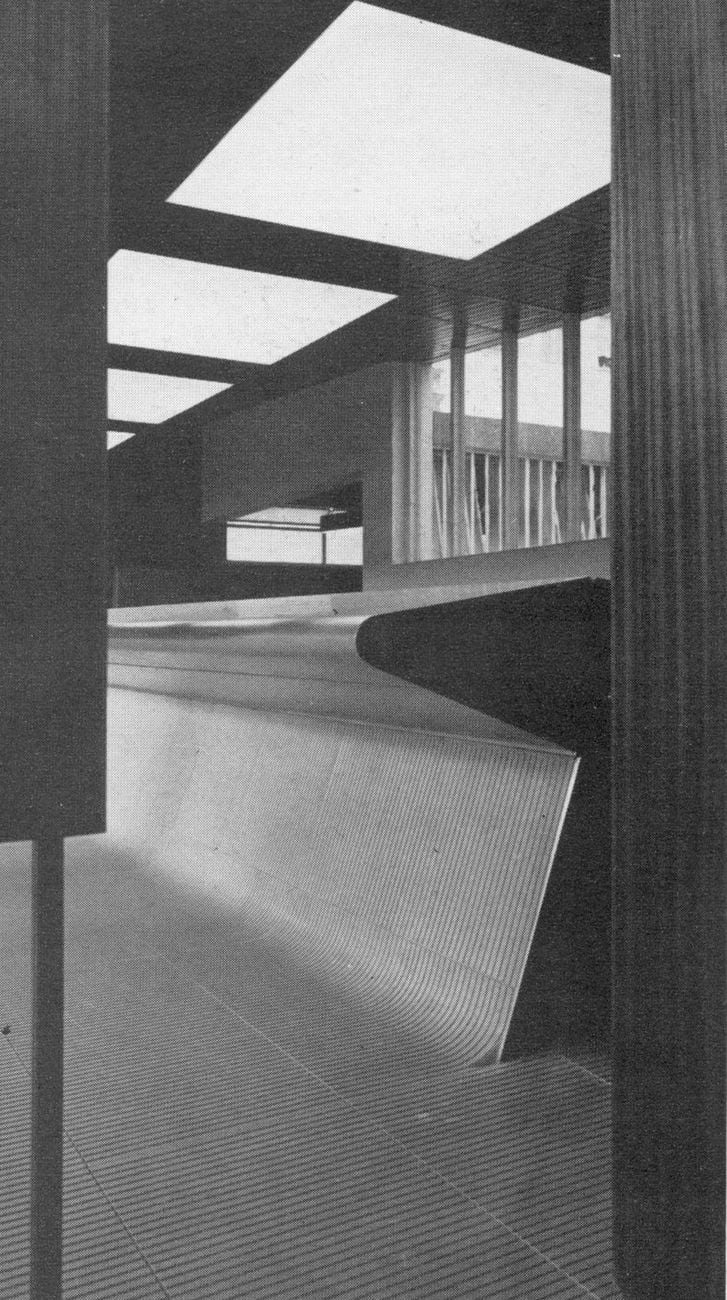 47 / 56
47 / 56
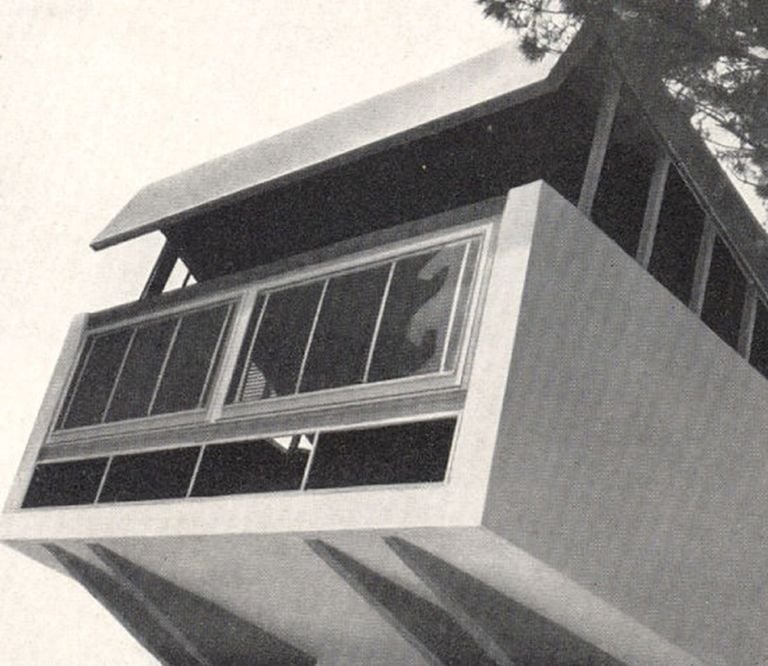 48 / 56
48 / 56
 49 / 56
49 / 56
 50 / 56
50 / 56
 51 / 56
51 / 56
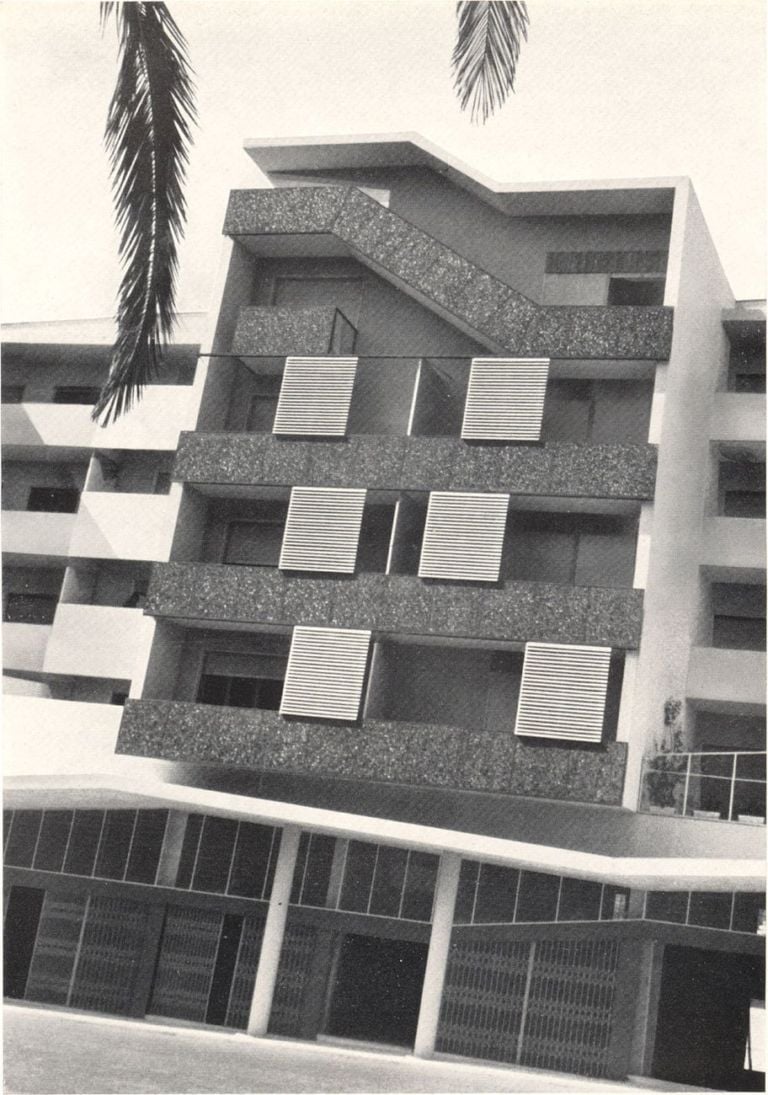 52 / 56
52 / 56
 53 / 56
53 / 56
 54 / 56
54 / 56
 55 / 56
55 / 56
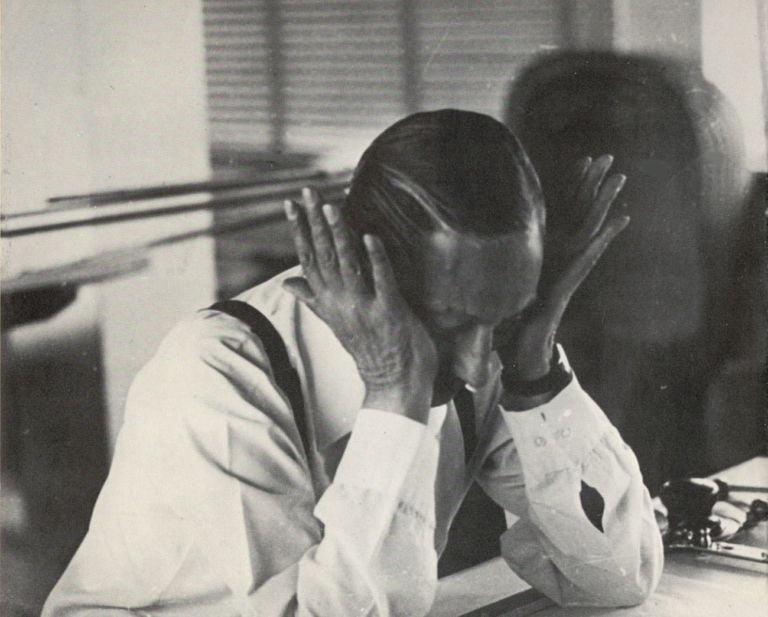 56 / 56
56 / 56
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati