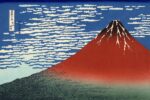Pittura lingua viva. Parola a Bea Bonafini
Viva, morta o X? 50esimo appuntamento con la rubrica dedicata alla pittura contemporanea in tutte le sue declinazioni e sfaccettature attraverso le voci di alcuni dei più interessanti artisti italiani: dalla pittura “espansa” alla pittura pittura, dalle contaminazioni e slittamenti disciplinari al dialogo con il fumetto e l’illustrazione fino alla rilettura e stravolgimento di tecniche e iconografie della tradizione.

Bea Bonafini vive a Londra, dove ha conseguito un MA in pittura al Royal College of Art nel 2016 e un BA in Fine Art alla Slade School of Fine Art nel 2014. Sue mostre personali recenti sono state presentate da Bosse and Baum, Londra, 2019; Lychee One, Londra, 2018; Renata Fabbri, Milano, 2018; Zabludowicz Collection, Londra, 2017. Tra le residenze cui ha partecipato: La Berlugane-Maleki Residency, 2019; Platform Southwark Studio Residency, 2018; FiBRA Colombia, 2018; Fieldworks Studio Residency, 2017; Villa Lena, 2016 e The Beekeepers Residency, 2015. A settembre 2019 si svolgerà una sua personale alla Galerie Chloé Salgado di Parigi e parteciperà alla residenza della British School at Rome.
Come ti sei avvicinata alla pittura?
Ho capito che la pittura avrebbe fatto stabilmente parte della mia vita quando a 17 anni ho frequentato la Salzburg Sommerakademie, un’esperienza fondamentale nel mio percorso artistico. Da allora ho continuato ad approfondire lo studio dell’arte nei dipartimenti di pittura delle università che ho frequentato, pur se nel frattempo sono andata maturando un percorso di allontanamento dalla cosiddetta pittura tradizionale. Quella tappa della mia giovinezza rimane tutt’oggi uno dei miei riferimenti principali.
Quali sono i maestri e gli artisti cui guardi?
Indubbiamente gli antichi. Mi affascina il mistero che emana dagli oggetti rotti o incompleti ritrovati nei siti archeologici; dai dipinti domestici creati da mani anonime ritrovati sotto le ceneri vulcaniche di Pompei o Ercolano; dai segni simbolici e dai testi ritrovati sotto strati di intonaco per esprimere credenze, miti, o semplicemente per urgenze emotive di espressione. Il filo corrente di tutto ciò è che lo scorrere del tempo trasforma gli oggetti, prendendosene il possesso e mettendoci il suo. A volte, non avendo spiegazione del perché qualcosa sia stato creato, ci inseriamo il nostro immaginario, ed è questo che mi affascina. Poi mi stimolano gli artisti che creano una fusione di linguaggi o di discipline, come Ernesto Neto, che crea oggetti che sono anche spazi, che si possono integrare con il proprio corpo, servendosene come una specie di cappella sensoriale.

Bea Bonafini, She told me a story as long as her lashes, 2019, detail. Oil on mixed carpet inlay, 200×140 cm
Come raccontavi prima, la tua formazione primaria è legata alla pittura, ma a un certo punto sei arrivata a una precisa constatazione e hai dichiarato in una intervista: “Volevo abbandonare il bagaglio della storia della pittura e saltare tra pittura e moda, design di interni o mobili, scultura, architettura e disegno”. Come si è quindi trasformato il tuo lavoro?
Quando lavoro, direi che uso un approccio pittorico, dal punto di vista estetico, pensando ai colori, alla composizione, come se l’opera fosse un dipinto senza essere “dipinta”. Poi, però, uso i materiali con un processo molto più scultoreo, utilizzando lame per tagliare, lavorando per terra. Voglio considerare la pittura come una scultura, perciò creo dipinti-non-dipinti che non richiedono una categorizzazione e che non hanno bisogno di essere crocefissi su un telaio.
E nel realizzare questi dipinti-non-dipinti ti confronti con diversi mezzi e materiali, alla ricerca di un coinvolgimento, di una sollecitazione continua di tutti i sensi, anche del tatto… Come nascono le tue installazioni immersive e avvolgenti? Quando progetti una mostra realizzi le singole opere e poi le allestisci o le pensi già in relazione e dialogo le une con le altre e con lo spazio espositivo?
Mi piace considerare le mie installazioni come una navigazione simbolica. L’inserimento dei miei lavori in una mostra non avviene mai senza creare uno strato supplementare, cioè il dialogo tra i lavori e lo spazio che li accoglie. Per questo il momento di ogni installazione ‒ che seguo personalmente dall’inizio alla fine ‒ ha un suo proprio “ritmo artistico”, vi circola la stessa energia creativa che ha percorso il momento più propriamente creativo delle singole opere. Nella loro collocazione nello spazio espositivo cerco di farle “parlare” tra di loro e di rallentarne la fruizione da parte del visitatore.
Quali nuove possibilità ti hanno offerto la tessitura, i tappeti, la tappezzeria? Si tratta di pratiche ancestrali molto legate al femminile, all’artigianato e alla mano intelligente…
Mi hanno inizialmente ispirato le coperte che vengono ricamate per uso domestico in varie culture. Ne acquistai una in Nepal che ho poi appeso in camera mia nel periodo in cui stavo passando dalla pittura a olio alla pittura di tessuti. Ogni mattina al risveglio la guardavo e pensavo al movimento della mano anonima che aveva cucito ogni piccola forma soffice su quello sfondo anch’esso così soffice. Mi è piaciuta la flessibilità di quell’oggetto, che nella sua tenerezza può essere piegato trasformandosi in uno straccio. Ho scritto una tesi in cui ho anche indagato il lavoro del movimento statunitense Gee’s Bend, un gruppo di donne che creano coperte di una complessità straordinaria pur essendo per uso domestico. La domesticità alla quale faccio riferimento usando le moquette nei miei arazzi è un modo per democraticizzare la scelta dei materiali per le opere d’arte.

Bea Bonafini, Slick Submissions, 2018. Pastel on wool and nylon carpet inlay, 426×366 cm
E cosa succede quando un pastello incontra la superficie di un tappeto?
Avviene una simbiosi graduale. Appena il pastello entra in contatto con le fibre del tappeto lascia una macchia superficiale. Col massaggio del tessuto i pigmenti entrano in profondità e diventano parte integrante della materia.
Spesso sposti il focus della composizione dalla verticalità all’orizzontalità, perché questa scelta?
Ciò che calpestiamo si consuma e si sporca, perciò di solito viene considerato di valore inferiore a ciò che si trova sui muri, dove la distanza conserva e impreziosisce. Mi piace spingere l’osservatore a invertire questa visione, a interrompere e rivedere la lettura consueta di un’opera.
Che ruolo ha il disegno nella tua pratica e in relazione alle tue opere?
Duplice. Il primo è puramente tecnico, è lo studio preliminare della creazione di un oggetto in senso pratico. Il secondo ruolo del disegno è la stimolazione dell’atto creativo in sé, per il suo processo lento e meditativo, o viceversa immediato ed energetico.
E il colore?
Istintivo e simbolico.
Cosa rappresenta per te il lavoro in studio?
È uno spazio di prove, cadute, epifanie, energia e magia.

Bea Bonafini. Courtesy Post_Institute Von Goetz
Cosa significa rappresentare un corpo?
Nei miei lavori il corpo subisce un processo di manipolazione: viene sezionato, allungato, deformato. Attraverso la sua frammentazione, esso diventa uno strumento, una lingua astratta composta da simboli, una grammatica sempre in trasformazione con interconnessioni infinite.
Figurazione e astrazione: dove finisce una e inizia l’altra?
Allontanarmi dall’evidenza delle cose percepibili mi consente di ampliare ciò che un’opera è o può significare. Quando non si ha tutto chiaro, si utilizzano altri mezzi di percezione per cogliere il senso di un’opera. Mi interessa rallentare la lettura di un’opera ed evadere da una sua narrativa definita.
Come nascono i titoli delle tue opere?
Traggo ispirazione dai versi di una canzone, da una riga di un diario, istintivamente, senza eccessive concettualizzazioni ma sempre in attinenza con l’opera.
‒ Damiano Gullì
Pittura lingua viva #1 ‒ Gabriele Picco
Pittura lingua viva #2 ‒ Angelo Mosca
Pittura lingua viva #3 ‒ Gianluca Concialdi
Pittura lingua viva #4 – Michele Tocca
Pittura lingua viva #5 ‒ Lorenza Boisi
Pittura lingua viva#6 ‒ Patrizio Di Massimo
Pittura lingua viva#7 ‒ Fulvia Mendini
Pittura lingua viva#8 ‒ Valentina D’Amaro
Pittura lingua viva#9 ‒ Angelo Sarleti
Pittura lingua viva#10 ‒ Andrea Kvas
Pittura lingua viva#11 ‒ Giuliana Rosso
Pittura lingua viva#12 ‒ Marta Mancini
Pittura lingua viva #13 ‒ Francesco Lauretta
Pittura lingua viva #14 ‒ Gianluca Di Pasquale
Pittura lingua viva #15 ‒ Beatrice Meoni
Pittura lingua viva #16 ‒ Marta Sforni
Pittura lingua viva #17 ‒ Romina Bassu
Pittura lingua viva #18 ‒ Giulio Frigo
Pittura lingua viva #19 ‒ Vera Portatadino
Pittura lingua viva #20 ‒ Guglielmo Castelli
Pittura lingua viva #21 ‒ Riccardo Baruzzi
Pittura lingua viva #22 ‒ Gianni Politi
Pittura lingua viva #23 ‒ Sofia Silva
Pittura lingua viva #24 ‒ Thomas Berra
Pittura lingua viva #25 ‒ Giulio Saverio Rossi
Pittura lingua viva #26 ‒ Alessandro Scarabello
Pittura lingua viva #27 ‒ Marco Bongiorni
Pittura lingua viva #28 ‒ Pesce Kethe
Pittura lingua viva #29 ‒ Manuele Cerutti
Pittura lingua viva #30 ‒ Jacopo Casadei
Pittura lingua viva #31 ‒ Gianluca Capozzi
Pittura lingua viva #32 ‒ Alessandra Mancini
Pittura lingua viva #33 ‒ Rudy Cremonini
Pittura lingua viva #34 ‒ Nazzarena Poli Maramotti
Pittura lingua viva #35 – Vincenzo Ferrara
Pittura lingua viva #36 – Luca Bertolo
Pittura lingua viva #37 – Alice Visentin
Pittura lingua viva #38 – Thomas Braida
Pittura lingua viva #39 – Andrea Carpita
Pittura lingua viva #40 – Valerio Nicolai
Pittura lingua viva #41 – Maurizio Bongiovanni
Pittura lingua viva #42 – Elisa Filomena
Pittura lingua viva #43 – Marta Spagnoli
Pittura lingua viva #44 – Lorenzo Di Lucido
Pittura lingua viva #45 – Davide Serpetti
Pittura lingua viva #46 – Michele Bubacco
Pittura lingua viva #47 – Alessandro Fogo
Pittura lingua viva #48 – Enrico Tealdi
Pittura lingua viva #49 – Speciale OPENWORK
 1 / 33
1 / 33
 2 / 33
2 / 33
 3 / 33
3 / 33
 4 / 33
4 / 33
 5 / 33
5 / 33
 6 / 33
6 / 33
 7 / 33
7 / 33
 8 / 33
8 / 33
 9 / 33
9 / 33
 10 / 33
10 / 33
 11 / 33
11 / 33
 12 / 33
12 / 33
 13 / 33
13 / 33
 14 / 33
14 / 33
 15 / 33
15 / 33
 16 / 33
16 / 33
 17 / 33
17 / 33
 18 / 33
18 / 33
 19 / 33
19 / 33
 20 / 33
20 / 33
 21 / 33
21 / 33
 22 / 33
22 / 33
 23 / 33
23 / 33
 24 / 33
24 / 33
 25 / 33
25 / 33
 26 / 33
26 / 33
 27 / 33
27 / 33
 28 / 33
28 / 33
 29 / 33
29 / 33
 30 / 33
30 / 33
 31 / 33
31 / 33
 32 / 33
32 / 33
 33 / 33
33 / 33
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati