Tutti pazzi per gli archivi. Ennesima moda o c’è di più?
Una lunga intervista a Marco Scotini sul tema dell’archivio e sulle sue implicazioni. Con l’arte, con la critica, con la filosofia
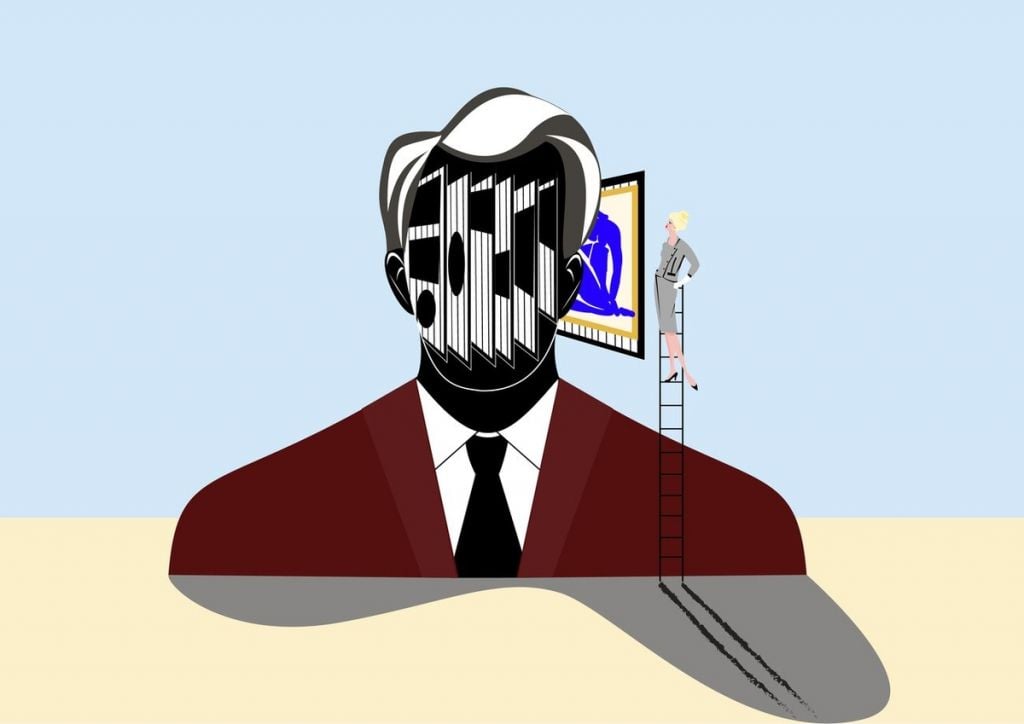
Il tema dell’archivio è ormai una costante nelle ricerche artistiche e curatoriali – basti pensare alla centralità che rivestirà alla prossima Documenta di Kassel e alla Istanbul Biennale. Se le radici teorico-pratiche di questa riflessione si possono far risalire al XX secolo, da Aby Warburg a Fluxus, da Michel Foucault a Jacques Derrida, nella riflessione critica internazionale del XXI secolo la figura centrale è quella di Marco Scotini. Il progetto Disobedience Archive risale infatti al 2005 e da allora, in forme sempre diverse, è stato esposto ai quattro angoli del globo. Nel frattempo Scotini ha proseguito la sua indagine sul filo del concetto di archivio, affrontando di volta in volta temi e momenti come l’arte italiana degli Anni Settanta, il femminismo, l’ecologismo. Chi se non lui poteva dunque fare il punto su questa enigmatica ossessione per l’archivio?

Julije Knifer. Non Aligned Modernity, Arte e archivi dell’Est Europa dalla Collezione Marinko Sudac. Installation view at FM Centro per l’arte contemporanea, Milano 2016
UNA CONVERSAZIONE CON MARCO SCOTINI
Partiamo da una classificazione delle tipologie di archivio, con particolare riferimento al mondo dell’arte. Ci sono almeno gli archivi d’artista (l’elenco è infinito: in ordine sparso, cito quello di Gianni Colombo che tu stesso segui, la realtà molto attiva e propositiva della Fondazione Piero Manzoni, realtà recenti e recentissime come quella dedicata a Fausta Squatriti, e l’elenco potrebbe continuare a lungo), gli archivi di critici e curatori (penso, per restare in Italia, allo Studio Celant e al patrimonio documentale recentemente donato da Achille Bonito Oliva al Castello di Rivoli, con mostra annessa in corso fino al 9 gennaio), gli archivi museali (in quest’ultimo caso penso a eccellenze come l’Archivio del ‘900 al MART di Trento e Rovereto, il CID – Centro di Informazione e Documentazione del Centro Pecci a Prato e lo stesso CRRI – Centro di Ricerca Castello di Rivoli). Quali sono le caratteristiche principali che li identificano e cosa contengono?
Parlando dell’archivio mi vengono in mente due brevi testi che non sono saggi teorici ma romanzi. Uno è Tutti i nomi del grande José Saramago, l’altro è L’anulare di Yoko Agawa, una delle “ragazze terribili” della scena letteraria giapponese. Il personaggio di Tutti i nomi è un impiegato senza attrattive dell’Anagrafe di una città portoghese non meglio identificata. La protagonista de L’anulare è assistente in un laboratorio dove oggetti carichi di memoria personale e affettiva vengono trasformati in reliquie o, meglio, in “esemplari”. Il signor Deshimaru, per cui la giovane lavora, è una sorta di tassidermista per ogni tipo di oggetto. Senza aggiungere altro, quello che però mi colpisce in questi due racconti è l’enigma fondamentale che contengono: un’incognita che non porta ad alcuna soluzione, ad alcuno sviluppo.
La capacità, spesso sottovalutata, della letteratura di fornire spunti teorici è una mia ossessione da parecchi anni, quindi accolgo in pieno questi spunti e ti chiedo: in che modo, più dettagliatamente, questi due romanzi ci permettono di riflettere sull’archivio?
La precisione procedurale, il carattere fattuale delle voci e delle registrazioni, gli ordinamenti e le classificazioni neutrali, la cura nel conservare tutto ciò, non garantiscono – come tali – né veridicità né eternità alle cose del mondo. Anzi, proprio lì dove tutto sembra ordinato, salta fuori l’incognito. Da un lato, la giovane assistente di Deshimaru finisce per diventare lei stessa un “esemplare” reificato. Dall’altro, la donna inseguita dall’impiegato dell’Anagrafe rimane, alla fine, soltanto un nome, un puro nome senza referente. L’aspetto interessante del libro di Saramago è che, solo al termine del racconto, l’impiegato capisce la possibilità che documenti e nomi possano essere scambiati tra loro, all’infinito. Tutto questo per dire che la ricchezza documentale che possediamo negli archivi dell’arte non è, di per sé, una garanzia di storicità. Certo abbiamo a che fare con un cumulo di documenti modernisti che non ha precedenti. Tutta questa mole di stampe fotografiche, lettere, contratti, differenti varianti di testi autografi, che ci arrivano da un recente passato, oggi non è più possibile. Il computer, WhatsApp e il cellulare non lasciano tracce.
È necessario elaborare il lutto archiviale, sono perfettamente d’accordo. Occorre farlo in maniera vigile, consapevole e critica, ma non in una chiave nostalgica.
Credo che la nostra contemporanea fissazione con l’archivio (con la sua immagine e la sua funzione) abbia a che fare con la perdita attuale del suo oggetto: l’elemento documentale. È vero che abbiamo pensato sempre l’opposto – e cioè che i database non facessero altro che favorire l’accumulazione, l’inventariazione e la conservazione di differenti materiali. Al contrario, penso che il nostro attaccamento all’archivio tradisca qualcosa di diverso e di originario. È un po’ come quando nasce la pittura di paesaggio: tutti la celebrano come un ritrovato connubio con la natura, mentre non fa altro che elaborarne il nostro affrancamento definitivo. In fondo l’idea di archivio (per come la conosciamo) trova il suo apice nel XIX secolo con la stampa, la fotografia, il telegrafo e la riproduzione meccanica delle cose. Qualcosa, cioè, in grado di materializzare anche l’immaterialità di un suono o di un momento. Ma oggi, nei nostri ambienti elettronici, quali sono le tracce o i depositi che ancora possiamo lasciare?

Raphael Grisey con Bouba Touré. Sowing Somankidi Coura. A Generative Archive. Second Yinchuan Biennale. MOCA Yinchuan 2018
ARCHIVI E ARTE
Gli archivi da cui siamo partiti, dunque, come possono e devono essere ricollocati in questa nuova topologia teorica?
Gli archivi museali e istituzionali a cui fai riferimento io li chiamo archivi-readymade, archivi alla lettera, magazzini convenzionali di cui già sappiamo il funzionamento: sono né più né meno che schedari, supporti alla storia dell’arte in un’accezione classica del termine. A volte possono essere esposti, altre volte citati in un libro, ma il loro senso non cambia. Questo assetto classico dell’archivio, diciamo così, deriva dal paradigma scientifico del XIX secolo e uno dei suoi scopi principali era istituire una tecnologia dell’identificazione che permettesse il controllo delle masse anarchiche che si andavano urbanizzando. Credo, al contrario, che il nostro attuale rapporto con l’idea di “archivio” sia di tipo paradigmatico. Abbiamo a che fare con regimi di storicità, non semplicemente con sistemi organizzativi. Una domanda seria al riguardo sarebbe quella di chiedersi: perché definiamo i documenti lasciati da Jannis Kounellis un archivio d’artista mentre quelli raccolti da Paulo Bruscky un’opera d’arte? Vedo che si riaffaccia l’enigma di cui ho parlato all’inizio: l’enigma dell’archivio. Proprio nel momento in cui questo dispositivo ha cessato di essere un luogo circoscritto e materiale per divenire una forma simbolica e culturale egemonica.
Hai sollevato un punto di importanza capitale. L’archivio, infatti, può diventare anche oggetto di riflessione artistica. A tuo avviso quali sono gli esempi più eloquenti, sia storici che contemporanei? Penso a figure come Gerhard Richter e Marcel Broodthaers, ad esempio, ma ancora prima a Fluxus e alla Institutional Critique – dove il confine tra opera e documentazione sfuma e diventa poroso.
Tutti gli autori che citi (ne potremmo aggiungere altri) soffrivano e soffrono di una giusta sindrome del sospetto: del documento probante, dell’immagine univoca, del museo garante di narrative veridiche. Molti altri artisti hanno invece lavorato all’aspetto formale o spaziale dell’archivio (ai differenti registri che lo istituiscono) e mi interessano meno. Ma l’archivio in arte, soprattutto dopo la fine della Guerra Fredda, ha sviluppato tutte le premesse concettuali emerse negli Anni Settanta: oggi è una presenza ingombrante che non può essere evitata. Penso ad Akram Zaatari, Pedro G. Romero, Deimantas Narkevičius, Walid Raad, Lamia Joreige, Sammy Baloji, Naeem Mohaiemen, Simon Wachsmuth, Sheba Chhachhi, solo per citarne alcuni.
Nella tua attività di ricerca hai affrontato più volte – sin da “tempi non sospetti” – e continui a confrontarti con questo enigma rappresentato dall’archivio. Tracciamo un itinerario di questa indagine, a partire dall’arte italiana degli Anni Settanta.
A un certo punto ho sentito la necessità di confrontarmi (vista la mia ossessione di sempre per l’archivio) con l’arte italiana di quegli anni, cercandovi le premesse. Ero sicuro che, oltre il ruolo egemonico dell’Arte Povera, avrei incontrato molto altro che era stato rimosso negli anni successivi. In fondo l’Italia di quel decennio è in grado di produrre un laboratorio sociale eccedente. Il suo intervento sulla trasformazione della temporalità e della fabbrica sociale (il post-fordismo) avrebbe dovuto muovere da un contesto estetico-culturale radicalmente innovativo, avrebbe dovuto compiere un salto paradigmatico. Da qui nasce la mia mostra L’Inarchiviabile. Italia anni ‘70, presso FM Centro Arte Contemporanea a Milano. Questa mi permette di capire come la matrice dell’archivio (l’atlante, la mappa, il catalogo) in tutti gli artisti esposti avesse avuto un potenziale eversivo basilare e dirompente: per trattare l’infinito, per sabotare le statistiche, per decostruire il genere, per misurare i corpi e il lavoro, per intervenire sul già filmato, sulla comunicazione, sull’immagine. In sostanza, l’archivio diviene, in quel contesto, un grimaldello per far saltare la storia e lasciar intravedere altri racconti… Chiaramente il filo conduttore, o la vera cornice, de L’Inarchiviabile è l’enunciato collettivo, il soggetto collettivo che parla, che si esprime, che si mobilita. Mi è sembrato importante rintracciare nella figura dell’archivio questa forte matrice della moltitudine contemporanea che rifugge sì dai dualismi classici, ma soprattutto dall’idea di un solo mondo possibile. La moltiplicazione dei processi di soggettivazione non può che accompagnarsi a una proliferazione di soggettività e sessualità eterogenee, post-identitarie, non vincolate a ruoli predefiniti.
Come si articolano e proliferano queste soggettività? Penso ad esempio alla questione di genere.
In rapporto al tema del genere, si tratta qui di sottrarlo a qualsiasi idea d’identità sessuale, con un processo di continua decostruzione che mette in scena una teatralità costitutiva e convenzionata dei comportamenti e delle attitudini. Penso a Lisetta Carmi in rapporto ai suoi Travestiti, quando dice che non esistono comportamenti obbligati se non in una tradizione autoritaria che ci viene imposta da sempre. Oppure penso alla tassonomia fiction dei ruoli del femminile di Marcella Campagnano che precedono i Film Stills di Cindy Sherman, così come le foto di Lisetta Carmi anticipano quelle notissime di Nan Goldin.
Ci si sottrae, in sostanza, alle assegnazioni che vedono gli intellettuali là (istituzione) e il popolo qua (politica). Le produzioni con cui abbiamo a che fare non si riconoscono né nella prassi creativa dell’istituzione artistica, né nella matrice predicatoria dei contributi politici.
Che poi questa stessa generazione fosse finita in un archivio giudiziario, a chiusura di quel decennio, mi pare un particolare non trascurabile. La posta in gioco era quella di profanare la storia dentro e contro quel dispositivo che la istituiva. Un’altra sorpresa è stata quando si è trattato di aprire gli archivi ribelli del femminismo per la mostra successiva, Il soggetto imprevisto.

Wang Sishun. Second Yinchuan Biennale. MOCA Yinchuan, 2018
ARCHIVI E CURATELA
Mi pare chiaro che, a fronte di quello che hai appena detto, anche dal punto di vista storico, critico e curatoriale l’archivio possa (debba) diventare (s)oggetto di studio più che strumento “neutrale”. In questo caso penso all’esempio seminale di Aby Warburg, alla mostra Archive Fever di Okwui Enwezor, e in un certo senso alla sempre più consueta abitudine di costruire mostre che contengano porzioni più o meno ampie di “documentazione” del lavoro degli artisti o dei temi affrontati nelle mostre stesse.
Ho sempre affermato che il curatore (la sua pratica) nasce dalle ceneri della storia. Per questo ha bisogno del paradigma dell’archivio: di una cosa accanto all’altra e non di una dopo l’altra. La storia è una costruzione modernista, gerarchica e verticista. C’è sempre una dimensione teleologica che fa cominciare le cose da qualche parte e le dirige da un’altra, c’è una causa e un effetto corrispondente. Senza questo costrutto storiografico non ci sarebbe passato, presente e futuro. Non sono pensabili, fuori di questo schema, neppure le avanguardie storiche, con il loro voler precedere il popolo che è già in marcia. Se c’è storia (compresa quella dei pop, minimalisti, land artisti, poveristi ecc.) non c’è necessità del curatore, basta un direttore museale che rimette ogni cosa al posto già assegnato. Il curatore invece ha bisogno di immaginare una relazione tra un’opera e l’altra, una relazione che non è già data, che non è già anticipata all’interno di un protocollo. Il curatore è orfano della storia o, meglio, dello storicismo. Non perché non conosce la storia ma perché riconosce la fragilità generale dei suoli e delle rappresentazioni, con la conseguente moltiplicazione dei punti di vista, con la decentralizzazione e la fine della sovranità dell’Uno: tanto della Storia dell’Arte che dell’idea di Popolo, di massa ecc.
Il nostro problema attuale è quello di riportare alla luce memorie collettive sepolte, corpi disobbedienti, ruoli repressi, libri interdetti, esposizioni rimosse. Insomma: tutto ciò che è stato lasciato fuori da una storia evoluzionista e patriarcale. Non c’è inclusività possibile senza trasformazione dei paradigmi narrativi, senza cambiarne infrastrutture di produzione. È un tema che ho affrontato anche con il cinema e il documentario nel libro Politiche della memoria, attraverso l’uso del found footage.
Veniamo a un nodo che fin qui abbiamo lasciato un poco sullo sfondo ma che ritengo sia centrale: qual è il rapporto fra archivio e memoria? Perché è chiaro, come mostra ad esempio Jacques Derrida in Mal d’archivio e come hai appena sottolineato tu stesso, che la costruzione di un archivio storico è inevitabilmente una costruzione “orientata” (e talora malleabile) del passato: nel presente si sceglie cosa conservare del passato, e così facendo si orienta il futuro.
Direi che questo appartiene piuttosto ai grandi racconti della storia. L’archivio, come tale, è una collezione di materiali eterogenei non immediatamente canalizzata in un costrutto finalizzato a qualcosa o in una storia che ha la pretesa di significare la totalità a partire da un singolo resoconto. Nella parola “archivio”, così come in “archeologia”, è vero che risuona la radice greca “archè” che, come dice Derrida, sta per comando (arconte) e origine. Ma come ci hanno insegnato due padri della filologia e archeologia moderne, si tratta di pensare qualcosa in cui l’origine non è l’unità incontaminata e coerente di un fenomeno, ma sempre la dispersione e l’ibridazione di più eventi. Che cosa si apprende, di fatto, se ci sbarazziamo dell’idea metafisica dell’inizio per seguire, al contrario, le vicende effettive? – si chiedeva Foucault, seguendo Nietzsche. “Che dietro le cose c’è tutt’altra cosa”, risponde, “non il loro segreto essenziale e senza data, ma il segreto che sono senza essenza o che la loro essenza fu costruita pezzo per pezzo a partire da figure che le erano estranee”.
Là dove l’origine, come tale, s’inventa un’identità o la forma inalterabile delle cose, non c’è altro che la proliferazione e la dispersione di maschere che si succedono: il teatro avventizio delle loro rappresentazioni, dove si ripete sempre e solamente il copione drammatico della dominazione. Per questo l’esordio di ogni cosa è tutt’altro che solenne: basso, derisorio, discontinuo. Sotto l’aspetto univoco di una figura o di un concetto si scopre sempre una moltiplicazione infinita di eventi, di archivi, di fratture, attraverso cui tale sedimentazione (quello che chiamiamo il ‘periodo storico’) si è formata. Se pensiamo all’idea di primitivo (anche in arte) o di classicità, decadenza ecc. non usciamo dal costrutto evolutivo che definiamo “storia”. Il fatto che la storiografia dell’arte sia in declino e che sempre più emerga il paradigma dell’archivio mi pare sintomatico in proposito. L’archivio risponde a questo venir meno delle narrative storiche e ufficiali ricorrendo a un dispositivo che può essere de-archiviato o re-archiviato continuamente. Dove ognuno può seguire il proprio percorso rispetto a tutti gli altri a disposizione. Se l’archivio è il campo del virtuale, la storia è quello dell’attuale.

Disobedience Archive. Installation view at Raven Row, Londra 2010
IL PROGETTO DISOBEDIENCE ARCHIVE
Qual è la particolarità di Disobedience Archive? In che modo ha anticipato l’interesse per gli archivi e con quali impostazioni teoriche e finalità?
Il progetto curatoriale risale al 2004 quando, a Berlino, concepisco un’esposizione itinerante di video, materiali grafici ed ephemera. La mostra-archivio era tesa a indagare le relazioni esistenti tra pratiche artistiche contemporanee, cinema, media tattici e attivismo politico. Ideato come un archivio di immagini video eterogeneo e in evoluzione, il progetto si è posto come una user’s guide attraverso le storie e le geografie di quattro decenni di disobbedienza sociale: dalla rivolta italiana del 1977 alle proteste globali, prima e dopo Seattle, fino ad arrivare alle insurrezioni, allora in corso, nel Medio Oriente e in Turchia. Dagli storici videotape di Alberto Grifi ai film di Harun Farocki, dalle azioni performative del gruppo americano Critical Art Ensemble a quelle del collettivo russo Chto Delat?, dalle inchieste di Hito Steyerl a quelle di Eyal Sivan, l’archivio Disobedience ha raccolto negli anni centinaia di materiali documentali, li ha esposti – ogni volta in maniera diversa – in decine di istituzioni museali internazionali. Nel 2014, con l’esposizione a SALT di Istanbul, Disobedience è stata sospesa perché in parte censurata e perché i tempi stavano cambiando in senso autoritario. Il prossimo anno, per una strana ironia della sorte, sarà parte della Istanbul Biennale.
Da queste riflessioni emerge un concetto di archivio non statico; al contrario, si dispiega come un lavoro infinito di rilettura. È un discorso che ovviamente si applica anche a Disobedience.
La domanda è: perché Disobedience era ed è ancora un archivio? Questo modello diviene importante proprio perché non si tratta tanto di un insieme di segni da conservare e interpretare, ma di un insieme di pratiche da raccordare, da montare tra loro in modi sempre diversi. Come registrare l’irriducibile emergenza e la singolarità dell’evento? Come tali eventi si manifestano, si concatenano e si scontrano? Il progetto è quello di un archivio multifocale permanentemente “in corso” sulle forme della disobbedienza sociale, strutturato attorno a una sorta di database come zona di visibilità e campo di leggibilità allo stesso tempo, come archivio documentale audio-visivo che richiede di essere de-archiviato e re-archiviato continuamente. Si tratta di un dispositivo contingente che sarebbe più opportuno chiamare “anarchivio” o archivio disobbediente. Costretto a mutare forma continuamente, Disobedience afferma l’impossibilità di una ricomposizione sociale delle nuove soggettività nelle forme classiche della modernità, negando qualsiasi istituzione che fissi i nuovi comportamenti in ruoli e funzioni predefiniti. Proprio per questo Disobedience non rinuncia a giocare con i simboli della modernità, rovesciandoli attraverso uno slittamento del senso: come nel caso del Castello di Rivoli, quando il Parlamento disegnato da Céline Condorelli si è sovrapposto al Circo di Martino Gamper, mentre Erick Beltrán ha disegnato un wallpainting sul buon governo (che naturalmente era upside down). Se penso alla scena contemporanea, devo ammettere che Disobedience è stata una mostra davvero pionieristica.
Restiamo ancora un momento su questo interesse sempre più diffuso per l’archivio, testimoniato ad esempio dal proliferare degli stessi sia alla prossima Documenta che alla Biennale di Istanbul.
Asia Art Archive, The Black Archives, Archives de luttes des femmes en Algérie sono solo alcuni degli archivi invitati da Ruangrupa per la prossima edizione di Documenta e molti saranno quelli presenti alla prossima Istanbul Biennale. Sicuramente questo interesse denota uno spostamento dalla figura dell’artista a quello delle progettualità artistiche. Il tentativo attuale di tante piattaforme collettive è quello di riscrivere il nostro passato, fuori da un’idea di universalismo di matrice occidentale e dal modello museale di matrice coloniale.
Diversamente dalla prima fase della globalizzazione, il mondo (nelle sue ex periferie) si comincia a chiedere se i modelli che ha ereditato siano stati davvero neutrali, se le divisioni operate dalla storia non abbiano occultato piuttosto le forme del potere occidentale nei suoi modi di edificare il mondo. Lo strumento dell’archivio diventa ora urgente per mettere in dubbio radicalmente i nostri modi di comprensione e i nostri meccanismi di identificazione. Uno dei compiti principali, nel tentativo di disarmare il potere universalista, viene individuato nella riscrittura di narrazioni temporali complesse, intrecciate tra loro e situate localmente, ma mai acquisite dall’univocità della modernità, tali cioè da restituirci una riserva di potenziale non esaurito nella storia, mai definitivamente in essa compiuto, ma sempre pronto a farsi (divenire) attuale. Non a caso Giorgio Agamben si chiede “Che cos’è il contemporaneo?”.
Come cambia l’archivio a fronte dei big data? Da un lato c’è senz’altro una semplificazione pratica nel catalogare e gestire la mole di informazioni raccolte, siano esse digitali o analogiche digitalizzate; dall’altra tuttavia non si può considerare soltanto una miglioria gestionale, perché subentrano fattori mediali che influenzano l’idea stessa di archivio.
Jean-Francois Lyotard imputava la crisi della storia tradizionale e dei meta-racconti modernisti alla società digitale, con il suo sostituire i database alle narrative come forma simbolica dominante. Anche Hal Foster vedeva la realizzazione dell’idea di museo senza mura – proposta da André Malraux – nel museo elettronico, virtuale, online. La pandemia recente ha poi accelerato il confronto (o la sovrapposizione) tra l’istituzione dell’arte e il paradigma visuale-digitale del sito web. Un artista come Allan Sekula all’inizio del millennio paragonava la nostra Era Internet a uno stato oceanico per immersioni liquide tra flussi informatici e liquidità dei mercati. Si possono lasciare tracce su o nell’acqua? Non faccio qui riferimento soltanto all’immaterialità e al carattere effimero della nostra informazione ma al suo eccesso: alla sua sovrabbondanza e indeterminatezza. Chi la potrà mai raccogliere tutta? Oppure: avrà mai un senso conservarla? È proprio il carattere documentale come tale a essere minato (una volta reso atomizzato, rapido, fluido, permanente) in questa supposta sovradocumentazione del mondo. Che tipo di documenti lasceremo? Siamo ancora in grado di pronunciarci sul carattere probatorio o meno di un’immagine? Se gli archivi del futuro non conserveranno prove, che cosa conterranno? Credo che ormai dovremmo essere esperti di quali sorprese ci riserva il rapporto tra ipermodernità e neoarcaismo. La tanto decantata scientificità o intelligenza artificiale negli ultimi due anni avrebbe dovuto mostrare il proprio volto violento anche ai più attardati, ma non è così. Il paradigma scientifico lo continuiamo a chiamare nuovo quando ha più di tre secoli: che aspettiamo a sostituirlo con un paradigma estetico? A quando rimandare una politica della memoria? Una politica delle immagini? Una politica del documento?
3 LIBRI PER APPROFONDIRE LA QUESTIONE DELL’ARCHIVIO
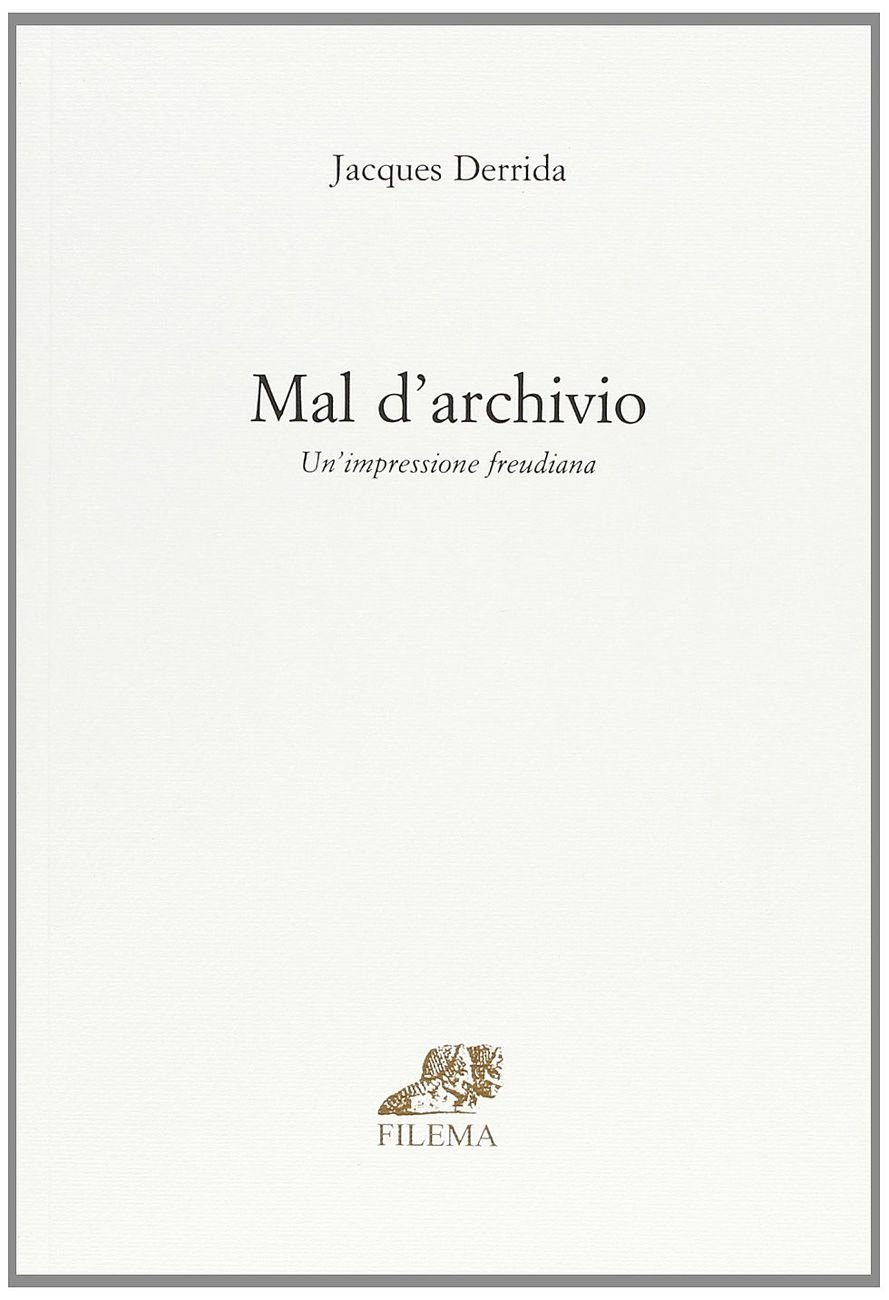
Jacques Derrida – Mal d’archivio (Filema, Napoli 1996)
FILOSOFIA DELL’ARCHIVIO
Concepito in prima battuta come lectio a un convegno tenutosi nel 1994 a Londra, questo testo di Jacques Derrida è sostanzialmente e consapevolmente privo di tesi, essendo costituito da una serie di introduzioni che alla fine costituiscono gran parte del testo stesso. Questa scelta stilistica, per così dire, sostanzia il “contenuto”, poiché la decostruzione qui si applica alla tensione irrisolta e irrisolvibile del concetto stesso di archivio, teso fra cominciamento (archè) e comandamento (arconte). Questa contraddittoria complessità viene esplicitata mettendola a confronto con piscoanalisi e giudaismo, essi stessi dilaniati fra ripetizione e messianismo.
Jacques Derrida – Mal d’archivio
Filema, Napoli 1996
Pagg. 131, f.c.

Cristina Baldacci – Archivi impossibili (Johan & Levi, Monza 2017)
OSSESSIONE CONTEMPORANEA
“Scegliere l’archivio come medium, rivisitandone il ruolo mnestico e insieme quello sociopolitico, per gli artisti significa mettere in moto una procedura critica dell’azione stessa del classificare o archiviare che si esprime attraverso il montaggio visivo, quindi attraverso quello che potremmo chiamare uno dei metalinguaggi più efficaci dell’arte contemporanea”: è quanto dichiarava Cristina Baldacci in una intervista rilasciata ad Artribune in occasione dell’uscita del suo Archivi impossibili. Un volume che coniuga prospettiva storico, teorica e monografica – con approfondimenti verticali dedicati a Gerhard Richter, Hanne Darboven, Marcel Broodthaers e Hans Haacke.
Cristina Baldacci – Archivi impossibili
Johan & Levi, Monza 2017
Pagg. 222, € 22
ISBN 9788860101907
https://www.johanandlevi.com

Asja Lācis – L’agitatrice rossa (Meltemi, Milano 2021)
UNA COLLANA DI GEOARCHIVI
Una novità delle ultime settimane è la collana GeoArchivi inaugurata dall’editore Meltemi. Alla direzione c’è proprio Marco Scotini, affiancato da un manipolo di professionisti accomunati dalla docenza alla NABA di Milano: Andris Brinkmanis, Paolo Caffoni, Zasha Colah, Massimiliano Guareschi, Gabriele Sassone ed Elvira Vannini. È proprio Brinkmanis a curare la prima uscita, L’agitatrice rossa della lettone Asja Lācis, figura radicale e pionieristica dell’Avanguardia storica, a cui il ricercatore si era già dedicato alla Documenta del 2017.
Asja Lācis – L’agitatrice rossa
Meltemi, Milano 2021
Pagg. 246, € 24
ISBN 9788855194433
https://www.meltemieditore.it
‒ a cura di Marco Enrico Giacomelli
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #63
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
 1 / 11
1 / 11
 2 / 11
2 / 11
 3 / 11
3 / 11
 4 / 11
4 / 11
 5 / 11
5 / 11
 6 / 11
6 / 11
 7 / 11
7 / 11
 8 / 11
8 / 11
 9 / 11
9 / 11
 10 / 11
10 / 11
 11 / 11
11 / 11
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati
















