I dimenticati dell’arte. Edoardo Cacciatore, il poeta che non piaceva a Moravia e Ungaretti
Dai saggi filosofici alla poesia, la scrittura di Edoardo Cacciatore va riscoperta per la sua eccezionale modernità

Una voce fuori dal coro, quella del poeta Edoardo Cacciatore (Palermo, 1912 – Roma, 1996), nato in Sicilia ma vissuto a Roma, dove si trasferisce sin dall’infanzia. Schivo e solitario, scrive alcuni saggi filosofici come L’Identificazione intera (1951) prima di dedicarsi alla poesia negli Anni Cinquanta, pubblicando i primi versi sulla rivista Botteghe Oscure, diretta da Giorgio Bassani e sostenuta da Marguerite Caetani. Si intitolano I graduali e la prima ad accorgersi della loro qualità è Elena Croce, che li recensisce su Lo Spettatore nel 1954, ma Cacciatore, che predilige forme chiuse e rigorose del verso poetico, si distacca dai modelli classici italiani per abbracciare uno stile più internazionale, vicino a Thomas Stearns Eliot.
LA STORIA LETTERARIA DI CACCIATORE
Cacciatore conduce una vita appartata, soprattutto dopo la morte del fratello maggiore nel 1928, e si dedica a una scrittura poetica complessa ed elaborata, in aperta polemica con la cultura letteraria ufficiale. “La poesia è intensificazione della realtà, introduce in essa una vibrazione intellettuale, è come un frammento di realtà di cui vuole rendere l’esperienza e il calore, che il poeta assorbe ed emana attraverso il testo”, scrive Cacciatore, che può essere considerato un anticipatore di molte tendenze della poesia contemporanea, dalla sperimentazione linguistica al recupero di una metrica sofisticata, alla riflessione sul Manierismo e sul Barocco. “Le sue strofe cadenzate in rigorose e inusuali misure metriche, pressoché prive di punteggiatura ma punteggiate di rime, si svolgono in ritmi sincopati e dissonanti. I suoni delle parole, anche le più comuni e del tran-tran quotidiano, hanno un tintinnio metallico”, scrive di lui Alfredo Giuliani.
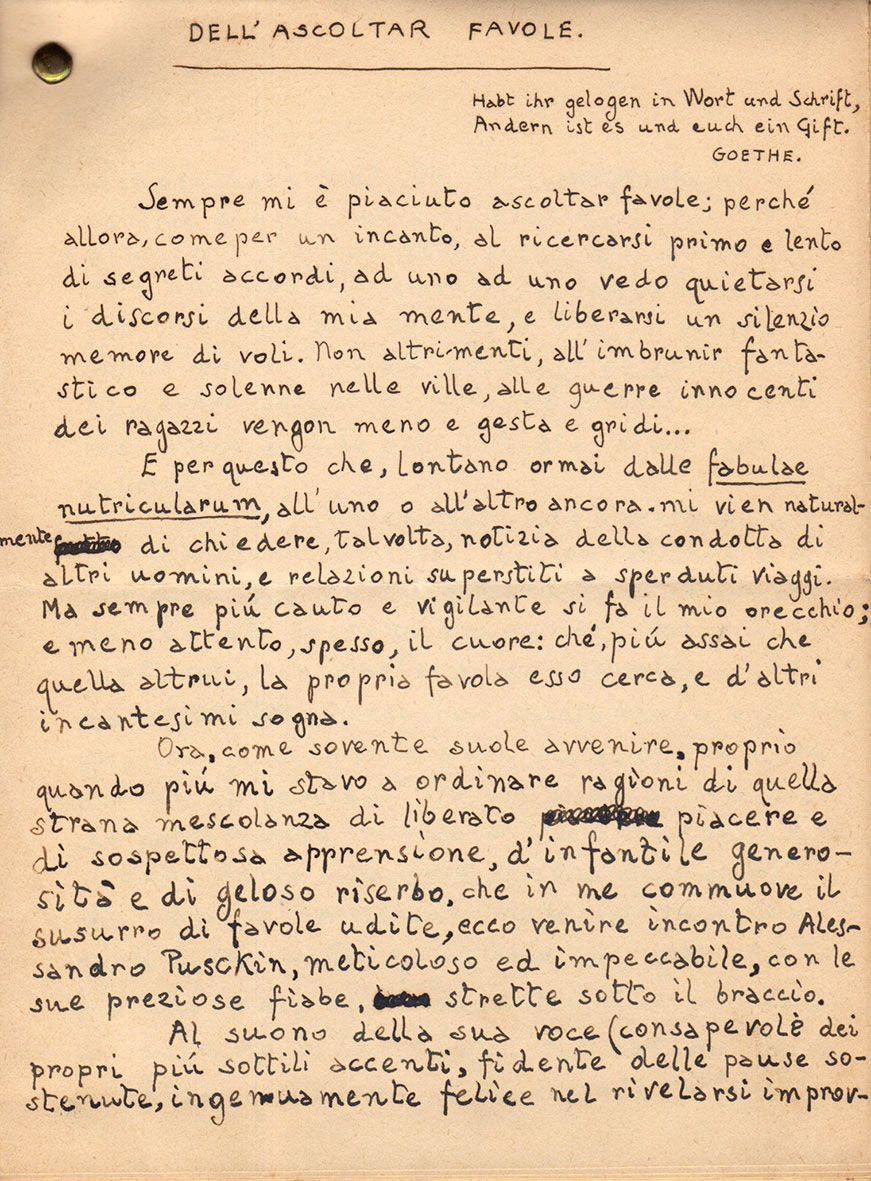 CACCIATORE, LA POESIA E ROMA
CACCIATORE, LA POESIA E ROMA
Non è un caso che il soggetto di molte poesie sia la città di Roma: “Questa luna che dice ad ogni cosa svestiti/ La realtà svela ai sepolcri dell’Appia/ Nella luna di luglio due volte superstiti/ Al morto prima ed ai vivi poi ch’io sappia”, scrive in Nella luna di luglio, mentre in Campo dei Fiori: “Il Nolano a mezz’aria/ Campo di Fiori è un mercato particolare/ Vi senti più il bruciato che il pesce di mare” e prosegue : “Chi sta urlando laggiù qualcuno che vaneggia/Libertà gratis è gente che rumoreggia/ La libertà ha un prezzo incredibile/A buon mercato è la merce deperibile/ Gli spazzini azionano gli idranti/ Il sangue si lava affermano i ben pensanti”. In Uno a Regina Coeli Cacciatore si sofferma sui bracci del carcere romano: “Alla fine un braccio è uguale all’altro braccio/ La rotonda solenne è l’unità del mondo/ La vista è vischiosa l’udito è un laccio/La memoria è la vedova di un vagabondo/ Il passato è un parassita della morte”.
CACCIATORE E LA CRITICA
Ma il poeta pensatore non piace agli esponenti della letteratura ufficiale: dopo l’uscita del saggio L’Identificazione intera Moravia si scaglia contro di lui urlandogli addosso “Ma chi ti credi di essere, Spinoza?“, mentre nel presentare la sua prima raccolta di poesie, La restituzione (1955), Giuseppe Ungaretti paragona le rime di Cacciatore ai versetti del Barbanera, un calendario popolare dell’epoca. Poco prima della morte la casa editrice Einaudi gli propone di pubblicare una raccolta di poesie, Il discorso a meraviglia, uscito nel 1996, poco dopo la morte del suo autore, che merita di essere riscoperto per la sua illuminante modernità.
‒ Ludovico Pratesi
LE PUNTATE PRECEDENTI
I dimenticati dell’arte. Liliana Maresca
I dimenticati dell’arte. Antonio Gherardi
I dimenticati dell’arte. Brianna Carafa
I dimenticati dell’arte. Fernando Melani
I dimenticati dell’arte. Pietro Porcinai
I dimenticati dell’arte. Giuseppe Vannicola
I dimenticati dell’arte. Alberto Martini
I dimenticati dell’arte. Il Maestro di Castelsardo
I dimenticati dell’arte. Pilade Bertieri
I dimenticati dell’arte. Mario Puccini
I dimenticati dell’arte. Guglielmo Janni, il pittore amato da Ungaretti
I dimenticati dell’arte. Salvatore Meo, l’artista del riciclo
I dimenticati dell’arte. Federico Seneca, il grafico dei Baci Perugina
I dimenticati dell’arte. Il pittore Luigi Trifoglio, meteora della Scuola romana
I dimenticati dell’arte. Clotilde Marghieri, la scrittrice che parlava con Bernard Berenson
I dimenticati dell’arte. Bruno Caraceni, l’artista che ha ispirato Burri
I dimenticati dell’arte. Vincenzo Rabito, l’analfabeta che diventò scrittore
I dimenticati dell’arte. Giuseppe Novello, pioniere della satira di costume
I dimenticati dell’arte. Carlo Romagnoli, il pittore della campagna romana
I dimenticati dell’arte. Guido Seborga, lo scrittore della Resistenza
I dimenticati dell’arte. Emanuele Rambaldi, il pittore della Liguria
I dimenticati dell’arte. Ennio Belsito, il pittore affascinato dall’Oriente
I dimenticati dell’arte. Colantonio, il maestro di Antonello da Messina
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





