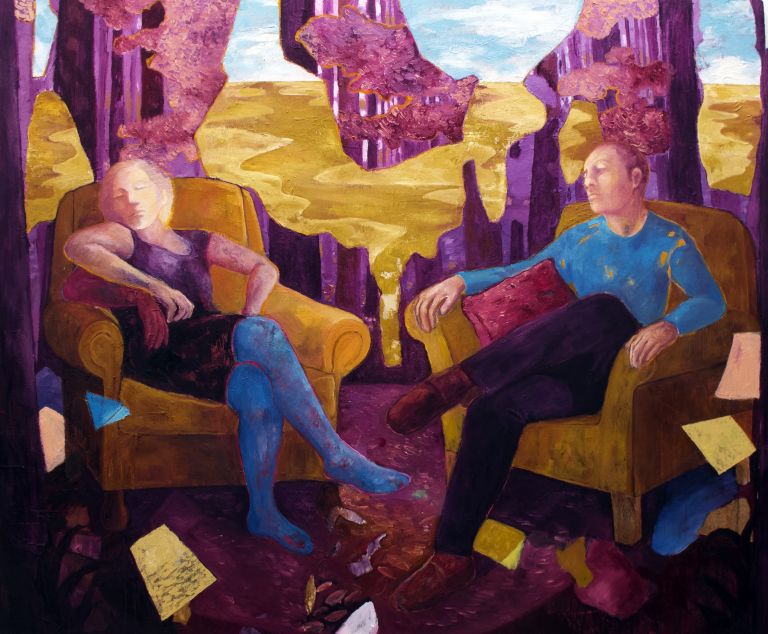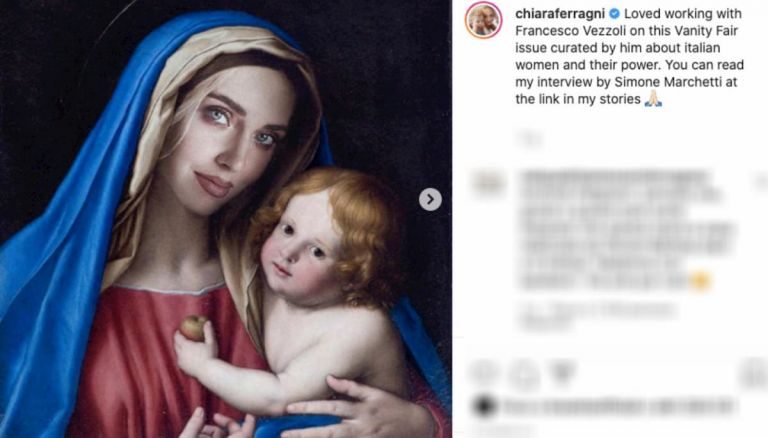Spazi matriarcali, parte seconda (X). Edie, i Counting Crows & la reflection
“A proposito della differenza tra artista e ‘persona d’azione’. Sì, credo che non si possa fare arte, o scrivere, essendo completamente DENTRO l’azione, la tempesta, il caos. L’arte e la scrittura provengono (necessariamente?) dal di fuori della vita”. L'ultimo capitolo della rubrica di Christian Caliandro dedicata agli spazi matriarcali.
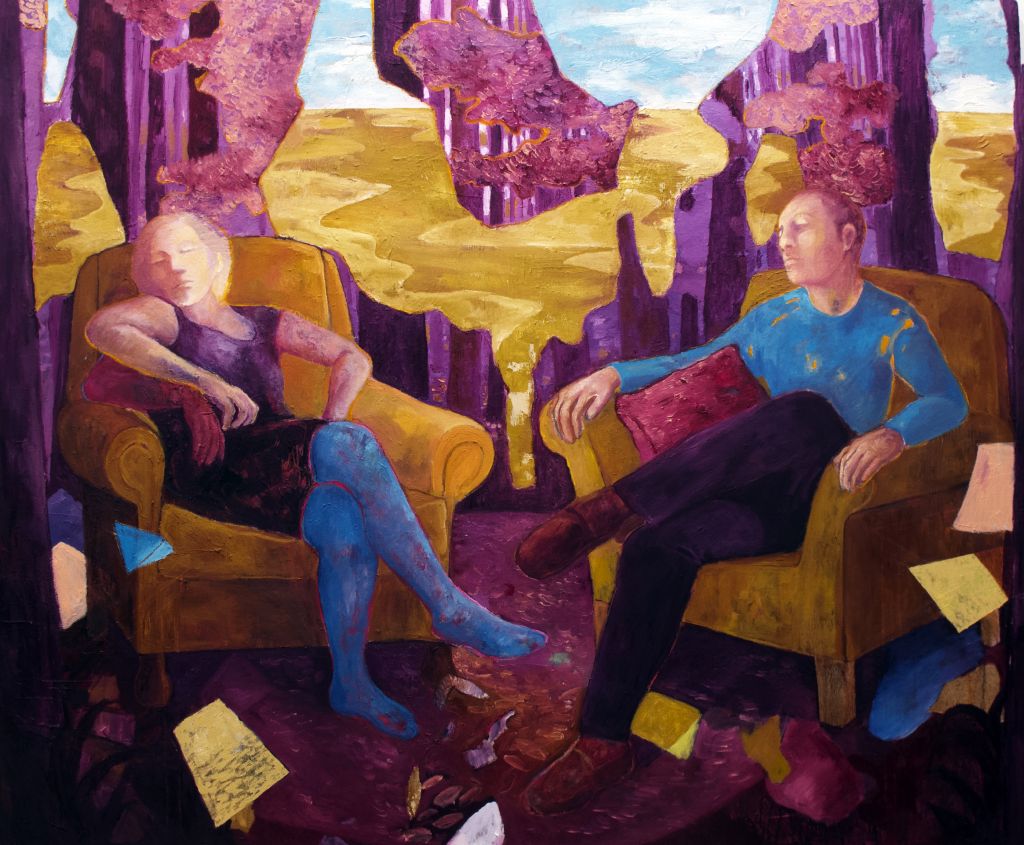
Riascoltare tutto – tutti i gruppi degli Anni Novanta e primi Duemila, l’intera discografia dei Radiohead per esempio, i Counting Crows e i Live, gli Helmet, i Prodigy, i Verve, i Gloria Record – riascoltarli come se fosse la prima volta, e in realtà è davvero la prima volta in qualche strano modo – la ripresentazione è la presentazione, la riproduzione è la produzione, e le cose le incontriamo davvero solo nel ricordo, nel recupero, nel riciclaggio, una volta estratte dall’esperienza diretta – un po’ come la pop art risiede davvero non nella superficie ma nella reflection, nel riflesso/riflessione (I’ll be your mirror) come dice Edie Sedgwick allo scettico presentatore Merv Griffin nel 1965 – ed è questa la trasformazione dello sguardo a cui torniamo e dobbiamo tornare sempre; la novità risiede nel modo in cui percepiamo e studiamo e indaghiamo la realtà che ci circonda, non negli strumenti o peggio ancora nelle tecnologie.
Solo nel riflesso e nel ricordo il mondo vive in noi.
(È la solita questione della distanza rispetto ai fenomeni: nessun soldato di prima linea – posto nel fuoco dell’impegno – ha mai raccontato la guerra; il ‘testimone’ è sempre infatti un vigliacco delle retrovie, un traditore; è uno cioè che ha posto una giusta distanza tra se stesso e il turbine degli eventi, uno che resiste alla brutalità dell’esperienza e che non si fa risucchiare e maciullare da essa, uno che coltiva una forma più sottile e diversamente intensa di disperazione…).
***
A proposito della differenza tra artista e “persona d’azione”. Sì, credo che non si possa fare arte, o scrivere, essendo completamente DENTRO l’azione, la tempesta, il caos.
L’arte e la scrittura provengono (necessariamente?) dal di fuori della vita – da una zona esterna, estranea allo scorrere e al flusso dell’esistenza – quando fai arte o scrivi stai pensando e parlando in realtà da un territorio che non fa parte dell’esperienza quotidiana (infatti, il problema principale di molta arte e letteratura odierne è che la maggior parte degli autori – a differenza forse di altre epoche – pretendono di scrivere tutti dentro, dal di dentro, dall’interno, di parlare una lingua comune “diffusa”, quella della “maggioranza”, e pretendono che questo sia non solo un vantaggio pratico – che può essere – ma un vanto culturale, una sorta di “abbattimento-delle-barriere” – quando invece si tratta al massimo di un restringimento, di un rinchiudersi ulteriormente all’interno di confini angusti e anzi di un costruire nuove inutili barriere; invece di sfondare, ma sul serio, quelle che ci sono). L’arte/scrittura dal-di fuori diventa quindi sempre più impervia, e per questo sempre più interessante e decisiva: “Dentro di noi abbiamo un’Ombra: un tipo molto cattivo, molto povero, che dobbiamo accettare” (Carl Gustav Jung).

Il post di Chiara Ferragni su Instagram
L’arte/scrittura che proviene da un vuoto – e quel vuoto è l’unica cosa vera che esiste, tra moltissime illusorie – l’arte/scrittura come un’interferenza, qualcosa di non previsto né atteso, il contrario dell’attenzione, qualcosa che non solo distrae e distoglie la concentrazione ma che nasce e cresce proprio nell’attimo della distrazione, che prospera sui margini, sugli spigoli, sui lati. (Un suono di campanelli elettronici totalmente distorto e immerso in una coltura ambientale – come soffermarsi sull’atmosfera, sull’aria tra i corpi, sugli spazi che separano gli oggetti piuttosto che su corpi e oggetti stessi. Sugli intervalli.)
La metafora della guerra è (purtroppo) sempre valida. È molto raro il caso di chi racconta dopo aver combattuto: lo standard è piuttosto lo stress post-traumatico, la condizione di mutismo che caratterizza i soldati (Prima Guerra Mondiale, Seconda Guerra Mondiale, Vietnam, Iraq, Afghanistan, ecc.). Chi racconta, chi testimonia? Il vigliacco, l’imboscato. Al massimo il reporter embedded, o comunque il giovane giornalista che sta al seguito e a fianco delle pattuglie, ma non nel fuoco dell’azione. È così, per esempio, nel caso di Omaggio alla Catalogna di George Orwell, di Addio alle armi di Ernest Hemingway (che faceva il conducente di ambulanza, e si fece pure ferire) o dei Dispacci di Michael Herr, forse il più bel reportage di guerra che è poi la base per Full Metal Jacket di Kubrick.
L’artista/scrittore/testimone deve stare comunque in qualche modo a distanza – a distanza di sicurezza. Per poter raccontare, non deve essere del tutto coinvolto.
‒ Christian Caliandro
Articolo pubblicato su Artribune Magazine #56
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
LE PUNTATE PRECEDENTI
Spazi matriarcali, parte seconda (I). Il pensiero femminile
Spazi matriarcali, parte seconda (II). La fine del patriarcato
Spazi matriarcali, parte seconda (III). La bellezza di essere vivi
Spazi matriarcali, parte seconda (IV). Tempi interessanti
Spazi matriarcali, parte seconda (V). Essere nel momento
Spazi matriarcali, parte seconda (VI). Lo stato di grazia
Spazi matriarcali, parte seconda (VII). Resistere e cambiare
Spazi matriarcali, parte seconda (VIII). Essere tutto e tutti
Spazi matriarcali, parte seconda (IX). La migrazione dell’avanguardia
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati