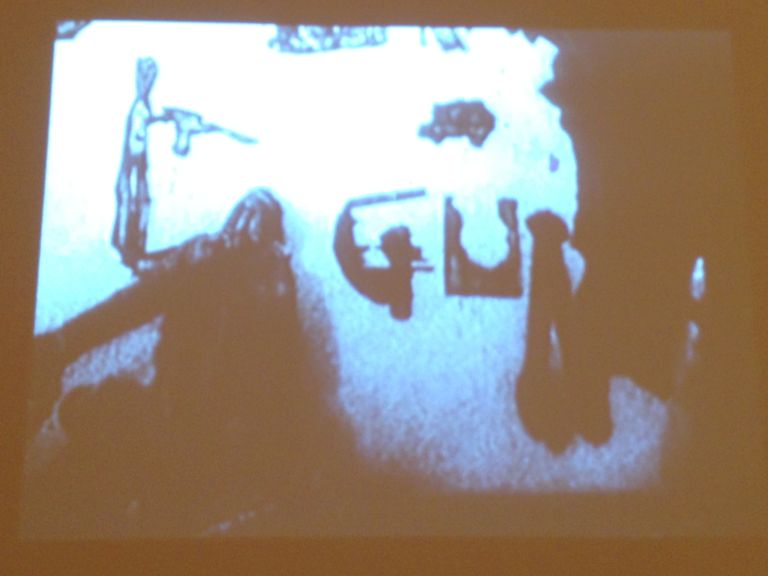Oldenburg porta i suoi Anni Sessanta al Guggenheim di Bilbao
“A quel tempo camminavo per le strade di New York e osservavo le vetrine dei negozi e gli oggetti della strada. Ho poi voluto rifarli applicando su di essi la pittura. Mi interessava andare dentro l'oggetto, esserne coinvolto”. A parlare è Claes Oldenburg in occasione della mostra appena aperta al Guggenheim di Bilbao. Ve la raccontiamo.

“Quando si ha la mia età può capitare che il tuo lavoro sia molto conosciuto e che la gente voglia parlarne, così devi spendere molto del tuo tempo a far ciò”. Claes Oldenburg (Stoccolma, 1929), uno dei più longevi protagonisti della Pop Art, lo dice con pacata riflessività, ma resta consapevole del fatto che forse gli anni migliori sono ormai irrimediabilmente passati, non soltanto per lui ma per un intero mondo che ha conosciuto momenti di esaltazione idealistica con poca ideologia e tanto entusiasmo.
Siamo negli Anni Sessanta e l’artista nato in Svezia e cresciuto a Chicago inizia a lavorare a New York aprendo nel Lower Est Side un suo spazio off all’interno della Judson Gallery, a sua volta ospite dell’omonima chiesa. In un clima di sperimentazione totale, Oldenburg lavora e invita amici, tra cui Allan Kaprow, a lavorare da lui. Qui avverrà la sua prima e pressoché unica performance: Snapshots from the city (1960), meritoriamente esposta a Bilbao, e qui presenterà appesi per strada i suoi primi lavori fatti di cartoni, tele e legni di recupero. Si tratta di sculture piatte che si pongono al crocevia tra pittura, disegno e scultura: con essi Oldenburg ricostruisce a modo suo gli oggetti e gli abitanti della strada, come l’“homeless” Big Man o la prostituta Sweet Cheek (Standing), entrambi lavori del 1960 che esporrà presso la giovane Reuben Gallery.
L’anno successivo creerà una serie di bandiere fatte con piccoli legni di recupero. Sono oggetti delicati e raffinatissimi, che ricordano le Costruzioni (figlie del cubismo sintetico) con le quali Picasso tra il 1912 e il 1914 darà il “la” a tutta l’arte dei combine a venire. Per Oldenburg però si tratta di un passaggio, il segno di una metamorfosi in atto che perdurerà per tutti i Sessanta con esiti definiti come “espressionisti” dal curatore della mostra Achim Hochdörfer, curator al Mumok di Vienna da dove la mostra proviene per poi andare al MoMA e terminare al Walker Art Center di Minneapolis.
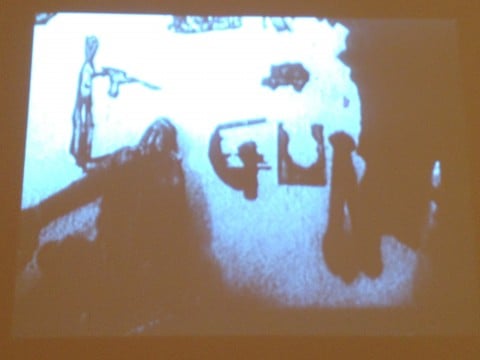
Claues Oldenburg – Snaphots from the City – 1960
In effetti, la serie si presenta graffiante, aggressiva e primitiveggiante. In una parola, debitrice della graffiti art. Lo si vede bene nei monotipi di disegni che Oldenburg crea con l’intento di seguire una rigorosa estetica della strada, tracciando scene di vita urbana abbozzate come dalla mano di un bimbo oppure vignette erotiche e pseudo-affiche con il proprio nome promosso da insegne luminose. È la vita di una New York vista dal LES quella che Oldenburg racconta in queste “stampe” a pezzo unico: una città grezza, rudimentale, disordinata e terribilmente creativa. Una combine-city essa stessa.
“Gli artisti sentivano di trovarsi in un momento di transizione, tutti si chiedevano ‘chi sarà il prossimo’? Pollock era morto pochi anni prima, nel 1956, e tra gli artisti si apriva una competizione feroce per raccoglierne il testimone”, spiega Hochdörfer. Nel 1963 Oldenburg vola a Los Angeles per la personale alla Dwan Gallery. Qui espone i lavori costruiti nel suo nuovo spazio, The Store: si tratta di un luogo di produzione e di vendita diretta degli oggetti che lì vi nascono. I più grandi li vende per poche centinaia di dollari, come Cash Register che oggi il Guggenheim assicura per 5milioni di euro. A quel tempo, però, gli affari non decollano. Sarà Andy Warhol, con il quale condivide l’abitazione di Los Angeles offerta dalla gallerista, a comprare una delle giacche realizzate, come tutti gli “oggetti” di allora, stendendo brandelli di tela, colorati con smalti industriali su scheletri di fil di ferro.
In questo modo la Pop Art di Oldenburg vuole restare vicino all’aspetto “industrial” delle cose prodotte in serie: in realtà le stravolge come in un Grand Guignol per cui le sculture diventano grumose, borbottanti, grondanti di colori brillanti. “A quel tempo camminavo per le strade di New York e osservavo le vetrine dei negozi e gli oggetti della strada. Ho poi voluto rifarli applicando su di essi la pittura. Mi interessava andare dentro l’oggetto, esserne coinvolto”, ricorda lo stesso Oldenburg. In effetti, già nei tardi Anni Cinquanta l’artista scatta fotografie agli oggetti lasciati per strada, dimostrando un coinvolgimento quasi sentimentale verso queste forme di abbandono. Sono le rovine del consumismo contemporaneo, ma anche i protagonisti simbolici della vita onirica che abbiamo imparato a conoscere grazie al Surrealismo. Con un solo atto interpretativo Oldenburg mette così insieme due visioni distanti dalla cui frizione però nascono nuove scintille creative. The Store sarà la fucina dove sorgeranno anche i primi oggetti morbidi, come Flood Cake (1962) una gigantesca fetta di torta gonfiabile che Philip Johnson donerà nel 1975 al MoMA di New York.

Claes Oldenburg – Mouse Museum – 1972
L’installazione relazionale voluta da Hochdörfer serve a mettere in mostra le opere così come venivano esposte allora, come dentro un negozio, uno spazio uniforme capace di presentarsi come un continuum e diventare quindi un’installazione esso stesso. Sono questi i lavori aurorali di Oldenburg, intuizioni che lo porteranno ai progetti large scale rendendolo celebre, scandaloso, controverso, ma sempre visionario, surreale e per molti versi utopistico. Come quando progetterà i primi oggetti-architettura, fra i quali la molletta per stendere i panni trasformata in grattacielo (per il Chicago Tribune) con la quale la mostra di Bilbao giunge verso un suo primo culmine. Ma prima si attraversa la sezione che accoglie lavori fondamentali degli anni centrali del decennio, come la toilette ricostruita in cartone e gli interruttori della luce o i telefoni morbidi, esempio di quanto l’artista vada ampliando le dimensioni e raffreddando il colore.
Quando la contestazione giunge nelle università americane, Oldenburg progetta per la Yale University un monumento della pace, psichedelico, umoristico e graffiante. Un rossetto gigante montato su un cingolato che al centro della piazza gonfia la sua parte rossa quando un oratore inizia a parlare e si sgonfia al suo termine. Il rettore tenterà di rifiutarla, ma l’atto di donazione da parte degli studenti ne impedirà la censura. È questo l’apice della creatività contestataria venata di umorismo tipica di Oldenburg. Da lì a breve il MoMA dedicherà una prima retrospettiva all’artista. “È stata la summa dei miei lavori degli anni Sessanta”, spiega Oldenburg, “ma in quel momento la situazione a New York cambiò considerevolmente. I Sessanta iniziarono in modo positivo ma finirono tragicamente: aumentavano gli omicidi, la droga, la violenza. Non so cosa davvero accadde ma la gente era diversa. Anche la mia vita ebbe una cesura: mi separai da mia moglie, le detti il mio studio e io ne trovai un altro, dove fare un lavoro diverso usando il metallo e la grande scala. Così iniziò un nuovo periodo”.

Claus Oldenburg – Toelet Hard Model – 1966
La mostra – sponsorizzata dalla Fondazione BBVA – si conclude con un masterpiece realizzato da Oldenburg per Documenta a Kassel nel 1972: il Mouse Museum, una sala a forma di testa di Mickey Mouse dentro cui l’artista ha accolto buona parte degli oggetti da lui collezionati nei primi Anni Sessanta. È ancora Oldenburg a spiegarci l’operazione: “Mouse Museum è una collezione, uno studio. Tutto quello che trovavo interessante lo prendevo e lo mettevo in uno scaffale. A volte le persone mi portavano qualche oggetto da aggiungere. L’ho fatto per un paio d’anni, dopo di che iniziai a immaginare questi oggetti come più grandi, sostituendo alla teca l’idea del museo. Quindi Mouse è davvero il museo delle mi esperienze degli Anni Sessanta”.
Protagonista assoluta è la Ray Gun, la pistola laser per cui Oldenburg ebbe una infatuazione primigenia. Come in un museo di antropologia primitiva, anche qui si scorgono le evoluzioni di un oggetto. Non la punta di una lancia, ma la pistola di Flash Gordon, che parte da legni erosi dal mare a forma vagamente a L e giunge fino a noi in design bombati e plastiche sgargianti.
La mostra, non abnorme ma ricchissima di spunti, è costellata di video e fotografie realizzate dallo stesso Oldenburg: materiali inediti che danno il senso di quel che lui osservava e riteneva, creando un ritratto della città di cui i suoi oggetti-soggetti sono la voce, il cuore e l’urlo.
Nicola Davide Angerame
Bilbao // fino al 17 febbraio 2013
Claues Oldenburg – The Sixties
a cura di Achim Hochdörfer
GUGGENHEIM
Avenida Abandoibarra 2
+34 944 359000
[email protected]
www.guggenheim-bilbao.es
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati