Il settore dell’abbigliamento tessile ha avuto una rilevanza limitata all’ultimo COP27, il vertice delle Nazioni Unite dedicato ai problemi ambientali. Ma un accordo stilato nella notte dell’ultimo giorno ha istituito il Loss and damage, un fondo per risarcire i danni subìti dai Paesi che, pur essendo tra i meno responsabili del riscaldamento globale, ne stanno subendo i danni peggiori. Il fondo ha raggiunto per il momento la cifra di 230 milioni di dollari. Adattamento climatico, tagli alle emissioni di gas serra e investimenti in tecnologia per lo sviluppo delle capacità produttive nei Paesi in via di sviluppo: sono questi gli obbiettivi prefissati. Il fondo si è poi immediatamente dotato di un comitato di transizione con l’incarico di costruire una struttura finanziaria da rendere operativa a partire dal COP28, previsto per il prossimo marzo. Davvero fuori dal comune risulta soprattutto la riflessione innescata circa la relazione esistente tra clima e colonialismo, argomento mai discusso precedentemente in un consesso del genere. Il fondo si inscrive in una strategia che cerca di individuare i luoghi più danneggiati dagli impatti climatici nei Paesi dove avviene attualmente la grande maggioranza delle produzioni. Si tratta quasi sempre di ex colonie. Storia coloniale ed emissioni sono infatti strettamente correlate: Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Belgio hanno colonizzato le Americhe, l’Africa e il sud-est asiatico, creando grandi condizioni di vulnerabilità. Tuttavia Paesi come la Cina, mai considerata uno stato coloniale, hanno pesanti responsabilità, così come gli Stati Uniti, la Russia e il Giappone, che hanno storie imperiali anche se non necessariamente coloniali.
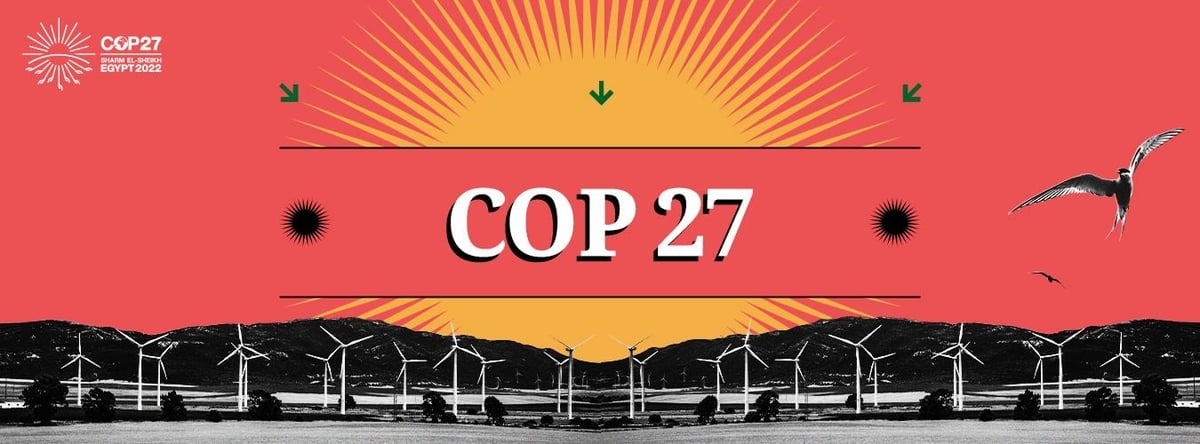
COP 27
MODA E INQUINAMENTO
Per l’industria della moda è arrivato il momento di riconoscere le proprie radici e il modo in cui questa eredità continua a manifestarsi tanto nello smaltimento delle produzioni che nelle catene di approvvigionamento. Quel che accade ad esempio in Ghana è noto: qui vengono scaricate anno dopo anno tonnellate di indumenti di seconda mano provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti. Ad Accra, lo strato di rifiuti tessili sepolti sulle spiagge arriva fino a due metri di profondità. Secondo uno studio della Commissione europea (marzo 2022), il consumo europeo di prodotti tessili ha il quarto maggior impatto sull’ambiente dopo il cibo, l’alloggio e la mobilità. È il terzo settore per maggior utilizzo di acqua e uso del suolo, e il quinto per utilizzo di materie di prima necessità ed emissioni di gas serra. Ogni anno un cittadino europeo getta in media 11 chilogrammi di prodotti tessili: meno dell’1% viene riciclato, il resto finisce appunto in Paesi come il Ghana. Oltre a quella dei rifiuti è necessario che la moda ripensi l’intera catena di approvvigionamento che comprende le pratiche di acquisto, i prezzi imposti alle manifatture, i tempi di consegna, lo sviluppo del prodotto e i modelli di vendita. Non ultimo c’è il problema dei salari, che dovranno divenire per lo meno dignitosi. A causa dell’effetto dei cambiamenti climatici (come inondazioni e caldo estremo in regioni vulnerabili come il Bangladesh), chi cuce i vestiti che indossiamo rischia sempre più di frequente la vita. Loss and damage è qualcosa di innovativo, manca tuttavia qualsiasi riflessione su come i Paesi ricchi possano aiutare quelli poveri a sviluppare le loro economie. Ad esempio, quale know how fornire loro per passare alle energie rinnovabili, solo così è possibile affrontare davvero il drammatico carbon footprint della moda.

Spiaggia di rifiuti in Ghana
IL CASO CHANEL
Quasi contemporaneamente al COP27di Sharm el-Sheikh anche a Dakar è accaduto qualcosa di inconsueto. Chanel ha dato vita al suo primo show in Africa, il primo tenutosi nell’Africa sub-sahariana in assoluto. Il Senegal, è un Paese di ex-colonizzazione francese, e un’iniziativa del genere è apparsa coraggiosa quanto controversa: il Paese dove per secoli è fiorita la tratta degli schiavi (abolita nel 1848) conta 17 milioni di abitanti, un tasso di disoccupazione del 99% e un Pil pro capite annuo inferiore al prezzo della maggior parte delle borse Chanel. Occorre precisare che Chanel Métiers d’Art è stato concepito come un festival progettato per mettere in luce i talenti di questo Paese nell’arte, nella danza, nella musica e nella letteratura. Chanel sarà di nuovo a Dakar a gennaio per un programma dove le19M (l’hub a cui fanno riferimento i suoi atelier) in collaborazione con l’Institut Fondamental d’Afrique Noire di Dakar si concentrerà su lavori realizzati con ricamatrici e artigiani locali. A seguire è prevista una mostra a Parigi dove le19M aprirà i suoi atelier per corsi di formazione rivolti a studenti e artigiani senegalesi.
Aldo Premoli
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





