Dal Muralismo messicano alle lotte per i diritti: una grande mostra a New York
Il Whitney Museum di New York ha da poco riaperto le porte e accoglie il pubblico con la mostra che ripercorre la storia del Muralismo tra Messico e Stati Uniti dagli Anni Venti ai Quaranta del secolo scorso. Mettendo in luce dinamiche fortemente attuali.

Fu salutato come il Rinascimento messicano e la sua influenza sull’arte mondiale fu vasta e profonda. Gli anni dell’arte militante, dei murales politici e della narrativa degli oppressi che seguirono la Rivoluzione messicana furono l’età dell’oro per la cultura di un Paese che in quella produzione artistica definiva i canoni dell’estetica a cui affidare l’espressione di una rinnovata identità culturale e politica. Il mondo intellettuale dei vicini Stati Uniti, dove negli stessi anni la cultura materialistica e individualistica si scontrava con la Grande Depressione e iniziava a mostrare i propri dolorosi limiti, non mancò di notare i fermenti culturali messicani, lasciandosene influenzare e riportando a casa pezzi di quell’estetica, di quella narrativa e di quell’impegno politico. Questa storia di incontro tra culture ce la racconta la mostra in corso al Whitney Museum di New York dal titolo Vida Americana: Mexican Muralism and Art in the United States 1925-1945.
IL MURALISMO MESSICANO A NEW YORK
La mostra, che aveva aperto a febbraio solo per chiudere poche settimane dopo a causa del Coronavirus, è una mega antologica composta per esplorare le influenze dei muralisti messicani sull’arte americana del ventennio in questione e allo stesso tempo raccontare le incursioni degli stessi sulla scena culturale statunitense. Oltre 200 opere a firma di più di 60 artisti tra messicani e americani. Dipinti monumentali, serie narrative, studi, riproduzioni di murales, filmati d’epoca, fotografie compongono un affresco di un momento storico che, nel contesto di irrequietezza sociale che gli Stati Uniti stanno vivendo in questo 2020, assume una particolare rilevanza.
Mentre una nuova generazione di artisti portava gli umili e gli oppressi sulle proprie tele, attingendo a piene mani dall’estetica dell’arte indigena, intellettuali di tutto il mondo trovavano una fonte di ispirazione nella Rivoluzione messicana e a frotte accorrevano nella rinnovata nazione per documentare quella rinascita e immergersi nel fermento culturale che aveva prodotto. La mostra racconta quei contributi esponendo, tra l’altro, alcune fotografie di Tina Modotti e Edward Weston e un estratto del film incompiuto di Sergei Eisenstein, Que Via México!. In particolare, artisti e intellettuali americani guardavano al Messico come a una civiltà nuova, ricostruita sulla purezza di un popolo con ferme radici nelle tradizioni e ancora incontaminato dalla civiltà industriale e dalla vita moderna. Il mito del combattente campesino, incarnato nella figura di Emiliano Zapata e immortalato nelle opere dei cosiddetti “tres grandes”, José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros, catturò l’immaginazione del mondo progressista. In questa mostra ricostruiamo la creazione di quel mito in opere come Zapata di Siqueiros (1931) o Barricada e Pancho Villa di Orozco (1931) o ancora The Uprising di Diego Rivera.

Diego Rivera, Flower Festival. Feast of Santa Anita, 1931. MoMA, New York © 2020 Banco de México Diego Rivera Frida Kahlo Museums Trust, Mexico, D.F. – Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © MoMA – Licensed by SCALA – Art Resource, New York
UN’IDENTITÀ NAZIONALE PER IL MESSICO
Fu lo stesso governo riformista di Álvaro Obregón che, nel tentativo di unificare un Paese diviso, fabbricò un’identità nazionale ancorata alla vita rurale, in netta opposizione alla cultura urbana europea. Il supporto del governo alle arti fu cruciale per la creazione di quell’identità. Gli artisti risposero alla chiamata creando pezzi di arte pubblica che eroicizzavano la popolazione rurale e indigena, trasformando la vita quotidiana in monumentali scene epiche pensate per ispirare senso di orgoglio ed educare il popolo. Simbolo di una cultura giovane e forte, in grado di parlare al popolo e aperta alle sperimentazioni divennero i murales, spesso realizzati su commissione pubblica e in alcuni casi frutto di collaborazioni. Opera iconica che racchiude in sé la contaminazione di cui racconta questa mostra è il Mercado Abelardo L. Rodriguez di Città del Messico cui contribuirono dieci artisti di cui quattro americani (Pablo O’Higgins, le sorelle Marion e Grace Greenwood e Isamu Noguchi) e sei messicani (Ramón Alva Guadarrama, Ángel Bracho, Raúl Gamboa, Antonio Pujol, Pedro Rendón e Miguel Tzab Trejo, tutti presi dalla scuola di Diego Rivera). Le opere realizzate sulle pareti interne del mercato, recuperato negli anni intorno al 1934 come centro di aggregazione oltre che per il commercio, sono qui riprodotte da video proiettati a trecentosessanta gradi in una stanza dedicata.
Tutti quegli artisti che dagli Stati Uniti arrivarono in Messico in quegli anni per apprendere e lasciarsi ispirare da queste nuove forme d’arte politicamente impegnate riportarono qualcosa a casa. Molti, frustrati dall’eccesso di influenze intellettuali europee e in cerca di risposte più politiche, guardavano all’arte messicana come a un modello e da questa si lasciarono influenzare, alla ricerca di una composizione figurativa in grado di raccontare le lotte operaie, le battaglie per l’emancipazione dei neri, l’ingiustizia sociale, la povertà, gli abusi di potere.

Philip Evergood, American Tragedy, 1937. Courtesy Harvey and Harvey Ann Ross
L’APPORTO DEGLI ARTISTI AFROAMERICANI
La mostra ci consente di riscoprire una produzione artistica sorprendente e poco raccontata. Artisti di origini afroamericane che faticavano a ottenere riconoscimento, esprimevano il bisogno di vedere la propria storia rappresentata nell’arte, con mezzi espressivi vicini alla sensibilità dei muralisti messicani. Tra questi Jacob Lawrence che affidò a diverse serie di piccole tele la narrazione di eventi drammatici che colpirono la popolazione nera nel primo Novecento. Qui in mostra ci sono alcuni pezzi della sua Migration Series, che racconta la migrazione di massa dei neri americani dal Sud rurale alle città del Nord e che è un meraviglioso esempio di storia orale in forma di pittura. A raccontare l’epica afroamericana anche Aaron Douglas che realizzò una serie di quattro pannelli per la Hall of Negro Life alla Texas Centennial Exposition del 1936 a Dallas. La serie illustrava l’epopea dei popoli africani portati in catene nel continente americano e la progressione verso la liberazione e un futuro sperato di eguali opportunità. Dei pannelli originali ne restano due, entrambi in mostra qui, Aspiration e Into Bondage (1936). Sui progressi della popolazione nera americana si concentra anche la monumentale opera di Charles White qui esposta, Progress of the American Negro: Five Great American Negroes (1939-40), in cui l’artista, che trascorse un periodo di studio e lavoro in Messico, ritrae cinque eroi, simbolo delle lotte afroamericane.
GLI STATI UNITI SECONDO THOMAS HART BENTON
Ma non erano solo gli afroamericani a esplorare l’estetica e l’etica di un’arte che parlava del popolo e al popolo. Artisti come Hugo Gellert, Ben Shahn, Marion Greenwood, Henry Bernstein, Belle Baranceanu, Philip Evergood portavano nelle proprie opere la lotta di classe, il mondo del lavoro, gli ideali progressisti, dipingendo scene di forte modernità e carica politica. Thomas Hart Benton fa un passo oltre e indietro e si cimenta in una narrazione non edulcorata della fondazione dell’America.
Del suo mastodontico American Historical Epic, composto da 14 pannelli realizzati tra il 1920 e il 1928, sono qui esposte sei tele che mostrano come nella versione della storia raccontata da Benton gli Stati Uniti siano nati e abbiano prosperato sullo sfruttamento e la prevaricazione delle popolazioni indigene e degli africani.
La serie di Benton è una delle riscoperte di questa mostra. L’autore infatti ebbe poca fortuna e viene ricordato soprattutto come maestro di Jackson Pollock, ma è proprio in questa connessione che si cela la vera tesi forte dietro questa mostra curata da Barbara Haskell. La chiarisce una delle ultime sale del percorso espositivo, in cui si mette in evidenza come l’influenza dell’arte messicana abbia permeato anche i protagonisti indiscussi del primo Novecento americano. Dell’Espressionismo astratto vengono sempre raccontate le radici e influenze europee, ma al Whitney troviamo una serie di tele di Pollock che ne raccontano i tentativi (a tratti piuttosto goffi) di emulare le atmosfere e la forza espressiva di Orozco. Nel 1936, a New York, Pollock seguì anche un corso tenuto da Siqueiros in cui il messicano insegnava tecniche innovative tra cui colate, schizzi, gocciolamenti. Il raffronto tra alcuni lavori del maestro dell’Espressionismo americano e quelli dei due muralisti messicani non lascia dubbi: quelle influenze venute dal Sud furono cruciali nello sviluppo di una forma d’arte politica nel gesto e nella scala più che nei contenuti, ma intrinsecamente rivoluzionaria.

Jackson Pollock, Landscape with Steer, 1936–37 ca. Museum of Modern Art, New York © 2019 The Pollock-Krasner Foundation – Artists Rights Society (ARS), New York. Photo © The Museum of Modern Art-Licensed by SCALA – Art Resource, NY
AMERICA CHIAMA MESSICO
Ma l’America non si limitò a guardare al Messico: cercò di farlo suo. Moltissimi furono gli artisti messicani che in quegli anni furono chiamati a realizzare opere pubbliche negli Stati Uniti. Questa mostra raccoglie alcuni degli esempi più interessanti esplorando diverse soluzioni per riprodurre tra le pareti di un museo un’arte pubblica destinata al popolo. Grazie a contributi video e lavagnette interattive possiamo immergerci nella corte del Detroit Institute of Arts dipinto da Diego Rivera, mentre in una stanza con studi, prove e riproduzioni possiamo immaginare come sarebbe stato il murale che lo stesso Rivera avrebbe voluto al Rockefeller Center.
E ancora grazie a un’installazione che riproduce gli spazi della caffetteria del Pomona College in California, possiamo godere del Prometheus di José Clemente Orozco (1930), il primo murale realizzato da un messicano negli USA.
In un momento in cui l’America è guidata da un presidente che ha fatto del muro col Messico uno dei capisaldi della sua politica e la comunità nera lotta per trovare voce nella società statunitense, questa mostra sembra poter offrire un contesto storico a forme espressive che ancora oggi lottano per emergere in una cultura dominante che spesso le relega in un ambito folkloristico, ancora condizionato da quel mito della purezza che portò brevemente alle stelle i messicani e i loro murales solo per poi cancellarli sotto colate di paternalismo.
Il Whitney ha riaperto a inizio settembre e fino a fine mese l’ingresso sarà a donazione libera; è consigliato prenotare l’orario di visita. Per chi non fosse a New York, il museo mette a disposizione sul proprio sito Internet un’ampia selezione di materiali digitali sulla mostra.
‒ Maurita Cardone
New York // fino al 31 gennaio 2021
Vida Americana: Mexican Muralism and Art in the United States 1925-1945
WHITNEY MUSEUM OF AMERICAN ART
99 Gansevoort Street
whitney.org
 1 / 23
1 / 23
 2 / 23
2 / 23
 3 / 23
3 / 23
 4 / 23
4 / 23
 5 / 23
5 / 23
 6 / 23
6 / 23
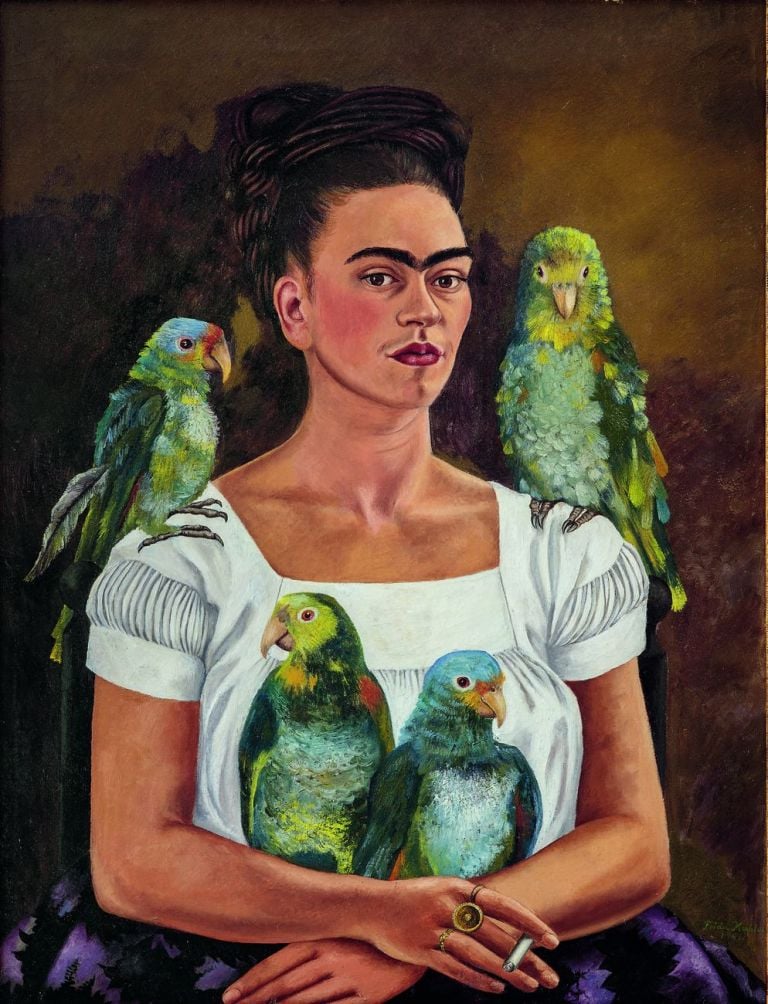 7 / 23
7 / 23
 8 / 23
8 / 23
 9 / 23
9 / 23
 10 / 23
10 / 23
 11 / 23
11 / 23
 12 / 23
12 / 23
 13 / 23
13 / 23
 14 / 23
14 / 23
 15 / 23
15 / 23
 16 / 23
16 / 23
 17 / 23
17 / 23
 18 / 23
18 / 23
 19 / 23
19 / 23
 20 / 23
20 / 23
 21 / 23
21 / 23
 22 / 23
22 / 23
 23 / 23
23 / 23
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati




























