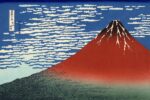Lezioni di critica #13. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (III)
“Più le serie tv conservano le caratteristiche di un Paese, più funzionano”. Questo dice Greg Peters, manager di Netflix. Quando lo capiranno anche gli artisti italiani?

L’artista italiano che non volesse cimentarsi con i miti della globalizzazione, del cosmopolitismo, del multiculturalismo, dei non-luoghi, della post-identità, che arte dovrebbe fare? Il quesito è male impostato, perché non conosce paletti. Quello corretto è il seguente: cosa ha accomunato prodotti di successo e solo in parte agli antipodi come l’Arte Povera e la Transavanguardia, tanto da poter essere adottato anche oggi che l’arte italiana stenta a farsi riconoscere sul mercato internazionale? Due ingredienti fondamentali: 1. l’aver saputo coniugare il genius loci (autentico e fittizio a un tempo) con le tendenze internazionali del momento; 2. l’intelligenza di spacciare tale alchimia per un prodotto made in Italy, esattamente come hanno fatto le declinazioni americane ed europee del fenomeno, il quale fu internazionale o, come userà dire, “glocale”. Bisogna riconoscere come sia stata una negoziazione tra gli stilemi nostrani e gli idiomi internazionali ora poveristi e minimalisti, ora neoespressionisti, ciò che ha decretato lo statuto italo-planetario di artisti come Mario Merz e Francesco Clemente. Un’italianità niente affatto difficile da rintracciare, se sottratta alla chiacchiera dei curatori e ricondotta alla dialettica degli idioletti artistici, è confluita in panorami semiotici di matrice mista, generando una prole robusta come solo l’esogamia sa partorire. Occorre inoltre considerare le due maggiori compagini artistiche del nostro dopoguerra come veri e propri “brand” lanciati sul mercato da due geniali imprenditori: Germano Celant e Achille Bonito Oliva, necessari quanto gli artisti.
A seguire, altrettanto hanno fatto le individualità fai-da-te degli Anni Novanta, presto etichettate come i “Fantastici Quattro” (Maurizio Cattelan, Vanessa Beecroft, Rudolf Stingel e Francesco Vezzoli, con i più modesti Paola Pivi e Piero Golia al seguito), quindi l’inopinata “Transavanguardia Povera” degli Anni Zero e Dieci, che ho introdotto nella mia succinta Stori(ell)a dell’Arte Italiana del nuovo millennio e a cui dedicherò un approfondimento anche promozionale. Attendendo che le tante promesse in lista d’attesa trovino domani un collocamento, si può intanto rilevare come alcuni artisti della penultima generazione (TP) abbiano tradito i “padri” (FQ) rifacendosi ai “nonni” (AP e T), una mossa non solo furba ma obbligata e che, non a caso, ne ha decretato la fortuna. Al contrario, assumendo come paradigmatiche le mostre ospitate al MAMbo e al VII Premio Fabbri, si è visto come gli artisti dell’ultima tornata appaiano in balia di falsi credo e di un’adesione pedissequa allo stile internazionale che, se anche li premia in Italia, rischia di vederli arrancare fuori dai confini nazionali.

Sopra, il curatore italiano come consumatore di giovani artisti. Sotto, le prede spacciate da predatori
STATI DISUNITI DELL’ARTE
Il cosiddetto “International Style”, infatti, facilmente può veicolare l’illusione di un cosmopolitismo finalmente agguantato, di una koinè artistica internazionale che condivide, oltre ai regimi democratici, valori comuni e dunque anche l’arte. Si tratta, appunto, di un’illusione. A ben guardare, gli Stati nazionali che si contendono l’IS sono pochi e relativi a latitudini che vedono coinvolti solo marginalmente i Paesi mediterranei, collocandosi Italia, Spagna e Portogallo a fianco di ex-Iugoslavia, Grecia, Turchia e Maghreb nel fanalino di coda dell’arte che conta (eccezioni individuali a parte).
L’IS è propriamente lo stile ufficioso di un ristretto consorzio di Nazioni nordiche, le quali promuovono politiche neocoloniali in competizione tra loro sotto l’etichetta posticcia della globalizzazione occidentale. Monolitico e proteiforme a un tempo, esso trova in ciascuno Stato la sua declinazione particolare che, a seconda del grado di protezionismo, sarà più o meno pronunciata, anche se aree culturali e confini nazionali coincidono fino a un certo punto. Se da un lato c’è uno stile statunitense ben riconoscibile pur nell’estrema varietà (parliamo di un vero continente), dall’altro c’è un’Europa che si può suddividere in cinque macro-aree stilisticamente individuabili: l’Inghilterra (più degli altri Stati influenzata dagli USA), l’area mitteleuropea, quella scandinava, quella est-europea e quella balcanica. Questi areali si spartiscono un’arte che poi così cosmopolita non è, perché contempla “di sfuggita” i Paesi mediterranei.
TU VUÒ FA’ L’AMERICANO…
Il Belpaese onora con idolatria ed epigonismo il primato dei cugini nordici, facendo di tutto per non essere una Nazione come le altre, ma sempre e solo un coacervo di campanili. Il rovescio della nostra esterofilia è infatti il provincialismo: scimmiottare l’arte straniera comporta il rinnegare i propri retaggi così come, sul territorio, l’artista della gilda altrui. Al manierismo internazionale d’inizio millennio non sfugge nessuno, America e Nord Europa possono esportare il Neo-Primitivismo, il Neo-Surrealismo, il Neo-Concettuale, il Neo-Geometrico, il Neo-Pop, il Neo-Minimalismo, ma noi no, vietato commerciare la Neo-Metafisica, il Neo-Spazialismo, il Neo-Poverismo, la Neo-Transavanguardia.
Ci confidava Luciano Fabro nel 1998 che gli unici artisti italiani degni di nota erano Maurizio Cattelan e Vanessa Beecroft, perché gli altri guardavano ai maestri. Aveva torto e ragione a un tempo. Torto perché perfino lui era vittima di questa visione provinciale per cui un maestro non deve figliare delle somiglianze ma solo delle differenze (il che è del tutto incongruo), e ragione perché Cattelan e Beecroft sono la differenza personificata, l’eccezione che conferma la regola. Dopo di loro, l’humus artistico peninsulare si è riscoperto in sintonia con una temperie artistica con qualche soluzione di continuità, ma pervicace, e per di più puntuale rispetto al generale ritorno all’ordine post-11 Settembre. Nei primi due decenni del nuovo millennio non si è scommesso sulla “nostra”, di nostalgia, temperandone al contempo gli eccessi frutto di un’isteria identitaria pari e contraria all’esterofilia.
Il provincialismo italiano è talmente radicato nelle coscienze di artisti e addetti ai lavori, da trasparire anche in un vecchio articolo di Francesco Bonami dedicato, paradossalmente, al provincialismo italiano. La soluzione ivi professata che l’arte italiana, per riscattarsi, debba troncare con la propria tradizione, andrebbe respinta al mittente perché falsa e impraticabile. Un artista di qualsivoglia nazionalità ha infatti tre opzioni a disposizione: o tradisce radicalmente le proprie radici trasferendosi all’estero, ché pretendere di farlo in casa è velleitario; o reinterpreta il genius loci del suo areale d’appartenenza, rinnovandolo per quanto riesce; o si accontenta di fare il clone, nazionale o esterofilo che sia. È chiaro come un Paese intero non possa che dividersi tra la seconda e la terza opzione, e che millantare la prima per tutti è tradire un principio di realtà disorientando in toto la popolazione degli artisti.

A sinistra, lo scrittore Roberto Saviano. A destra, un quadro dell’italianissimo Pietro Roccasalva esposto nella sede londinese di Massimo De Carlo
UNA RICETTA DIFFICILE MA REALISTICA
Gli artisti di qualsivoglia Paese, proprio perché prendono continuamente l’aereo, dovrebbero valorizzare le radici che pure calpestano, non rimuoverle. Esse non vanno rintracciate in astratte categorie per ciò stesso inattingibili, come più di un curatore mostra di (fra)intendere, ma in modelli in carne e ossa che è bene risiedano nel proprio areale d’appartenenza. A partire dalla constatazione che il Belpaese non è allineato con gli areali che contano, pensare di fare un’arte internazionale svincolata dai propri vessilli è l’illusione di un falso cosmopolitismo, e infatti chi ci casca viaggia tutt’altro che a gonfie vele. Si può anche produrre olio extravergine in Norvegia, ma essendo un prodotto mediterraneo, quello spremuto in Italia sarà più ricercato. L’inverso vale, evidentemente, per le merci estere clonate sul suolo italiano, difficilmente ri-esportabili. Il problema dell’incerta identità dell’arte contemporanea italiana e del suo scarso appeal sui mercati internazionali non può essere eluso con l’idea che l’identità sia un miraggio, perché non c’è commercio senza etichette. A meno di eccedere l’impersonalità come Claire Fontaine o Darren Bader (l’anonimato brevettato è pur sempre un marchio), l’unica soluzione è riconsiderare le peculiarità del proprio areale come un esotismo, e non come un’onta imperdonabile, promuovendo nuovamente un’identità “glocale” sull’esempio non solo dei campioni della nostra tradizione, ma anche di Ai Weiwei e Chris Ofili. Ragionare in termini di brand è l’unica ricetta praticabile da qualsivoglia artista, e per quello italiano consiste innanzitutto nel ridurre la forbice tra l’opera e la sua narrazione, quindi nel rinverdire “memi” identitari in letargo. Le pratiche di ibridazione e postproduzione, oggi all’iperbole ma in realtà di casa di ogni epoca storica, non sono affatto in contraddizione con una difesa dell’identità artistica, anzi, il plagio di ricette estere può essere scongiurato solo avendo chiara la distinzione tra gli ingredienti d’importazione e i propri, da miscelare con cognizione e un protezionismo almeno al 51%. Ancora non ne siete convinti?
A dar retta al manager Netflix, Greg Peters, “più le serie tv conservano le caratteristiche di un Paese, più funzionano”. Se Paolo Sorrentino ha sbancato in America, è perché ha saputo coniugare Fellini con Linch e Scorsese senza scimmiottare il cinema d’oltreoceano. Lucio Battisti è tra i prediletti di Sir Paul MacCartney perché ha saputo fondere blues, rock e folk con il melodico italiano, così Ferretti con il punk, Vasco con l’hard-rock, Battiato con new-wave e psichedelia. In letteratura Eco e Saviano, pur debitori rispettivamente di Borges e Camus, sono due brand mondiali perché italianissimi. Anche per quanto riguarda l’arte il sistema internazionale non si aspetta l’equivalente di una pizza, ma di sofisticate ricette by Pierangelini, Cracco, Vissani, che non disdegnano di giustapporre i sapori esotici e mediterranei. Dopo di che se gli artisti italiani, per assecondare i palati dei loro curatori, vogliono continuare a produrre würstel e hamburger infarciti d’ideologia, facciano pure, ne pagheranno le conseguenze. Non così i loro commensali, che fanno carriera nonostante i sapori senza stelle dell’arte che consumano.
– Roberto Ago
Lezioni di critica #1. La sindrome di Warburg
Lezioni di critica #2. Adriano Altamira e il detour del generale Druot
Lezioni di critica #3. Maurizio Cattelan e il culto occulto
Lezioni di critica #4. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (I)
Lezioni di critica #5. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (II)
Lezioni di critica #6. Stori(ell)a dell’Arte Italiana d’inizio millennio (III)
Lezioni di critica #7. Come si giudica un’icona
Lezioni di critica #8. Istruzioni per un’arte politicizzata (I)
Lezioni di critica #9. Istruzioni per un’arte politicizzata (II)
Lezioni di critica #10. Scappate dall’Italia!
Lezioni di critica #11. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (I)
Lezioni di critica #12. Sull’incompetenza dell’arte e della curatela italiane (II)
 1 / 4
1 / 4
 2 / 4
2 / 4
 3 / 4
3 / 4
 4 / 4
4 / 4
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati