Non sarà il self-publishing ad uccidere il mercato italiano dell’editoria. O forse sì?
Passando dal 2 al 7% delle produzioni, il self-publishing sembra minacciare ogni giorno di più il mercato dell’editoria. Tuttavia, prima di trarre affrettate conclusioni, è bene analizzare a fondo la situazione, cercando di capire dove stia realmente il problema strategico degli editori
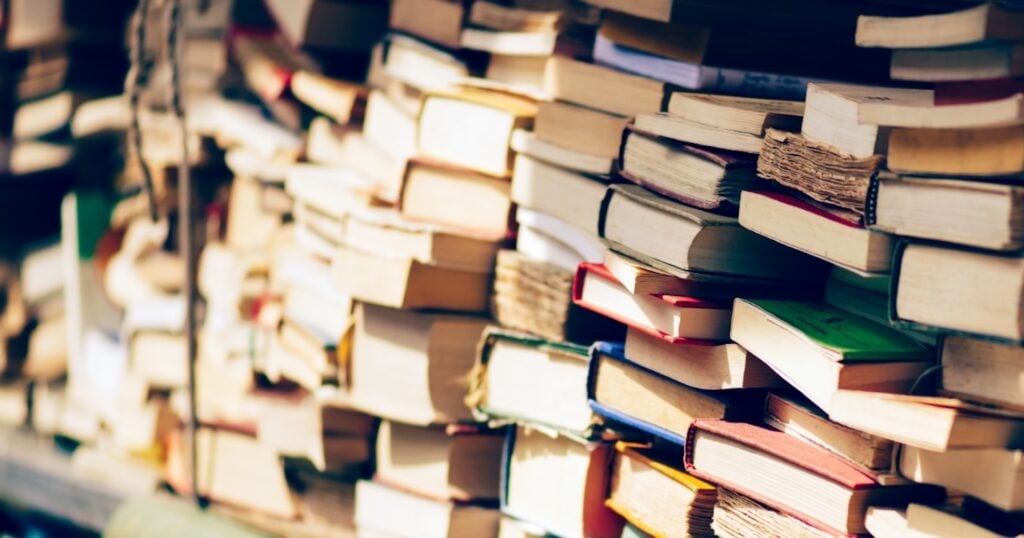
La disintermediazione pare colpire in modo sempre più evidente anche l’editoria. Secondo dati riportati dal Secolo D’Italia, nel nostro Paese, negli ultimi anni, il self-publishing ha mostrato una crescita importante, passando dal 2 al 7% delle produzioni. Un dato che tuttavia va letto nella sua completezza per essere realmente compreso, perché sono numerose le variabili da tenere in considerazione. Analizziamo nel dettaglio la situazione prima di trarre (affrettate) conclusioni.
La qualità delle pubblicazioni nel mercato del self-publishing italiano
In primo luogo, la dimensione qualitativa delle pubblicazioni. In alcuni casi si tratta di tentativi di speculazione con testi prettamente elaborati dalle intelligenze artificiali, in altri casi opere di pura vanità. L’autopubblicazione raccoglie tantissimi libri che probabilmente non avrebbero superato una selezione editoriale vera e propria. Esistono delle eccezioni, che ottengono anche grande esito, ma si tratta di eccezioni, appunto, in un oceano di cattive proposte, e che spesso sono sostenute da una grandissima attenzione alla promozione online, soprattutto attraverso i principali social network.
Un nuovo senso per l’editoria in Italia
Eccezioni a parte, l’editoria nel suo complesso ha tanto da riflettere da questi casi: come per ogni altro settore, infatti, l’autopubblicazione, e quindi la disintermediazione, si combatte soltanto ricercando un nuovo “senso”per quegli intermediari (gli editori), che sinora hanno sempre detenuto un potere importante all’interno della filiera di produzione del valore di un determinato settore. Allo stato attuale, il ruolo che l’editoria pare essersi conquistato nei confronti del fenomeno è quello di certificatrice di qualità: gli esordienti online ottengono successi e poi, notati dagli editori, raccolgono contratti. Nel frattempo, molte case editrici pare stiano sviluppando una medesima politica di autofinanziamento, chiedendo un contributo per la pubblicazione o un numero di volumi certi di venduto. È ora di immaginare nuovi ruoli e nuove strategie per intercettare i reali autori di valore: perché se da un lato il self-publishing può essere meritorio perché lascia ai lettori (attraverso gli acquisti) il potere di decidere quali siano le proposte meritevoli o meno, è anche vero che tantissimi capolavori della letteratura, così come tantissime produzioni editoriali contemporanee, non nascono con la volontà di divenire best-seller e richiedono ancora una lettura critica, e competente. Non sono rare, del resto, vicende in cui aspiranti autori hanno ricevuto molteplici rifiuti da parte di case editrici prima di pubblicare il loro primo libro e poi diventare degli scrittori affermati: da J.K. Rowling a Stephen King, passando per John Grisham e molti altri. I casi sono così numerosi da rendere d’uso comune l’idea che sia naturale ricevere numerosi rifiuti prima di vedersi pubblicare un libro e che la perseveranza sia una dote essenziale che un aspirante scrittore deve possedere.
Il valore perso dei “rifiuti”
Per quanto risulti ormai pienamente condiviso questo pensiero, in realtà nasconde un’inefficienza diffusa. Al netto degli errori di proposta, e vale a dire quegli invii che vengono destinati ad editori che pubblicano testi di natura diversa rispetto al testo che si intende proporre, è evidente che ciascun rifiuto, se deve essere accettato da parte dell’autore come un passaggio evolutivo, rappresenta anche una perdita importante per la casa editrice, sia in termini economici, sia in termini di credibilità.
Perché se è possibile stampare in autopubblicazione i propri testi (e negli stati uniti il numero di self-published è passato da circa 85mila del 2008 a circa 1 milione e 700 mila nel 2018), allora la casa editrice non si può semplicemente limitare ad offrire i “mezzi” di produzione.
Soprattutto se nel frattempo attraverso Amazon e la promozione sui social, è possibile accedere a canali di distribuzione e vendita alternativi a quelli cui può accedere una editrice tradizionale. Certo, un libro pubblicato da una casa editrice risulta ancora più autorevole, ma questo è vero per coloro che sono cresciuti nel corso del Novecento, secolo in cui gli “intermediari culturali” avevano un peso differente. Chi invece nasce in un momento storico in cui la popolarità di un autore o di un libro si misura non solo dal “voto” delle recensioni, ma anche dal “numero” di quelle recensioni, potrà trovare sufficientemente autorevole un libro pubblicato con i servizi online, che però è stato letto e consigliato da migliaia e migliaia di lettori. A maggior ragione se, poi, le autorevoli case editrici si limitano a “seguire” i fenomeni letterari, o rifiutano per dozzine di volte un autore che poi diventerà di successo. Questo mostra una certa debolezza nella loro capacità di selezione.

Il nuovo ruolo degli editori nella competizione con il self-publishing
Risulta quindi essenziale comprendere che ruolo debbano avere gli editori in questo particolare mercato, atteso che nel 2021, quindi nel primo anno dopo la pandemia, è stata aperta quasi una nuova società editrice al giorno, e che stando a quanto affermato da Fabio del Giudice – Direttore AIE – al termine di quell’anno, le editrici attive erano più di 5mila. Una strada è quella dell’attesa: gli editori osservano i trend online e sottoscrivono contratti con chi inizia ad acquisire un certo seguito nell’esercito degli auto-pubblicati. Si tratta di una strada possibile, che tuttavia riduce l’eterogeneità delle proposte, andando a ricercare esclusivamente coloro che producono testi che piacciono al maggior numero di persone. Un approccio in qualche modo corretto nel breve periodo, ma che toglie credibilità e capacità di intercettare pubblici di nicchia, che preferiranno sempre più cercare in modo autonomo le nuove proposte piuttosto che andare in libreria. Se infatti sono divenuti ormai completamente democratici i mezzi per pubblicare, per distribuire e per vendere, e se le case editrici non sviluppano un importante valore aggiunto rispetto a chi si pubblica da solo su Amazon, a che serviranno le case editrici tra vent’anni? Quale ruolo avranno nella generale cultura che sarà allora contemporanea? Sono riflessioni che è necessario fare adesso, perché se non si sceglie che direzione assumere, è chiaro che sarà la corrente a dettare le regole. E non pare che il vento soffi a favore degli editori.
Stefano Monti
Libri consigliati:
(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





