Cosa può fare l’arte per salvare il pianeta?
Da sempre gli artisti reagiscono alle dinamiche e alle urgenze del presente. Ma come stanno rispondendo al cambiamento climatico e all’esaurimento delle risorse ambientali? Un confronto tra l’artista Rebecca Horn e la filosofa Donna Haraway, caposcuola della teoria del cyberfemminismo, chiarisce le linee di un pensiero parallelo
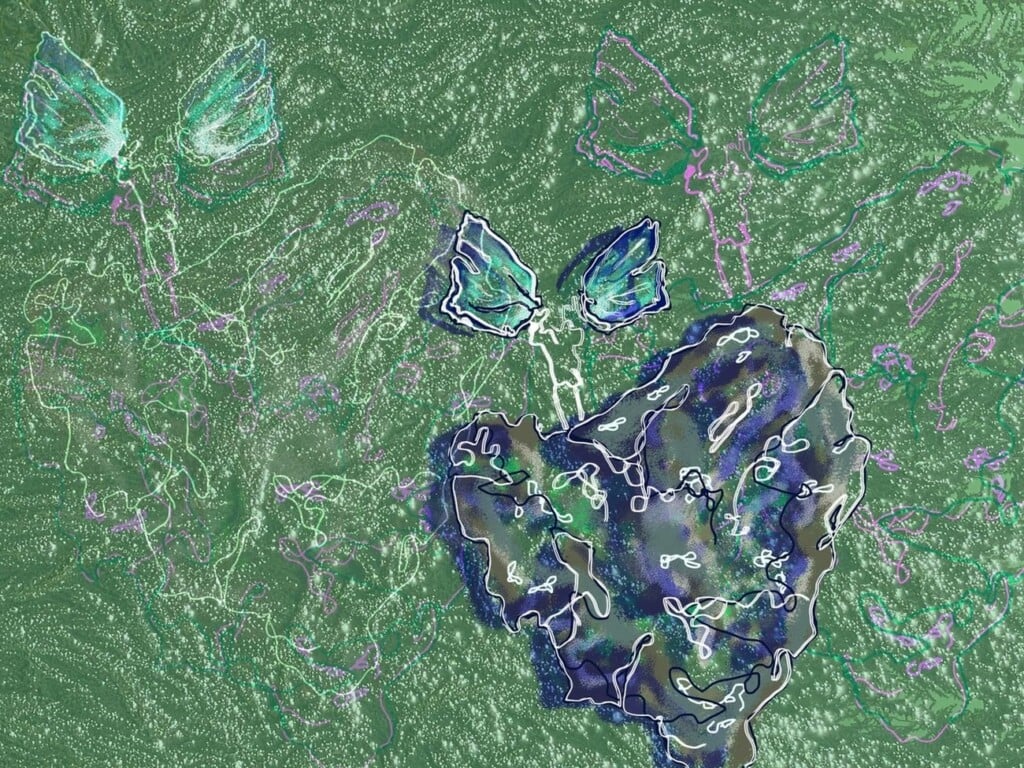
Nell’ormai attuale e inoltrata era della crisi climatica, avviata nel 1971, l’uomo vive in un costante debito con il suo pianeta (cfr. Stefano Mancuso, La nazione delle piante, Laterza, Bari 2019, articolo 06).
Fino al 1970 la specie umana come abitante della Terra è stata sostenibile, L’EOD, l’Earth Overshoot Day, cioè il giorno del debito ecologico, in cui l’umanità inizia a consumare risorse che non saranno più rinnovabili ‒ avendo esaurito tutte quelle che gli ecosistemi terrestri sono stati in grado di rigenerare per quello stesso anno ‒, coincideva esattamente con il 31 dicembre. Già nel 1971 arrivò in anticipo, il 21 dicembre, nel 2000 il 23 settembre, fino al 2022, in cui l’EOD si è verificato lo scorso 28 luglio, un giorno in anticipo rispetto al 2021.
Nei primi decenni successivi a questo cambiamento, come accade per ogni evento decisivo per la collettività, l’arte inizia a evidenziare le problematiche che rispecchiano il suo presente.
Ma oggi a che punto siamo? Quanta teoria, scienza e arte dobbiamo mettere in scena prima di ottenere dei cambiamenti radicali, che partano dalla piccola realtà di ogni singola e autonoma soggettività fino ad arrivare alle grandi potenze?
Da sempre scienza, filosofia e arte lavorano per la creazione di suggerimenti, che sta a noi saper cogliere per creare metamorfosi efficaci.

Rebecca Horn, Fingerhandschuhe, 1972 Épreuve gélatino-argentique, 80 x 60 cm, photographe Achim Thode, collection privée. Rebecca Horn Workshop
© Rebecca Horn / ADAGP, Paris 2019 © Droits réservés.
Rebecca
L’ARTE SECONDO REBECCA HORN
Ingranaggi e metalli ricalcano le orme della natura. Si percepisce la volontà di evocazione e provocazione simultaneamente. Dolore e conforto aleggiano nell’aria, si mischiano, sono in circolo, come fossero sensazioni respirabili. Un ossimoro continuo avvolge lo spettatore nella stanza.
Tubi ramati si espandono dal basso verso l’alto con un andamento curvilineo, ogni tanto intervallati da fascette metalliche, una base meccanica alimentata dalla corrente porta i tubi ad alzarsi e abbassarsi con un andamento sinuoso, come rami d’arbusto mossi dal vento. Il loro movimento sembra quello di un essere stanco, come se l’opera avesse la consapevolezza di dover continuare a sopportare quel ritmo perpetuo all’infinito. Le componenti di metallo ramato sono lucide e luminose, suggeriscono carica energetica, probabilmente per via delle proprietà intrinseche del materiale, conduttore di energia. Nelle prossimità delle pareti ci sono coni di vetro sparsi contenenti polvere di carbone, simbolo del fuoco, elemento potente e vibrante. Farfalle con ali blu scandiscono il tempo, con un movimento lento e meccanico, ancora una volta un andamento potenzialmente atemporale e infinito simula la vita di un essere che invece non lo è. I lepidotteri robotici poggiano leggiadri su rocce vulcaniche, questa volta l’elemento naturale è reale, anche se composto da materia inorganica. Risuonano nell’ambiente delle voci trasportate dal vento, sono i lamenti di persone in viaggio, ognuna con il proprio carico di preoccupazioni. Specchi circolari riflettono ciò che accade intorno, il corpo dello spettatore diventa parte dell’opera, il soggetto che la rende attiva e la anima.
Questa è una possibile visione di un ambiente pulsante, dove trovano dimora le opere realizzate da Rebecca Horn (Michelstadt, 1944). Non c’è più la presenza dell’artista, come accadeva nei primi lavori performativi, volti all’esplorazione dello spazio attraverso il proprio corpo e l’uso di protesi. In questo caso è centrale il tema del naturale, soprattutto nelle opere realizzate dalla fine degli Anni Ottanta a oggi.

Rebecca Horn, Blue Butterfly, 2017, acciaio, vetro, pietra, pigmento blu, farfalla, bastoncini di ottone, matita blu, ciotola di vetro. Photo © Luciano e Marco Pedicini. Courtesy collezione privata, Napoli
LA STORIA DI REBECCA HORN
L’artista tedesca ha iniziato la sua pratica intorno agli Anni Settanta, esplorando lo spazio, proprio nel momento in cui la Fenomenologia della percezione (1945) di Maurice Merleau-Ponty era appena stato tradotto in inglese, e le risorse del pianeta Terra iniziavano a essere in pericolo. Diventando celebre per le sue body extension – in cui si relaziona con lo spazio attraverso protesi, busti, bozzoli, piume, coni, tutti elementi usati come estensioni del suo corpo, appunto ‒ si è dimostrata un’artista sempre al passo con il tempo, perspicace e pronta a catturare elementi problematici del suo contemporaneo, per trasformarli in gesti creativi e critici.
Negli ultimi anni della sua produzione, sono gli oggetti a prendere vita. Il carico di responsabilità, rispetto a tematiche che risuonano nel quotidiano ‒ in cui l’armonia tra natura e artificio è sempre più precaria ‒, viene scaricata sull’oggetto. Questo imita la natura, al pari di un proxy, ma senza mai riuscire davvero a ingannare chi lo osserva. Ogni elemento sembra essere al suo posto e in bilico contemporaneamente, su un filo teso, alla ricerca di un equilibrio universale, in cui organico e meccanico si scambiano di funzione.
Lo spazio assume sembianze diverse. Se prima era Horn a muoversi nell’ambiente, modificando il suo corpo con l’uso di protesi, adesso sono gli elementi artificiali dalle sembianze vegetali a renderlo fervido. La sua è una denuncia verso l’uomo e un inno nei confronti del mondo naturale messo in pericolo. Il corpo diventa man mano rarefatto, per lasciare spazio a meccanismi che fanno visualizzare la coesistenza di elementi organici e di dispositivi. La sostituzione è centrale, così come lo scambio, ma le macchine non sono demonizzate, si percepisce quasi una comprensione nei loro confronti, a tal punto da attribuire loro caratteristiche naturali. C’è la ricerca di un compromesso per la convivenza degli opposti.

Donna Haraway
IL CONFRONTO TRA REBECCA HORN E DONNA HARAWAY
Considerando gli ultimi anni vissuti e la nuova realtà in cui siamo immersi, le tematiche che tocca Rebecca Horn sono ancora attuali e non superate. La combinazione tra macchina e essere vivente è vivida più che mai e la ricerca di un equilibrio per la convivenza di due elementi, di cui evidentemente non possiamo fare a meno, è sicuramente necessaria.
Così il parallelo con le teorie della filosofa statunitense Donna Haraway (Denver, 1944), sembra imprescindibile: dallo Chthulucene al pensiero tentacolare alle creature ctonie, fino alla farfalla monarca delle piccole Camille, il richiamo è evidente.
Haraway traccia la via per un mondo in cui la coesistenza mantiene in vita gli organismi viventi in modo reciproco, generando parentele. Rebecca Horn anima l’inanimato. Una teoricamente, l’altra praticamente e visivamente, Horn e Haraway affrontano i problemi dell’impatto umano sul resto degli organismi viventi.
Nelle sue ultime teorie, Donna Haraway pone come interesse primario, rispetto alle tematiche ecologiste, il restare a contatto con il problema, pensare all’impatto catastrofico dell’uomo sull’ecosistema, e quindi dell’Antropocene, senza mitizzare il passato o imprimere tutte le speranze sul futuro.
Pensare alla posizione attuale che si occupa è fondamentale per mettere a fuoco il problema, rendendo limpida la visione.
Un concetto importantissimo alla base di queste teorie è quello della response-ability (Donna Haraway, Chthuucene, terza edizione, Nero, Roma 2020, pagg. 7, 58), cioè l’abilità di generare risposte alle urgenze del tempo presente. E quindi creare parentele con tutti gli organismi che popolano la Terra, adottando una visione orizzontale in cui umano e non umano si guardano e ascoltano muovendosi sullo stesso gradino, abbattendo la solita, quanto obsoleta, piramide di priorità in cui l’uomo si identifica sempre al primo posto, autoproclamandosi come specie superiore.
In una poesia del 1992 Rebecca Horn scrive:
“GET UP FOR FULL MOON
Free yourself from the icebox
eat the lilies till you vaporize
howl like a wolf
allow black swans to skate on ice
drink the light of mercury
take off your clothes
grab your sex
and dance”
Rebecca Horn, The vertebrae oracle, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2014.
Pochi versi immergono il lettore in una escalation di sensazioni, accompagnandolo in una crescente e progressiva liberazione. L’invito dell’artista sembra essere quello di abbandonare una condizione iniziale glaciale, di imprigionamento da se stessi, per sciogliersi, fino a vaporizzarsi, attraverso l’incontro con organismi inumani ma viventi.
Così la natura e l’animale diventano la guida per un nuovo corpo evacuato dalla sua forma più rigida.
Ogni verso intensifica questo rapporto interspecie, rendendo la figura umana e carnale quasi liquida o aerosa, pronta a generare scambi con il diverso da sé. Proprio come accade con l’humusità che introduce Haraway, in cui la “specie superiore” diventa compost, humus, cioè uno stare al mondo generativo, batterico, stratificato e sostenibile, in cui dalla Terra si può osservare il cielo che non è ancora caduto.
“Compostare è sexy!”
‒ Alessandra La Marca
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati




