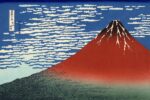Il teatro che fa sentire a casa. Intervista a Deflorian/Tagliarini
Daria Deflorian, Antonio Tagliarini e Francesco Alberici descrivono il loro approccio alle arti performative. A partire da una riflessione su Michelangelo Antonioni.

Due spettacoli ispirati a Il Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni, una tournée internazionale (di recente sbarcata in Canada), un lavoro di ricerca minuzioso: dopo il successo di Quasi Niente e la rappresentazione del suo spin-off Scavi, andato in scena nell’edizione da poco conclusa del Festival FOG Triennale Milano Performing Arts, abbiamo incontrato Daria Deflorian, Antonio Tagliarini e Francesco Alberici, autori e interpreti di questa accuratissima indagine teatrale: la parola alle persone dietro ai personaggi.
La sensazione più forte che arriva vedendovi in scena è quella di essere al sicuro, in compagnia di persone in un certo senso fidate, che hanno voglia di raccontarsi: vi ritrovate in queste considerazioni? Che cosa pensate e in che cosa credete quando create uno spettacolo?
Daria Deflorian: Nella fase di creazione siamo sempre almeno in due, io e Antonio, anzi negli ultimi progetti il gruppo di lavoro è ancora più ampio. Questa condizione ci porta a basare fin dall’inizio il nostro lavoro sull’apertura verso l’altro e sull’ascolto reciproco. Il desiderio di condivisione e di compartecipazione è fortemente presente, quindi, in ogni fase creativa, anche la più teorica: una volta in scena questo nostro desiderio si apre a tutta la platea, ci piace pensare che lo spazio scenico finisca dietro l’ultima fila di sedie.
Antonio Tagliarini: Ogni creazione si attiva con una lunga e profonda indagine intorno alla tematica che scegliamo, un processo di ricerca che prima di tutto riguarda noi stessi e il mondo e poi, naturalmente, si allarga alla scena. Questo modo di lavorare fa sì che dentro le figure in scena si trovi sempre una parte di noi, della nostra storia o del nostro carattere, siamo dunque noi a metterci prima di tutto in discussione con le nostre fragilità e contraddizioni. Anche se l’incontro e la reazione del pubblico è sempre (e per fortuna) qualcosa di imprevedibile, in genere cerchiamo di costruire una relazione sincera col pubblico e questo lo pone in una zona di fiducia, di ascolto e dunque partecipata.

Deflorian/Tagliarini, Reality, photo Silvia Gelli
Gli ultimi due spettacoli che avete portato in scena sono nati intorno a uno studio profondissimo di Deserto Rosso di Michelangelo Antonioni: da dove nasce questa piccola ossessione?
A. T.: Abbiamo riscoperto Deserto Rosso quando stavamo lavorando a Il cielo non è un fondale: per quello spettacolo stavamo approfondendo la relazione fra paesaggio e figura. Abbiamo immediatamente capito che a questo film avremmo dedicato una ricerca e una creazione esclusiva. Antonioni ha rivoluzionato il concetto di sguardo nel cinema: l’uso della telecamera e del montaggio dà modo di osservare i personaggi e il paesaggio in maniera molto più simile a come avviene nella realtà. Il teatro ha invece altre regole di visione per cui il confronto con il cinema di Antonioni è stato per noi un’occasione di crescita proprio sulla questione dello sguardo. Abbiamo passato giorni a leggere le diverse sceneggiature di Deserto Rosso nell’archivio dedicato al maestro ferrarese, ci siamo concentrati sul personaggio di Giuliana, interpretato dalla grandissima Monica Vitti, e dopo mesi di lavoro sono nati i due spettacoli Quasi Niente e Scavi.
Proprio Giuliana/Monica Vitti ha una presenza decisamente cruciale sia in Quasi Niente che in Scavi: che cosa vi ha fatto innamorare di lei?
D. D.: Giuliana rientra perfettamente in quelle “figure fragili” che sono state fin dall’inizio della nostra collaborazione ‒ anche senza deciderlo razionalmente ‒ l’oggetto di studio di tutti i nostri lavori: nonostante la sua bellezza abbagliante, nonostante viva in condizioni di benessere e non abbia alcun disagio apparente, Giuliana ha una complessità e un movimento interiori enormi, che la rendono un personaggio instabile, in continua evoluzione. Questo tipo di personalità ci ha sempre affascinato e catturato: ci interroghiamo dunque non solo su come comprendere le fragilità nostre e delle figure che osserviamo, ma anche su come imparare a proteggerle per non lasciare che vengano fagocitate a contatto con il mondo poiché le consideriamo una grande ricchezza, un punto di vista dal quale osservare sé stessi e gli altri.
Da parecchio tempo tu e Antonio vi occupate di formazione attraverso laboratori e incontri: che cosa pensate sia importante trasmettere alle persone che desiderano imparare da voi?
D. D.: Occuparsi di formazione è innanzitutto un atto di responsabilità, perché il rischio di essere presi come modelli in un percorso formativo è molto alto: questo da una parte è inevitabile, dall’altra appunto è rischioso, perché mette in moto un processo di imitazione. Quello che a noi preme è invece preservare la diversità di ciascuno. Non abbiamo pretese di insegnare un metodo di recitazione, nei nostri laboratori proponiamo un lavoro molto simile alla sala prove: in genere presentiamo domande relative agli spettacoli ai quali stiamo lavorando in quel momento oppure chiediamo agli allievi di portare un progetto, un desiderio di teatro che li sta abitando. Lasciamo ai partecipanti estrema libertà di elaborazione: la restituzione che ne deriva è fortemente vivificante per il nostro lavoro, tanto che viene continuamente ribaltata la questione tra chi sta dando e chi sta ricevendo.
Francesco Alberici: La mia presenza in compagnia è frutto proprio di uno di questi laboratori, il modo di lavorare di Daria e Antonio è basato sulla fiducia effettiva e sulla parità dei rapporti in sala. Entrambi si mettono in una condizione di osservazione e di ricerca della bellezza in ciascun partecipante, non esiste una verticalità di rapporti né alcun insegnamento dall’alto, viene dato il tempo di elaborare un tema e di restituirlo secondo la propria sensibilità, cosa che effettivamente esclude qualsiasi rischio di imitazione a favore di un risultato più sincero e personale.

Deflorian/Tagliarini, Quasi Niente, photo Claudia Pajewski
Lavorare nel mondo del teatro è molto difficile, in particolare nel nostro Paese, dove spesso si riscontrano molti ostacoli legati alla scarsa retribuzione, che probabilmente dipende dalla poca richiesta rispetto all’offerta. Se vi chiedessero perché valga comunque la pena di fare teatro, che cosa rispondereste?
D. D.: Penso che la situazione che descrivi sia più o meno sempre esistita, in più la generale crisi di lavoro e di economie per chi lavora ha peggiorato ulteriormente il quadro. Avviene per forza una selezione naturale che fa sì che emerga chi ha una vera e continua necessità di esprimersi, comunicare e condividere, magari facendo anche altri lavori per molto tempo. Vale la pena continuare a fare teatro perché facciamo un lavoro bellissimo ma questo, lo dico spesso ai miei allievi, dipende molto dalla qualità degli incontri che facciamo: dobbiamo andare a cercare le persone che ci piacciono e non subire solo le occasioni che arrivano.
F. A.: Questa è una domanda che spesso viene posta agli artisti. Io vorrei riportare le parole di due grandi personalità, parole nelle quali mi ritrovo e che condivido perfettamente. Il primo è il regista cinematografico Werner Herzog, il quale consiglia di leggere tanto, per avere il cervello sempre attivo e rimanere giovani tutta la vita. Il secondo è Danio Manfredini, che dichiara che il mestiere dall’attore è una vera e propria vocazione, e che di questa cosa si debba prima o poi venire a capo.
Fra i vari tour e laboratori che avete in programma, state pensando alla vostra nuova creazione?
D. D.: Assolutamente sì, in questo momento sentiamo il bisogno da un lato di prenderci una pausa dallo stare sempre in scena nei nostri progetti, dall’altro stiamo cercando di capire come ri-attraversare una nostra scrittura originale: il primo desiderio si è concretizzato in un lavoro che debutterà nel 2020 al Festival VIE di Modena e che vedrà in scena Francesco Alberici sul testo di Edouard Louis Chi ha ucciso mio padre?. Per il 2021, invece, abbiamo già cominciato le prime indagini per un lavoro attorno alle due figure protagoniste di Ginger e Fred di Federico Fellini, un progetto legato proprio al tema della vocazione e del sogno artistico: un’occasione per riflettere ancora sulla fragilità, stavolta su quella dell’artista di fronte alle regole del mercato.
‒ Giada Vailati
 1 / 8
1 / 8
 2 / 8
2 / 8
 3 / 8
3 / 8
 4 / 8
4 / 8
 5 / 8
5 / 8
 6 / 8
6 / 8
 7 / 8
7 / 8
 8 / 8
8 / 8
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati