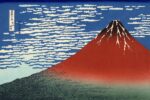Oltre Fantocci. In ricordo di Paolo Villaggio
A un giorno dalla scomparsa di Paolo Villaggio, Christian Caliandro riflette su uno dei personaggi più celebri fra quelli interpretati dall’attore genovese, il ragionier Ugo Fantozzi. Emblema di una cattiveria ben lontana dagli stereotipi che lo accompagnano.

Da bambino facevo le imitazioni di Fantozzi per i miei parenti, in continuazione. Per esempio, nel patio della villa al mare sconcertavo mia nonna, mio padre e mio zio (ma non mia madre, che rideva di gusto) con interminabili gag che avevano per argomento unico e solo l’identità del personaggio inventato da Paolo Villaggio, prima in letteratura e poi al cinema. Avevo amici praticamente analfabeti che possedevano tutte le copie dei suoi libri (che io sono riuscito a trovare solo molto dopo), incredibilmente gualciti dal troppo uso e disposti su miseri, tristi scaffali di legno grezzo. Le prime due videocassette mai possedute con mio fratello (le chiedemmo in regalo, insieme al videoregistratore, nel Natale 1986) furono proprio Il secondo tragico Fantozzi e Rocky III: le consumammo quasi del tutto a furia di mandare avanti e indietro col telecomando, in cerca delle scene da memorizzare e ripetere ripetere ripetere, mimandole e recitandole a ogni ora del pomeriggio. Se ne va l’ultimo pezzo della mia infanzia, così come quello di moltissimi altri italiani…
***
Ma che pezzo è? Di che identità si tratta, e perché mi incuriosiva tanto anche da piccolo, così come adesso?
Fantozzi non era buono. Ma proprio per niente. Lo poteva sembrare, se uno lanciava solo uno sguardo superficiale alla narrazione di cui era protagonista; ma non lo era affatto. Era crudele come e più dei suoi colleghi-vessatori, come e più di Calboni (a proposito: siamo tutti Calboni, mentre in pochissimi riescono a essere davvero, fino in fondo, Fantozzi; questa è una verità nazionale con cui prima o poi si dovrà fare i conti); era una iena, deboli coi forti e forte coi deboli. In questo, continuava ed espandeva sapientemente la tradizione attivata con il Sordi degli Anni Cinquanta e Sessanta, quella tradizione che faceva acutamente notare per esempio a Pier Paolo Pasolini come per esempio all’estero non sapessero ridere (e come avrebbero mai potuto?) di questa peculiare comicità italiana che, affondando le radici nella Controriforma, prendeva di mira i difetti peggiori di fatto assolvendoli – e autoassolvendoci. Villaggio aggiunse una vena estremamente caustica, amara, pessimista, cattiva: di fatto, si può dire che il nostro punk (anche temporalmente: 1975, 1976…) è stato questo, nient’altro che questo. Mica poco.
Del resto, insieme a film come Romanzo popolare (1974) di Mario Monicelli, C’eravamo tanto amati (1974) di Ettore Scola e Amici miei (Pietro Germi-Mario Monicelli, 1975), Brutti, sporchi e cattivi (Scola, 1976) e I nuovi mostri (Monicelli-Risi-Scola, 1977), i primi due Fantozzi – diretti dal sottovalutato e indimenticabile Luciano Salce – fotografano un paesaggio di disillusione e smarrimento collettivi, rispecchiati dalle macerie e dal degrado di uno spazio privato, pubblico e civile che cancella velocemente la propria stessa memoria storica per proiettarsi in uno squallido nulla. Opere del genere costituiscono una risposta articolata e probabilmente irripetibile in termini di critica sociale e culturale, intelligente e brillante, a una serie di questioni che il cinema ritenuto allora più “serio” e autoriale – ma se non sono d’autore questi film, quali possono mai ad esserlo? – preferiva non affrontare, volgendo lo sguardo altrove. Non sono solo tipi umani che si aggiungono alla galleria composta durante gli Anni Cinquanta e Sessanta: quelli come “Fantozzi” sono tipi umani nuovi tout court, immortalati praticamente in diretta da questo cinema d’assalto e inseriti prontamente in una narrazione complessa, utile oggi a ricostruire scansioni storiche che difficilmente sarebbero riconoscibili altrimenti.
***
Fantozzi contro tutti (Neri Parenti-Paolo Villaggio, 1980) segna invece il cambio di passo ideologico e morale nella saga – è il terzo episodio. L’evoluzione-involuzione fantozziana degli Anni Ottanta (nutritissima: quattro film) viene sempre sottovalutata. È invece utilissima per comprendere il cambio di segno ideologico a cui vengono sottoposte le figure simboliche del decennio precedente (il corrispettivo americano è, naturalmente, Rocky). Riconfigurazione della critica sociale. Nell’incipit, Paolo Villaggio chiarisce qual è il nuovo contesto: “Questa è la sede centrale di una megaditta italiana degli Anni Ottanta: la crisi del Paese, la svalutazione galoppante, hanno finalmente generato nella classe impiegatizia un nuovo, incredibile, morboso attaccamento al lavoro”.
Così, per capire i nostri Anni Ottanta un elemento-chiave da analizzare è proprio l’evoluzione-involuzione del personaggio nel corso del decennio. Anche Ugo Fantozzi, infatti, cambia: subisce una “mutazione antropologica”. Non era mai stato così aggressivo, con quegli scatti addirittura violenti contro Pina. E, a volte, anche contro il mondo crudele che lo circonda. È l’isteria italiana del periodo, descritta così bene da Alberto Arbasino ne In questo stato (1978) e in Un Paese senza (1980); un’isteria che agisce dall’interno questo palinsesto (tragi)comico nazionale. La maschera, la figura-simbolo dell’italiano medio è come percorsa da una scarica elettrica, da una pulsione che lo trasforma da dentro. Che modifica i suoi desideri (i programmi soft-core, a notte fonda, sulle nuove tv private ), pilotandoli e modellandoli, creandoli ex novo.
***
È per questo che, già qualche ora dopo la sua morte, Villaggio/Fantozzi resiste, stride, contrasta con il trattamento, la cura-Ludovico a cui ogni defunto che appartiene a quest’era di somma volgarità viene ormai sottoposto: i tormentoni, le scene ossessivamente trasmesse (sempre le stesse, peraltro: segno inequivocabile di scarsa conoscenza del tema), i commenti sconclusionati e inopportuni. E no, Fantozzi/Villaggio non è lì, in quei servizi di telegiornale, e non sta nemmeno su Facebook e su Twitter: perché ciò che resiste e stride è proprio quella identità così attraente (e repulsiva al tempo stesso), radiante, originale, corrosiva: quella cattiveria, quella disumanità, quel cinismo sano e disperato, quella degradazione, quella mortificazione sono profondamente alieni e sconosciuti alla società attuale, così timorosa invece del fallimento e dell’umiliazione e dell’esclusione sociale, e al suo immaginario conseguente. Queste sono tutte cose – caduta fallimento esclusione disperazione entropia, unite a un irredimibile e raffinatissimo cattivo gusto – che, espressione di un altro sistema di valori e di una diversissima forma-di-vita, sembrano del tutto inaccessibili a un’epoca come quella attuale.
Non alla prossima, però.
– Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati