La nostra architettura eclettica. Intervista agli architetti Barreca e La Varra
La pubblicazione della monografia “Il superfluo e il necessario. Architetture di Barreca & La Varra” è il punto di avvio di una conversazione con gli architetti alla guida dello studio milanese, prossimo al completamento del nuovo (e più grande) ospedale della città.

Secondo gli architetti Gianandrea Barreca (Genova, 1969) e Giovanni La Varra (Milano, 1967) per ogni intervento architettonico è necessaria una forma di “accompagnamento” estesa nel tempo. La definiscono come una sorta di “cura di ritorno” necessaria anche per le opere di social housing, un ambito nel quale lo studio da loro fondato a Milano nel 2008 è particolarmente attivo. Perché anche una volta conclusi, spiegano, gli edifici “li sentiamo nostri, come fossero figli. Non sono di nostra proprietà, ma conserviamo sempre l’interesse nel seguirne le vicende. Ci torniamo, guardiamo come cambiano, suggeriamo al committente qualche soluzione se necessaria, anche a incarico finito. Lo facciamo in un’ottica di condivisione con gli architetti dello studio, che così prendono coscienza che ogni architettura è sempre un corpo vivo: invecchia, si modifica, va curata”.
I progetti dello studio Barreca & La Varra: dal Nuovo Policlinico di Milano alla Cittadella dello sport a Tortona
Mentre è in dirittura d’arrivo la costruzione del Nuovo Policlinico di Milano – esito del concorso internazionale vinto nel 2007 da Techint S.p.A. (Arch. L. Colombo) e dall’allora Boeri Studio (S. Boeri, G. Barreca, G. La Varra) – che sarà il più grande nosocomio del capoluogo lombardo, lo studio Barreca & La Varra ha appena completato la Cittadella dello sport di Tortona (Alessandria). Ufficialmente inaugurata lo scorso 21 settembre, è stata realizzata su incarico di Appia srl – Gruppo Gavio: a comporla è un palazzetto per 5000 persone, con vari servizi interni. Lo studio si è inoltre occupato anche del riassetto territoriale dell’area di intervento, una porzione di tessuto urbano “tipicamente italiana, in cui agricoltura, logistica e industria si sono incrociate, senza un’apparente pianificazione” raccontano. Accanto ai traguardi raggiunti in questi anni di attività, nella loro recente monografia, dal titolo Il superfluo e il necessario. Architetture di Barreca & La Varra, hanno scelto di riservare un ampio spazio ai progetti irrealizzati. E per una ragione specifica.
Intervista agli architetti Gianandrea Barreca e Giovanni La Varra
Nel vostro libro li definite “progetti smarriti”: sono i interventi non realizzati. Qual è il vostro rapporto con questo patrimonio rimasto su carta?
Gianandrea Barreca: Fanno parte della memoria mia e di Giovanni, oltre che di quella collettiva dello studio. In maggioranza sono relativi ai concorsi persi; altri si riferiscono a progetti sviluppati negli anni ma che, per varie ragioni, non hanno visto la luce. Questo però non vuol dire che non abbiano un impatto sulla nostra crescita personale, sul nostro sapere, sulla nostra capacità di lavorare. Ci sembra bello dargli valore nel libro. È un esercizio che facciamo spesso, anche con gli architetti dello studio.
Cosa intende?
GB: Una volta all’anno, esponiamo nello studio i lavori che sono stati sviluppati nel corso del tempo, in modo tale che tutti siano informati dell’esistenza di quel materiale: è parte del nostro patrimonio. Capita che, con la distanza data dal tempo, cogliamo aspetti che nel caos, nella fretta, nell’ansia, nel lavoro quotidiano di sviluppo non erano emersi pienamente. Come accadde a tutte le cose, il tempo concede senso critico rispetto a quanto fatto.
Giovanni La Varra: E aiuta anche a definire meglio le traiettorie future. Nel libro, quel capitolo serve a celebrare un mondo nascosto, una cava di idee che non ha avuto una prima occasione, ma potrebbe avere una seconda possibilità. Spesso in queste pubblicazioni si tende a privilegiare i progetti costruiti: a noi sembra importante assegnare legittimità anche a questo “retroscena” del nostro lavoro.
Parliamo di rigenerazione urbana, espressione che in tempi recenti è talvolta adottata con accezioni negative. Operate in questo settore da anni; risale al 2016 la pubblicazione Architettura della rigenerazione urbana, curato da La Varra. Come definireste il vostro lavoro su questo fronte?
GLV: In quella pubblicazione, che è una raccolta di interventi che ho sviluppato all’università, osservavo una cosa curiosa. Dal punto di vista generazionale, da studenti per noi il grande tema era il recupero dei centri storici. Ci siamo poi formati quando la riqualificazione delle aree dismesse è diventata il centro della professione; adesso siamo immersi in questo terzo paradigma: la rigenerazione urbana. Mentre i primi due sono spazialmente localizzati – uno legato alla città antica, l’altro a quella produttiva –, il terzo non si riferisce a un’area specifica. Ci indica invece che tutta la città è da rigenerare e risanare, ma non è esente dai rischi delle definizioni generiche.
Ovvero?
GLV: Almeno in teoria, la rigenerazione urbana comporta il dover lavorare non solo sui luoghi, ma anche sulle azioni, sulle comunità, sull’edilizia sociale e su chi la mantiene, sugli spazi aperti e su chi li gestisce. C’è un’attenzione diversa rispetto al fatto di completare un’architettura in un dato territorio – pensiamo ai grandi quartieri di edilizia popolare sorti degli Anni Settanta. È da qui che trae origine quello che chiamiamo “accompagnamento”.
 1 / 11
1 / 11
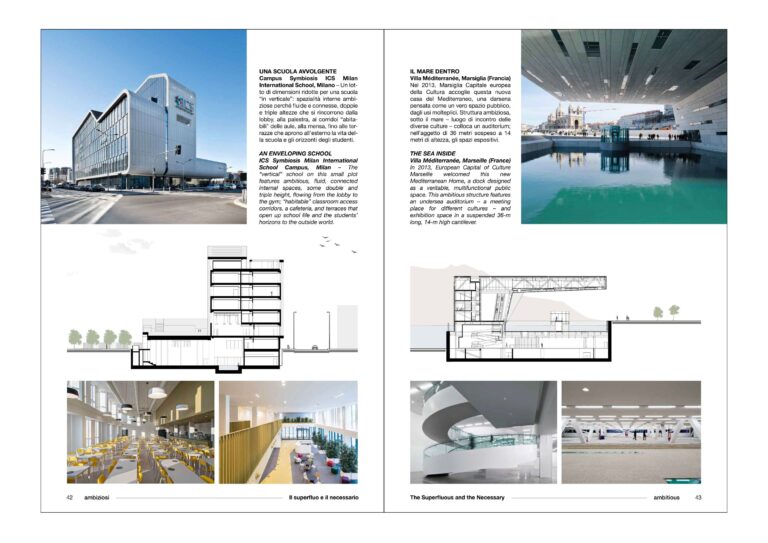 2 / 11
2 / 11
 3 / 11
3 / 11
 4 / 11
4 / 11
 5 / 11
5 / 11
 6 / 11
6 / 11
 7 / 11
7 / 11
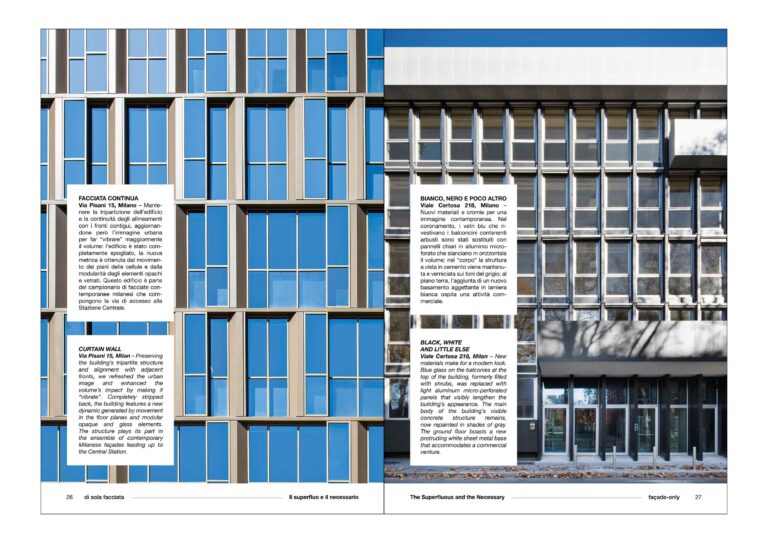 8 / 11
8 / 11
 9 / 11
9 / 11
 10 / 11
10 / 11
 11 / 11
11 / 11
I progetti di rigenerazione urbana dello studio Barreca & La Varra
Alla luce di questa posizione, quali considerate come i vostri progetti più rilevanti?
GLV: La nostra esperienza è fatta di luce e ombre. In alcuni casi abbiamo l’impressione di essere all’interno di processi edilizi che effettivamente sono accompagnati da percorsi sociali, politici, economici; in altri casi percepiamo qualche carenza o un disallineamento. Anche se spesso viene considerato come l’esito, in realtà il processo è soprattutto l’inizio di un cambiamento in un certo quartiere. Tra le nostre realizzazioni più emblematiche, ovvero quelle in cui siamo riusciti a incrociare tutte le dinamiche importanti in progetti di architettura consapevoli delle esigenze abitative contemporanee, cito due esempi di social housing a Milano: quello completato in via Antegnati, nel 2022, e quello in corso allo Scalo Greco.
Cosa li rende così rilevanti?
GB: Attorno al tavolo si sono seduti tutti i soggetti che concorrono alla vera natura di un’opera di rigenerazione urbana, che non vuol mai dire solo ridare vita a un edificio dismesso o recuperare un quartiere abbandonato. Piuttosto significa collegarlo alla città, rendere possibili al suo interno funzioni che rendono la sua presenza premiante anche per chi vive nei dintorni, lavorare anche su quello che è invisibile. Il progetto di Greco è un master plan per l’area dello scalo ferroviario Greco-Breda a Milano, ha vinto a maggio 2019 il concorso C40 Reinventing Cities; nell’intervento di social housing in via Antegnati abbiamo recuperato cinque grandi edifici abbandonati da decenni e sostanzialmente mai abitati.
GLV: Rispetto al social housing, il Comune di Milano ha avuto una battuta d’arresto. Purtroppo succede spesso che nei momenti di crisi – finanziaria, economica, di sistema – il social housing diventi l’anello debole delle operazioni; ha una bassissima reddittività, pone problemi di gestione, richiede manutenzione. Speriamo si riprenda quel cammino. La città stava provando a risolvere la questione abitativa, per allinearsi a un livello qualitativo che in Europa è alto.
Oltre Milano, sempre sul versante social housing state lavorando anche Genova e Udine. In questa città, vi state occupando anche di un progetto inusuale per voi.
GLV: Si tratta del teatro nel carcere di Udine. Da qualche anno abbiamo sviluppato un’attenzione verso la dimensione estrema del carcere. La costruzione del nuovo edificio del teatro ha una valenza di varia natura: è un’offerta tanto alla città, quando al luogo e al tempo della pena. È un piccolo intervento, con cento posti a sedere.
E poi c’è la Cina.
GB: Quella in Cina è una vicenda molto particolare, che nasce dal contatto accademico con l’architetto cinese Yuelai Ruan, Director of the Office of the School of Public Art – China Academy of Art, a Hangzhou. Ci ha invitato a collaborare al recupero di un edificio esistente. È lo showroom di un grande sviluppo edilizio: tutti gli immobili sono stati venduti ed è rimasto inutilizzato, ma data la posizione interessante, a ridosso di un lago, è nata l’idea di renderlo un padiglione con un uso misto, sia culturale che commerciale. Per certi versi, sembra un intervento “molto italiano”, sia per la piccola dimensione che per la sensibilità dimostrata verso il recupero, più comune alle nostre latitudini che lì.
È un territorio in cui vorreste mettere radici?
GB: Potrebbe interessarci. Oltretutto l’occasione di progettare luoghi ibridi in Italia non è così frequente. Anzi, per motivi imprenditoriali, urbanistici e legislativi, è spesso difficile disporre di spazi in cui le funzioni sono così interrelate. In Cina, forse, questo è il momento in cui in città spesso monofunzionali e talvolta anonime iniziano a presentarsi buone occasioni di questa natura.
GLV: Spesso succede così: a valle di una trasformazione immobiliare massiva, muscolare, estensiva, prende piede un ripensamento, un programma di sviluppo più ridotto.

L’architettura secondo lo studio Barreca & La Varra
Guardiamo al futuro. Cosa vorreste progettare nei prossimi anni?
GB: Il nostro curriculum, la nostra storia sono fatti di progetti eclettici. Abbiamo avuto la fortuna di attraversare quasi tutte le tipologie, quasi tutti i tipi di clienti, quasi tutte le dinamiche delle città. Il teatro nel carcere di Udine rappresenta una nuova frontiera. Nei prossimi anni vorrei continuare nel solco di quanto fatto da quando lavoriamo insieme, Giovanni e io.
E quindi?
GB: Deviare rispetto alla tangente. Continuare a essere un po’ strabici, nel senso di cercare temi, soggetti, opportunità, forme che aprano una riflessione e ci diano l’opportunità di metterci nuovamente in gioco. Senza cadere nel rischio di riciclare, ma piuttosto ci interessa continuare a pensare. E poi sì: ci piacerebbe lavorare su temi ibridi e complessi, con edifici per l’arte, la musica e l’architettura, che hanno necessità di essere pensati in un modo completamente diverso.
All’inizio raccontavate dello studio del recupero dei centri storici quando eravate all’università. Anche sulla base delle vostre esperienze di docenza, su cosa si formeranno le future generazioni di architetti?
GLV: Sulla questione ambientale. La sostenibilità, però, è un tema con molte insidie. Nel libro, parlando dei nostri progetti, abbiamo cercato di raccontarla con la giusta complessità. Come tutto ciò che l’architettura porta in dote alla città, anche la sostenibilità deve trovare le sue forme di rappresentazione, oltre che essere di sostanza.
GB: Lo spazio pubblico, che oggi pone tanti livelli di difficoltà anche in considerazione del fatto che i nostri studenti provengono da tutto il mondo e hanno specifiche prospettive e aspettative. Ma mai come ora vedo espressa dagli studenti e dalle giovani generazioni la richiesta di una più alta e più diffusa qualità dello spazio pubblico in città. C’è l’esigenza altissima, impellente, non più rimandabile di un sollevamento qualitativo ovunque: non è possibile rimanere scioccati (e quindi sconvolti e delusi al rientro) semplicemente perché si sono percorsi 500 chilometri verso nord e si è incontrata una qualunque città in cui la qualità di vita e lo spazio pubblico sono migliori che da noi. Per me questa è la grande sfida di domani. Le nostre città sono indietrissimo. Milano compresa.
Valentina Silvestrini
Scopri di più
Barreca & La Varra (a cura di THE PLAN editions) ‒ Il superfluo e il necessario. Architetture di Barreca & La Varra
Gruppo Maggioli S.p.A., Bologna 2024
Pagg. 172, € 29
ISBN 8891656554
ACQUISTA QUI il libro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati
















