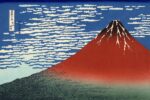L’idea del realismo (IV)
La maggior parte delle narrazioni attuali (film, romanzi, opere d’arte, discorsi) provengono ancora da una sorta di “zona finzionale”, costruita nell’arco di un trentennio, dell’Italia che si rispecchia in una storia inesistente: questo tipo di produzione culturale è rivolta esattamente all’autocelebrazione, a confermare il ‘già noto’ prodotto e riprodotto da quelle griglie obsolete appena descritte.

Il presente e la storicizzazione del presente
è l’esposizione a un fascio di luce nera
che ugualmente acceca.
GIUSEPPE GENNA
Il fatto è che una società “chiusa” con problemi strutturali e disfunzioni sociali come quella italiana di questi anni, inevitabilmente trasmette queste stesse criticità alla produzione culturale. Un Paese e una collettività in declino non possono produrre opere e contenuti di prim’ordine. Semplicemente, non ne sono più in grado: esprimeranno inevitabilmente qualcosa che sia disponibile alla consolazione, alla retorica, all’autocelebrazione. Alla negazione della realtà.
E il modo migliore, più efficace di negarla è offrirne una rappresentazione del tutto dissociata, ideale, finzionale, modellata su schemi importati o sognati. Offrirla agli altri, e soprattutto a se stessi. Così, ogni discorso culturale ruota attorno a premesse esaurite, e fa finta che negli ultimi decenni e anni nulla sia accaduto, se non in meglio. Stiamo continuando una conversazione che si è estinta da tempo: così, per rassegnazione, pigrizia e – soprattutto – paura. Ci aggiriamo nel panorama culturale come spettri, come i guardiani di una città-fantasma. Lo stesso “panorama culturale” è questa città-fantasma.
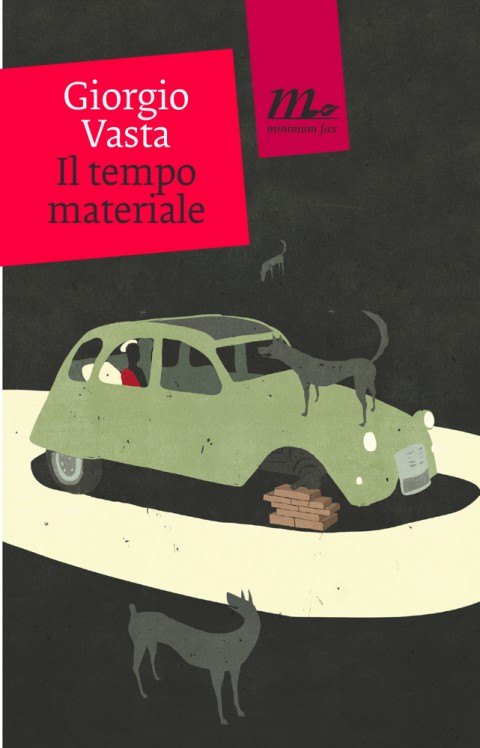
Il tempo materiale (2008) di Giorgio Vasta
Il “fare finta di niente”, il continuare quasi per gioco il discorso della cultura su premesse superate e come se nulla fosse accaduto nel frattempo (tanto più se, al di là della convenzione, il lavoro culturale nei fatti si svolge secondo modalità e finalità mutate) è pericoloso perché ci impedisce di andare avanti. Se si vive nella finzione perché è più comodo, non si può poi pretendere che il risultato sia efficace. Se si sceglie di restare lontani – a distanza di sicurezza – dalla realtà, non è possibile immaginare un oggetto culturale che influisca profondamente su di essa. È un atteggiamento infantile. Non si può insomma pensare di realizzare qualcosa di veramente notevole e potente lasciando tutto il resto così com’è: lavorando cioè nella dissociazione, e non sulla dissociazione.
Questo lavoro sulla dissociazione viene portato avanti, negli ultimi anni, quasi esclusivamente dagli scrittori: il ripensamento degli ultimi trent’anni italiani, dei punti d’origine e delle formazioni storiche, dà luogo ad un racconto in gran parte inedito dell’identità collettiva, che affronta i traumi e non li aggira. E questo racconto, che proviene dalla zona oscura della realtà diametralmente opposta a quella dell’illusione di realtà, è il presupposto dell’immaginazione, e della costruzione, di ogni realtà futura.
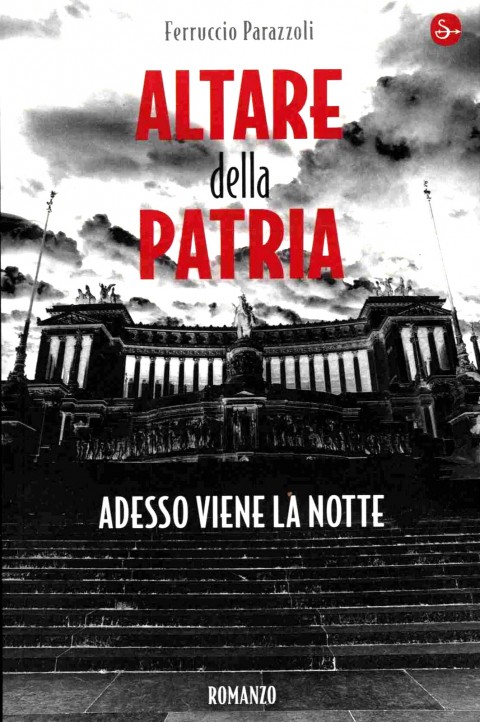
Altare della patria (2011) di Ferruccio Parazzoli
Questa pattuglia di testi (elencati qui senza alcuna intenzione di catalogazione esaustiva) è composta da: Assalto a un tempo devastato e vile (2001; 2002; 2010), Dies Irae (2006), Italia De Profundis (2008) e Hitler (2008) di Giuseppe Genna; Lettere a nessuno (1997; 2008), Gli esordi (1998), Canti del caos (2001; 2003; 2009) e Gli incendiati (2010) di Antonio Moresco; Il tempo materiale (2008) di Giorgio Vasta; Come Dio comanda (2006) e Che la festa cominci (2009) di Niccolò Ammaniti; Cinacittà (2008) di Tommaso Pincio; il dittico composto da Stirpe (2009) e Nel tempo di mezzo (2012) di Marcello Fois; Lezioni di tenebra (1997) e Le rondini di Montecassino (2010) di Helena Janeczek; Troppi paradisi (2006), Il contagio (2008) e Resistere non serve a niente (2012) di Walter Siti; Il bambino che sognava la fine del mondo (2009) e La seconda mezzanotte (2011) di Antonio Scurati; Altare della patria (2011) di Ferruccio Parazzoli; Elisabeth (2011) di Paolo Sortino.
Come si vede, si tratta di romanzi e autori diversissimi tra loro, per stile, interessi, impostazioni tematiche. Che cosa hanno in comun allora queste narrazioni? Ognuno di questi libri è a suo modo ‘misterioso’; molti sono profetici nel tono stesso delle pagine (un tono brusco e salmodiante, che riorienta subito il nostro modo di percepire l’argomento): si tratta però di una profezia che ha a che fare con il già accaduto.

La seconda mezzanotte (2011) di Antonio Scurati
Spesso, si incaricano di compiere l’autopsia di un’epoca storica nazionale (quella appena conclusa: “gli anni Ottanta e Novanta e Zero Zero”), un’autopsia che coincide con la sua comprensione. Vogliono cioè riscrivere la storia recente del nostro Paese, attraverso i mezzi letterari. Gli ultimi decenni sono squadernati attraverso le apparizioni che appartengono ad essi: “In questo lungo gioco di sguardi (di campi e controcampi, di canti e controcanti) che attraversa lo spazio nazionale si concentra il fantasma concreto ed evanescente di un paese claustrofilico, la grande microscopica capsula temporale da cui non riusciamo a venire fuori” (G. Vasta, Altare della patria – recensione, “minima & moralia”, 18 novembre 2011).
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati