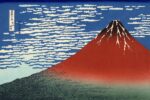La freccia e il presagio
“La democrazia del marmo”: così si intitolava il primo saggio sull’icona di Gian Maria Tosatti. Dove una certa immagine degli scontri di piazza avvenuti a Roma nel dicembre 2010 venivano accostati a una celeberrima opera di Délacroix. Il “taglio” è il medesimo anche in questo caso. Ovvero siamo sempre in bilico fra consapevolezza classica e coscienza contemporanea.

“Niente più trascendenza, niente divergenza, niente altra scena: solo un gioco speculare con il mondo contemporaneo così come esso ha luogo. Per questo l’arte contemporanea è inesistente, perché tra essa e il mondo si ha solo un’equazione perfetta.”
Jean Baudrillard
New York e una piazza che non esiste: Liberty Square (all’inizio è così che la chiamavano, prima che diventasse famosa come Zuccotti Park). A cercarla su Google Maps o Google Earth si poteva finire in giro per le campagne del New Jersey dove, ai primi d’ottobre del 2011, quando ho iniziato a scrivere questo saggio, non stava succedendo assolutamente niente. E, invece, in una piazza che non esiste di New York City si è consumato e si consuma ancora forse il più epocale dei sollevamenti che il mondo occidentale conosca. Niente barricate, niente fumogeni, qualche scontro sì, ma direi più qualche intemperanza.
Ma ad andarci, a guardarli, i ragazzi, i cosiddetti “indignados”, sembra di assistere a una lezione di terza elementare. Fa quasi tenerezza Slavoj Zizek che al centro dell’assemblea assisa sul selciato, in piedi da solo come un direttore d’orchestra, con una maglietta rossa indosso raffigurante il faccione di nonno Marx, agita le braccia e le idee come un maestro del coro, mentre tutti ripetono ad alta voce, frase per frase, per far viaggiare le parole e farle sentire anche agli anelli più lontani del consesso. Non c’è neanche un microfono, è un metodo da campeggio.
Zizek con la barba sembra lo zio Slava coi nipotini mentre gli fa imparare una filastrocca. È un’immagine impietosa, ma potete giurarci, è proprio così. I ragazzi sono tutti belli, come i bambini. Ecco, sembra la rivoluzione fatta dai fanciulli. Viene quasi voglia di non prenderla sul serio. Ma poi penso che erano proprio ragazzi come loro che negli anni ’50 e ’60 hanno scassato l’impianto della famiglia, della gerarchia dei sessi, della morale. Non erano meravigliosi bambini, fragili e con gli occhi spalancati Jack Kerouack e Allen Ginsberg mentre scalavano le montagne del Dharma salendo sui treni merci che andavano chissà dove collegando la periferia di San Francisco col resto del mondo?
Qui le rivoluzioni si fanno così. E nemmeno è vero. Qui le rivoluzioni si sanciscono così. Con gli occhi spalancati, gli occhi dei testimoni che stanno al lato della battaglia appena consumataglisi davanti, come nel celebre dipinto di Antonio Mancini, e già ne conoscono il verdetto. E, infatti, Zizek non canta la filastrocca rivoluzionaria; la sua litania per tenore e coro, salmodia la lapidaria formula che decreta la fine del capitalismo. Senza ulteriori sofisticatezze. Ne parla come di qualcosa già andato, è il referto del medico legale, non ci sono più profezie da fare. Tutta la storia è già alle spalle.
Questa rivoluzione incastrata in un incrocio stradale, quello fra Broadway e Liberty Street, che nel resto della città non si vede e non si sente, se non attraverso l’eco dei giornali, non fa paura. Questi ragazzi non sono dei rivoluzionari. Sono già la prima generazione post-rivoluzionaria. Sono già i ragazzini dietro i banchi a cui si parla del prima nell’ora di Storia, di quel prima che per chi c’era dura ancora e non smette di durare, come nei romanzi di Fenoglio, ma che per loro non è che una pesante eredità di cui liberarsi, come nei romanzi di Cassola.
Dall’Italia si fa fatica a capirlo. Noi siamo ancora impelagati nelle spire di un’agonia. Da Roma a New York ci sono sei ore di differenza, sei ore di ritardo, e qui il capodanno del “dopo-storia”, come avrebbe detto Pasolini, si attende ancora e si continua a sentire il sibilo di una società dal respiro moribondo che non cessa e che tiene ancora i nostri giovani col fiato sospeso, sospendendogli il futuro.
Noi siamo tutti ancora al capezzale, a scontare il ritardo e a perdere la nostra occasione, come i ragazzi di guerra, che partono troppo presto e tornano troppo tardi, e a cui non è permesso entrare nel mondo restaurato, come per una specie di peccato originale, di maledizione, che appartiene alle “generazioni perdute” cui accenna Remarque nel suo libro più famoso, le generazioni su cui pesa l’attrito della transizione. E di guerra si può parlare certamente in questo caso, una guerra che qui s’è combattuta con la forza dei leoni, tra le mura di Wall Street. Muta, senza clamori, lasciando cadere bombe senza tuono, il cui unico boato era il successivo levarsi del canto disperato dei superstiti, dei feriti a morte. Questo Paese, gli Stati Uniti intendo, negli ultimi tre anni si è rotto (per usare la traduzione letterale della parola ‘broken’, che calza a pennello intendendo anche il senso del fallimento economico). E il dramma è stato contenuto solo dalla mancanza di voce che contraddistingue le vittime in luoghi come l’America, che non sono poi tanto diversi dai Paesi del Terzo Mondo, dove i genocidi non sono drammi di Stato, ma silenzio di campagne abbandonate.
Per citare ancora Carlo Levi, qui, le campagne in bancarotta dell’Arkansas, dell’Arizona, dell’Ohio non sono più vicine a New York di quanto non lo fosse la Lucania rispetto a Roma nel Cristo si è fermato a Eboli. Lì si denunciava una distanza antropologica, quella che da noi s’è sempre chiamata “questione meridionale” e che il fascismo per vent’anni aveva negato, oscurato, dimenticato. Ecco, già, infatti, anche qui, questa questione non ha nome. Per quanto tempo, mi domandavo mesi fa, questo Paese continuerà a mentire ai suoi cittadini, per quanto tempo brandirà la sua retorica di sogni vuoti per coprire un disimpegno di Stato che non ha uguali nel mondo occidentale? Oggi questa domanda non ha più senso. Il velo della retorica è caduto. E sta ai piedi del silenzio coraggioso del presidente Obama. Che resta immobile, davanti agli occhi di tutti, nel suo potere nudo. Siamo al grado zero. Siamo alle classi di scuola improvvisate nelle strade dei Paesi che cercano di ritrovare una identità dopo un’occupazione o una dittatura. Non sono ancora classi “statali”. Sono tirate su un po’ alla buona dalle maestre per evitare che in attesa di una nuova normativa, di un nuovo ministero, un’altra generazione venga dispersa. E il miracolo è proprio che negli occhi di questa generazione c’è già il futuro: inarticolato, inconsapevole; ma del passato, del prima e delle sue consuetudini, non c’è traccia. E sono proprio i loro occhi che disarmano. Essi non sono più in guerra. Si possono ancora sferzare, punire, arrestare, zittire. Gli si può cucire addosso un ruolo che non è il loro. Li si potrebbe anche uccidere come si faceva nei secoli passati. Ma sarebbe come sparare contro il tempo che passa e contro la sua legge ineludibile.
Attorno alla fine del terzo secolo, a Roma, quella che allora era la New York dell’antichità, il centro di un impero disperso, si legò un uomo contro un palo, le mani costrette dalle corde, e gli si tirò contro con l’arco, fino a che le frecce non gli divennero una seconda pelle. La leggenda, a cui non credo, racconta poi che quell’uomo subì il martirio senza spirare. Sopravvisse alla tortura, per poi trovare la morte altrove, sempre per mano dell’imperatore pagano Diocleziano.
È di San Sebastiano che parlo ovviamente, ma questa vicenda, spogliata dall’oleografia dei santi, cosa racconta? Racconta di due visioni del mondo, una antica e una moderna. Diocleziano col suo paganesimo rabbioso era ormai un relitto della Storia, al timone di una nave alla deriva, di un modello di ordine pubblico che non dava più risposte, che non riusciva più a viaggiare neppure fra i confini fragili del già conquistato. Sebastiano, primo comandante dell’esercito imperiale, era un uomo moderno, vedeva il futuro e aveva già visto che il mondo si volgeva ad altro, che sulle rovine della necropoli greca si era già alzata l’acropoli cristiana, coi suoi diversi archetipi e il suo uomo “moderno”, la sua rivoluzione globale. L’aneddoto che lo fa sopravvivere al suo martirio è concepibile, perché la sua morte a questo punto non avrebbe avuto nemmeno senso, perché una freccia scoccata dal passato può cadere nel futuro, ma non può trafiggerlo. Ed è lì, al futuro che volge gli occhi il santo nell’iconografia rinascimentale.
Nel ritratto che ne fece il Perugino tra il 1493 e il 1494, gli occhi della figura non sembrano minimamente in preda a un’estasi celestiale, sembrano piuttosto gli occhi di chi vede con chiarezza qualcosa, gli occhi di chi già vede un mondo nuovo, un “brave new world”, o forse con un lessico un po’ più contemporaneo, un “brand new world”. Senza voler entrare nelle faccende della fede, in quegli anni a fronteggiarsi non erano certo la terra e il cielo. A passarsi il testimone, con le asprezze del caso, erano due visioni politiche dell’uomo e della Storia e di conseguenza due ordini del mondo. E la corona, che l’angelo posa sulla testa del San Sebastiano di Sodoma (1525), forse uno dei più famosi dipinti di questo martirio, assomiglia tanto più ad un simbolo di potere secolare che non d’illuminazione celeste come sarebbe stata una più classica aureola.
Questo dipinto dunque, visto in prospettiva storica (il fatto che sia stato realizzato più di un millennio dopo la vicenda gli consente una certa lucidità dell’analisi), dà una forma alla successione fra due ere, quella antica e quella moderna (non differentemente da come il quadro di Délacroix, nel saggio precedente, era corrispettivo visivo al passaggio dall’era moderna a quella contemporanea). A farlo tornare d’attualità però non è la medesima circostanza che oggi ci vede funambolare sopra un valico epocale sul filo del rasoio che collega ciò che abbiamo chiamato fin qui “contemporaneità”, ossia quell’era del capitalismo che ci stiamo lasciando alle spalle, e la “Nuova Preistoria” (così ribbattezzata da un Tiresia dei nostri tempi) che ci si para d’innanzi. Il richiamo è assai più preciso di così. Bisogna continuare a osservare l’iconografia, tenerla a mente nei dettagli, fino a saperla riconoscere a colpo d’occhio, o forse meglio, come diceva Rilke, ricordarla di colpo, dopo averla dimenticata.
Nella quasi totalità delle versioni rinascimentali di questa icona, Sebastiano non è trionfante, è spogliato, quasi fino alla leziosità, fragile, e il suo sguardo, pur ispirato, in molti interpreti, non è immune dalla paura. In Sodoma questo è particolarmente evidente. Eccolo allora, un santo vulnerabile nella sua nudità, anche impaurito, e sbigottito dal contrasto fra la luminosità del futuro che ancora lo rapisce e la dura regola delle manette, o dei “vincoli”, per dirla alla latina: simboli del menzionato conflitto fra le due ere che ha nel corpo del santo il punto di attrito.
A farne un ritratto a parole, però, sembra proprio di parlare di uno di quei ragazzi di Liberty Square, la piazza che non esiste, alle spalle di Wall Street. La sua figura giovane e sognatrice non può non ricordare uno dei 700 arrestati sul ponte di Brooklyn in ottobre: un numero che sembra già iperbolico, biblico nella sua stupida enormità, fatto quasi apposta per far da sfondo all’aneddoto, alla mitografia. Ed è appunto da qui che arriva un colpo d’occhio tagliente quando sulle prime pagine dei quotidiani appare la fotografia di una ragazza arrestata, costretta nella posa identica del San Sebastiano di Sodoma. Un’immagine scoccata dalla fotoreporter Stephanie Keith come una freccia che attraversa il tempo e dal passato cade nel presente come un segno, una epifania, un pronostico, o ancora peggio un déjà-vu che mette sul futuro già la pietra del suo verdetto.
Identica nella forma, nello sguardo, nell’ispirazione, in una nudità dissimulata, ma altrettanto capace d’esaltarne la fragilità incatenata, questa icona suona un accordo inquietante, una consonanza che è già sentenza. Attraverso il suo riapparire formale, per mezzo di un gesto artistico contemporaneo come la fotografia – che non ha niente della premeditazione e tutto dell’intuizione in quella “equazione perfetta fra l’arte e il mondo” di cui ci parla Baudrillard – l’icona si ripresenta con la forza del suo senso originario per incastonarsi nella corona giornalistica della cronaca come una chiave capace di aprire la finestra su di un evento che suona già consumato, su una successione epocale che si dimostra a colpo d’occhio già avvenuta.
Tutt’intorno, a parole, lungo le linee nere d’inchiostro delle sei colonne, sembra si stia parlando d’altro, in un fuori-sincrono abissale, quasi fosse una patetica telecronaca in differita dal passato spacciata per una diretta in un tempo che è già presente e che nessuno sta raccontando davvero.
Gian Maria Tosatti
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati