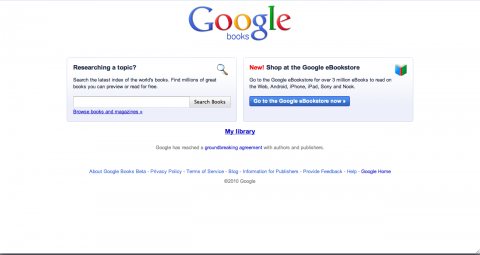Design & Cultural Heritage. Intervista sulla frontiera dei beni culturali
Abbiamo incontrato Fulvio Irace ed Eleonora Lupo, fra i curatori di un’opera monumentale sul rapporto fra design e beni culturali. L’occasione: un corposo cofanetto che raccoglie saggi per quasi ottocento pagine. L’obiettivo: capire quali sono le frontiere per la fruizione e la valorizzazione del patrimonio.

Design dei beni culturali: di cosa stiamo parlando?
Fulvio Irace: Sino a pochi anni fa parlare di design a proposito di beni culturali significava parlare di allestimenti, di disegno di vetrine o di supporti per le opere, di servizi, insomma, a servizio dell’oggetto esposto in mostre o in musei. Poi è andata cambiando l’idea stessa del design, che da sistema di produzione industriale è andato assumendo il significato di progetto di procedure e non di oggetti. Cioè progetto di definizione di scenari d’uso, di previsione o sollecitazione di comportamenti: dunque un’attività capace di stabilire connessioni tra sistemi diversi in modo da utilizzare le sinergie per aumentare la gamma delle prestazioni. L’incontro del design con i beni culturali avviene su una base di reciprocità: perché se il design si è trasformato da produttore di oggetti a produttore di processi di trasformazione, i beni culturali hanno cessato di essere soltanto il “forziere” della Storia, il giacimento della Grande Bellezza mummificata, ma si sono estesi al paesaggio, ai riti, al folklore, ai costumi e a tutto quello che l’Unesco definisce intangible heritage, cioè l’eredità immateriale.
Che ruolo assume in questo quadro il design?
Il design diventa un processo strategico che aiuta a mettere a fuoco obiettivi, priorità e soprattutto i mezzi e i modi con cui perseguirli. Per esempio, definisce le strategie di visualizzazione e di comunicazione con cui un’istituzione (un museo, un monumento, un luogo ecc.) o un territorio scelgono di valorizzarsi e di comunicare la loro attiva presenza. È chiaro che alla base sta la necessaria (anche se controversa e dibattuta) coesistenza tra conservazione e valorizzazione.
Ma questo apre naturalmente un dibattito infinito, cui si può forse in quest’occasione solo far presente che non può esserci una conservazione che non sia anche una valorizzazione del bene: ovviamente quest’ultima deve essere sostenibile e compatibile con la fragilità del bene stesso. Ma è anche vero che l’unica maniera di conservare (e lo dicevano anche i primi teorici del restauro come Ruskin) è di usare il bene. Solo l’uso ne impedisce infatti la rovina: sia quella fisica che quella metaforica dell’oblio.
Cosa distingue il cultural heritage dal patrimonio dei beni artistici inteso in senso tradizionale?
F.I.: La parola cultural heritage è la traduzione in inglese della nostra dizione beni culturali. Ma ogni traduzione è anche tradimento o ampliamento di significato. L’equivalenza non è dunque né meccanica né scontata: anzi, nella versione inglese di “eredità” c’è l’idea attiva della conservazione come uso. Un’eredità attiva incrementabile con la produzione di nuovi beni: come il caso di interventi artistici, di restauri, di aggiunte al bene storico, che in tal modo lo traghettano sino agli usi richiesti dai cambiamenti della società.
Nella dizione beni culturali si nasconde invece una tradizione patrimonialistica dell’eredità, simile all’orrenda definizione di “giacimenti culturali”. Come dicevo prima, la stessa introduzione del concetto di “cultura immateriale” apre a una visione del “bene” che sconfina nell’antropologia, quindi in una dinamica costantemente attiva dei comportamenti di una comunità che include le sue pratiche simboliche, i suoi contenuti espressivi, i suoi modi di rapportarsi alla tradizione e all’esistente.
Quale ruolo può avere la tecnologia in ambito museologico? Quali paradigmi può sollecitare a livello teorico, al di là delle singole applicazioni pratiche?
F.I.: La cultura digitale, al di là di tutte le sue infinite applicazioni, significa soprattutto valorizzare le pratiche di interrelazione e di condivisione e quindi implica la possibilità di espandere la creazione di nuovi valori che poi costituiranno la tradizione di domani. Ogni tecnica infatti non è solo strumento (McLuhan diceva “il medium è il messaggio”) ma porta con sé una visione del mondo, un sistema di comportamenti che mettono in crisi i vecchi paradigmi e ne creano di nuovi. I paradigmi dell’apertura e dell’inclusione, dell’intreccio, della complessità e dell’interazione, per cui la trasmissione del sapere non è più uni direzionata, ma diventa una trama di impulsi che arricchiscono il quadro complessivo. Oggi il primo ingresso a un museo avviene sul web e i portali digitali aprono possibilità inedite ai visitatori remoti della società globale. Si parte con le indicazioni di servizio, per arrivare poi ai virtual tour, ai servizi personalizzati e persino alla possibilità di crearsi le proprie selezioni dentro le collezioni del museo con un’applicazione (Master Matcher) che sfrutta le tecniche del gaming per familializzare il visitatore con il mondo dell’arte.
Facciamo esempi concreti.
F.I.: Ad esempio, al Rijksmuseum di Amsterdam (completamente rinnovato nel portale e anche nell’edificio storico) si possono ordinare copie a stampa delle opere esposte, mettendo in evidenza particolari, dettagli che servono per una personale ricerca (gli uccelli nella storia dell’arte, gli specchi, i merletti ecc.) che possono rivelarsi strumenti di ricerca scientifica e non solo giochi. La Galleria universale di Google invece si propone di collegare le collezioni dei musei in un solo museo virtuale immaginario, che fa rivivere il sogni di Malraux del Museo senza muri o quello dell’Atlante della Memoria di Aby Warburg. Poi ci sono le applicazioni come “7scenes” o lo “street museum” di Londra che trasformano il cellulare in uno strumento di informazione storica, capace di arricchire la visita di una città con tutti i dati sulle sue trasformazioni nel tempo. In tal modo si apre la strada per un’altra forma inedita di esperienza conoscitiva: quella del museo diffuso.
I nuovi paradigmi della complessità e della stratificazione delle informazioni creano dunque una prospettiva culturale in cui le interrelazioni immediate diventano fenomeno di arricchimento.
Uno dei saggi raccolti in d&ch parla di prossemica museale. Prendiamo l’esempio dei famigerati selfie, che anche la National Gallery di Londra ha di recente permesso nelle proprie sale: siamo pronti per convogliare senza snobismi queste pratiche nella direzione di un più profondo “amore” per il nostro patrimonio?
Eleonora Lupo: Non c’è dubbio che l’esperienza del cultural heritage si sia profondamente trasformata, e non stiamo più parlando, come afferma Purini, di “democratizzazione” e accessibilità del patrimonio quanto di suoi nuovi valori e “attivazioni” che si connota, come Irace ha sottolineato, come un maturo valore d’uso e di scambio della fruizione e appropriazione di cultura, legato a pratiche di identificazione, auto-rappresentazione, costruzione di relazioni, espressione di valori, tuttavia spesso conformati socialmente: la pratica dei selfie mi pare ancora un “uso” non maturo, che diventa facilmente consumo, ove non riesca a entrare in una dimensione di partecipazione e volontà collettiva, anche politica, di far riconoscere ufficialmente un patrimonio grazie all’attivismo di una comunità, come alcuni casi lasciano ben sperare.
Come immagini l’esperienza “adulta”?
E.L.: La chiamata in prima persona nell’interazione con il patrimonio culturale è pronta a vestire anche i panni adulti di un’esperienza fisica e sensoriale “densa” cognitivamente, che metta in campo, dentro e fuori dai musei, nuove gestualità culturalmente “consistenti”, non limitate a quelle diffuse negli ambienti espositivi come l’interrogazione di un device, ma legate ai contenuti culturali stessi: ad esempio azioni in cui l’intero corpo e i movimenti del visitatore diventino l’attivatore di contenuti la cui natura sia performativa (le già citate espressioni dell’intangible heritage) creando dei rimandi significativi nell’interazione tra gesti culturalmente connotati e contenuti stessi.
In questo la prossemica museale, costituisce un terreno di osservazione che deve però superare l’atteggiamento prescrittivo tra “interazione corretta/errata”, lasciando maggiori gradi di libertà e molteplicità di accadimenti alla gestualità dei visitatori. Tale gestualità può essere molto varia: la “meraviglia” nasce da movimenti consapevoli ma inusuali per un ambiente museale (sporgersi da una finta finestra, soffiare…) o da gestualità istintive agite all’interno di un percorso molto formalizzato, quale può essere una esperienza narrativa (ad esempio muoversi autonomamente ma all’interno del copione di ruoli e storytelling previsto dall’Apartheid Museum di Joannesburg). In un’esperienza fisica di questo tipo si diventa letteralmente attori/attanti del cultural heritage: inoltre la discronia tra tempo storico del patrimonio e tempo della esperienza hic et nunc che comprime a scala “umana” i tempi delle eredità culturali, diventa elemento scatenante di curiosità e riflessione, e di comparazione tra memoria collettiva e apprendimento individuale, attraverso modalità sinestetiche meno mediate e più dirette.
Questo tipo di conoscenza viene amplificata se posta in una dinamica sociale-relazionale vivendo l’esperienza di interazione in comunione con altre persone, nella condivisione e scambio di contenuti, in una sorta di corpo collettivo. Anche questo livello di relazione deve superare le dinamiche tipiche dei social network limitate alla semplice aggiunta di tag o commenti, per approdare a nuove modalità di confronto di punti di vista e dialogo.
Infine, l’interazione in prima persona con il patrimonio, si sposta, nei suoi livelli più profondi sul piano della co-curatela e co-creazione dell’heritage, a scala individuale o collettiva. Anche in questo caso, se si supera il modello di semplice aggiunta di commenti, si può giungere ad un modello di partecipazione attiva, multivocal ed inclusiva, aperta alle dissonanze. La possibilità di contributi e punti di vista molteplici richiede anche di rivedere i processi di legittimazione, elezione e selezione del patrimonio culturale, costruendo nuove scale di autorevolezza sui contenuti.
Che ruolo ha la tecnologia in questo discorso?
In questo panorama ovviamente le tecnologie digitali svolgono un ruolo fondamentale nella mediazione della relazione tra visitatore ed eredità culturale: diventano sempre più smart e invisibili per essere responsive ai movimenti più naturali del corpo, attraverso dinamiche performative e riproduttive. La sensibilità progettuale richiede di evitare la spettacolarizzazione, cercando di offrire percorsi diversificati a vari livelli di complessità, da esperienze narrative a quelle di riscrittura del patrimonio, fino alla possibilità di risalire la filiera delle eredità in una sorta di tracciabilità del patrimonio culturale.
L’idea di partecipare attivamente del patrimonio si muove in questa direzione, al di là dei selfie. Il concetto che meglio esprime questo obiettivo progettuale di usare il patrimonio e ri-contestualizzarlo nell’esistente, non è più la valorizzazione ma l’“attivazione”. Parafrasando Agamben, lungi dall’essere una “profanazione”, la disattivazione di possibilità d’uso convenzionali che l’heritage ha incorporato nei secoli a favore di nuove interpretazioni e appropriazioni, deve tendere a superare la “separazione” culturale tra heritage e quotidiano, “restituendolo al libero uso degli uomini”. Non si tratta solo di “amore” e rispetto per le nostre eredità culturali, ma di inserire l’heritage all’interno di un circuito virtuoso e sostenibile di pratica e “uso” costante e quotidiano, cioè di conoscenza e sviluppo di comunità e territori.
Un intero volume del cofanetto è dedicato agli archivi, in particolare a quelli degli architetti. Qui la questione generale è relativa al copyright, ovvero: come gestire la diffusione digitale di questo materiale pur rispettando il diritto d’autore? Quest’ultimo non rischia di fungere da ostacolo alla conoscenza dell’opera dell’architetto stesso, nella fattispecie?
F.I: Gli archivi sono un campo di sperimentazione particolarmente rilevante del nuovo rapporto tra design e cultural heritage, perché dimostra come la semplice digitalizzazione dei documenti cartacei è solo il primo passo verso una diversa concezione d’uso e un diverso statuto scientifico e sociale dell’archivio stesso.
L’esigenza della conservazione deve misurarsi con le aspettative di un pubblico di utenti molto diverso dal passato: non più solo specialisti e studiosi, ma cittadini, esponenti di comunità locali, di gruppi ecc. che vogliono essere rappresentati dall’istituzione in maniera partecipativa e diretta. Se la nuova storiografia ha sancito l’apertura della storia all’oralità, alle storie “minori” o “speciali” (gli studi di genere, i documenti del folklore, la storia delle comunità ecc.), il nuovo archivio deve dare loro spazio e agibilità, predisponendo nuove modalità di formazione delle memorie.
Al posto dell’archivio sorgono gli archivi: si moltiplicano i luoghi e i modi d’accesso, si accentuano i ruoli delle comunità che includono diverse auto-rappresentazioni. L’archivio non è più il campo di concentramento delle memorie ma luogo di produzione di nuove memorie: in tale prospettiva bisogna superare quelle resistenze, anche di carattere commerciale, rappresentate dal copyright, sperimentando pratiche di negoziazione che tutelino alcuni diritti ma allo stesso tempo li mettano al centro di una prospettiva più ampia. È ovvio che ogni tecnologia (pensiamo ad esempio al campo sensibile della genetica) porta con sé discussioni etiche sulla liceità di certe azioni e sui suoi limiti: ma la risposta non può essere legale, deve essere culturale e implicare la scrittura di un nuovo patto sociale sull’uso della conoscenza.
Il terzo volume, infine, tratta di allestimenti temporanei e relativa archiviazione digitale. Vorrei però porre una questione di base: abbiamo veramente bisogno di quest’accumulo di memoria? Accumulo fra l’altro frustrato e angosciato dai timori di obsolescenza e deterioramento dei supporti fisici di archiviazione. Insomma, non c’è spazio per un sereno affidamento all’oblio di quel che produciamo ogni giorno?
E.L.: Memoria e oblio sono due facce della stessa medaglia: siamo pieni di “archivi imperfetti” (per citare Fausto Colombo) che, paradossalmente, demandando la conservazione a un qualche supporto, diventano protesi e appendici della nostra mente che ci consentono di dimenticare più facilmente… In una mostra in corso a Barcellona (Big bang data, fino al 26 ottobre) mi ha molto colpito il Rosetta Project che intercetta molte delle questioni racchiuse in questo ossimoro. Si tratta di un disco in lega di nichel che misura circa 7 cm di diametro e su cui sono incise in dimensione micron circa 13mila pagine contenenti 1.500 linguaggi umani. Il disco è realizzato per durare migliaia di anni e vincere qualsiasi deterioramento: il timore dell’obsolescenza del supporto dunque può essere eccellentemente superato.
Tuttavia mi pare che la questione di base tra memoria e oblio possa essere osservata anche a prescindere dal supporto, problematizzando questo processo di esternalizzazione della memoria collettiva che di fatto “separa dal libero uso” un patrimonio per congelarlo e fissarlo in maniera immutabile nella storia. Con i dovuti distinguo per le forme culturali estinte la cui documentazione è ovviamente necessaria, questo atteggiamento piuttosto integralista di preservazione dell’autentico è opposto, nei casi di living heritage, al valore d’uso che l’heritage ha o aveva originariamente all’interno della sua comunità detentrice: facendo parte di un sistema culturale vivo e attivo, in cui l’evoluzione e la trasformazione sono connaturate, seppure in cicli storici difficilmente percepibili a scala umana, anche all’interno di un sistema documentale queste dovrebbero essere in qualche modo ancora consentite.
In un sistema orientato alla storicizzazione, la memoria non si contrappone all’oblio ma di fatto diventa complice di una sorta di svuotamento di significato e perdita d’uso che nel tempo porta all’oblio. Si tratta quindi di pensare tecnologie della memoria capaci di conservare in continuità, ossia mediare tra conservazione ed evoluzione, immettendo i sistemi di documentazione in una sorta di “heritage continuum” che connetta archivio e esperienza quotidiana del patrimonio, permettendo relazioni di ricontestualizzazione nel e con il contemporaneo (app e archivi partecipati vanno in questa direzione). Contestualmente occorre passare da una visione di conservazione pura alla trasmissione, che è sempre e comunque l’obiettivo finale della conservazione (ad esempio open-ended archive finalizzati al riuso e la rimessa in circolo dei contenuti).
Infine la questione della vertigine della memoria mi pare espressione di una tensione umana culturalmente ineludibile in cui il processo di selezione è frutto di scelte, a volte magari inconsapevoli, ma destinate comunque a diventare emblematiche sul perché qualcosa è stato ritenuto degno di essere conservato per essere trasmesso.
Qui arriviamo al discorso sugli allestimenti…
E.L.: Proprio questa scelta a legittimare come bene culturale una produzione contemporanea, come il caso degli allestimenti, in questo contesto va inquadrato più che altro in una dimensione sperimentale e metodologica. L’interesse a verificare la dialettica memoria-obsolescenza/rimozione con gli allestimenti era dettato principalmente dal fatto che si tratta di per sé di un bene destinato all’oblio, perché effimero (un allestimento temporaneo ha breve durata e non resta traccia alla fine del suo ciclo di vita se non qualche foto) e dai rilevanti aspetti immateriali (un processo allestitivo vede cooperare vari saperi e discipline ed è puntellato da artefatti dalla grandissima diversità tipologica: disegni, schizzi di progetto, foto, video, altri media…). Era quindi un’occasione per ragionare su come trattare con strumenti altrettanto “imperfetti” un sistema documentale e fruitivo da questa doppia natura virtuale: ed in effetti le potenzialità del mezzo sono state valorizzate offrendo chiavi di lettura e interfacce dinamiche e personalizzabili, con finalità anche di riuso didattico e progettuale open-ended.
La scelta dell’archivio di allestimenti temporanei si rivela in sintonia anche con una sensibilità oramai abbastanza diffusa di sperimentare le pratiche di valorizzazione sulla produzione culturale contemporanea, legittimandola come bene culturale. In questo caso il progetto di design o di architettura diventano paradigma di collezione del presente come esempio di nuove eredità culturali che meglio rappresentino la contemporaneità. In questo senso l’archivio degli allestimenti si distacca sensibilmente da qualsiasi ossessione di estensività documentale, e certo non può costituire un esempio risolutivo per sciogliere la tensione tra conservazione e oblio, ma può offrirci un punto di vista interessante del modo di approcciare il tema.
Marco Enrico Giacomelli
Design & Cultural Heritage
a cura di Fulvio Irace, Graziella Leyla Ciagà, Eleonora Lupo e Raffaella Trocchianesi
3 voll., pagg. 784, € 50
ISBN 9788837097516
www.electaweb.it
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati