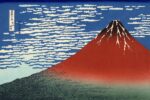La riscoperta del mondo e della curiosità verso l’Altro, dopo mesi di chiusura e paura nei confronti di tutti, compresi amici, parenti e vicini di casa, non potrebbe cominciare da un posto migliore dello Zimbabwe.
Conosciuto come Rodesia fino alla sua indipendenza dal potere minoritario bianco nel 1980, il Paese gode di una vivacità artistica e culturale unica, che può risultare inaspettata in un luogo conosciuto soprattutto per l’instabilità politica, l’inflazione, le divisioni razziali e le sanzioni internazionali che ne hanno accompagnato la storia.

Alcuni studenti della School of Visual Arts and Design, Mbare, Harare. Photo Bongani Kumbula
PROBLEM? NO, CHALLENGE
Questa unicità si può forse spiegare con l’innato senso estetico dei suoi abitanti, la cui eleganza si riflette anche nella forma di comunicare, pacata e costantemente tesa al rispetto verso l’interlocutore. In Shona, una delle lingue ufficiali del Paese, qualsiasi conversazione comincia così: “Buongiorno, come ti sei svegliato stamattina?”. “Mi sono svegliato bene, ma solamente se tu ti sei svegliato altrettanto bene”. L’eleganza si accompagna a una profonda capacità di resilienza, anch’essa riflessa nel linguaggio. In inglese, un’altra lingua ufficiale del Paese, gli zimbabwani non usano mai la parola “problem”, sostituendola sempre con “challenge”: i problemi non sono altro che sfide, che vanno affrontate e vinte.
La resilienza, la raffinatezza e la predilezione per forme espressive non violente hanno contribuito a sviluppare l’inclinazione artistica di questo popolo che, nonostante le poche scuole di arte presenti nel Paese, ha generato un numero sorprendente di talenti. Forse sono state proprio queste caratteristiche a permettere di fare delle sanzioni delle Nazioni Unite contro la Rodesia negli Anni Sessanta l’occasione per trasformare un campo di tabacco – prodotto colpito dall’embargo – in un atelier di scultura, che ha presto raggiunto fama internazionale. Le stesse caratteristiche hanno incoraggiato l’uso del mezzo artistico per esprimersi, in mancanza di altri spazi, durante i quasi quarant’anni di potere ininterrotto di Robert Mugabe (1980-2017).

Harare. Photo Jez Bennet
L’ARCHITETTURA DI HARARE
Che la capitale Harare – chiamata Salisbury prima dell’indipendenza – non sia la tipica metropoli africana soffocata da grattacieli, traffico, confusione e inquinamento, si coglie sin dal primo sguardo. Per buona parte dell’anno le sue strade hanno un’atmosfera incantevole, grazie ai petali viola dei jacaranda e rossi dei flamboyant che le ricoprono delicatamente. Anche gli spazi verdi non mancano e sono spesso testimoni della complicata e sofferta storia coloniale e post-coloniale del Paese. Ad esempio, il parco Africa Unity Square presenta una struttura somigliante alla Union Jack inglese. Questo elemento geometrico non è casuale: il parco fu costruito nel 1898 e giace dove i primi coloni inglesi posero la bandiera della madrepatria. La presenza coloniale si ritrova anche fra il verde degli Harare Gardens, creati all’inizio del Novecento dall’amministrazione coloniale inglese, al cui centro vi è un laghetto artificiale costruito nel 1937 per celebrare l’incoronazione di Giorgio V.
L’architettura della città è un’armonica sovrapposizione fra il periodo coloniale inglese (1890-1965), i quindici anni di potere della minoranza bianca rodesiana che dichiarò unilateralmente indipendenza dal Regno Unito (1965-1980) e lo Zimbabwe indipendente (dal 1980). Una passeggiata sulla via pedonale First Street, la zona dello shopping a partire dagli Anni Venti, permette di attraversare centotrent’anni di storia in pochi metri. L’edificio più antico risale ai primi anni del XX secolo ed è stato costruito dall’architetto James Cope-Christie. Conservato in perfetto stato, attualmente accoglie un fast food. Si trovano poi l’Edward Building, edificio degli Anni Trenta in stile Art Déco e oggi sede della TV Sales&Home, e i Batanai Gardens, un complesso in mattoni ispirato ai templi indiani, costruito nel 1986 dall’architetto Michael Pierce e così chiamato dal termine “batanai”, che in Shona significa “viviamo insieme”, per omaggiare l’aspetto cosmopolita degli uffici che lo avrebbero occupato. Ogni angolo di First Street offre qualche sorpresa, come il bassorilievo dal richiamo cubista realizzato negli Anni Cinquanta dallo scultore bergamasco Edoardo Villa sull’edificio della CBZ Holding, una compagnia di servizi finanziari. L’artista, che era stato prigioniero di guerra in Sudafrica durante la Seconda Guerra Mondiale, dopo la liberazione decise di rimanere nel continente, trovandovi grande spazio per la sperimentazione, al contrario dell’Europa, dove tutto gli appariva già provato, già fatto, ormai esaurito.
Nelle vicinanze di First Steet, è interessante l’Eastgate Center, un centro commerciale con negozi e uffici costruito nel 1996. Vincitore di riconoscimenti internazionali, è il primo complesso commerciale al mondo di grande magnitudine (26mila metri quadrati) a utilizzare un sistema naturale di regolamento della temperatura, senza uso dell’aria condizionata. Ispirato dai formicai, l’architetto Michael Pierce ha voluto creare un ecosistema sostenibile anziché un conglomerato per persone che lavorano.

Nell’atelier di Gareth Nyandoro a Ruwa, Harare. Photo Bongani Kumbula
MODA, DESIGN E MERCATI IN ZIMBABWE
La Duchessa di Cambridge, Kate Middleton, li ha indossati spesso: i gioielli fatti a mano in argento sterling e oro a 18 carati di Patrick Mavros sono una sintesi fra lusso e semplicità. Secondo la leggenda, il business familiare dei Mavros, che oggi vanta negozi a Nairobi, alle Mauritius e a Londra, comincia negli Anni Ottanta, quando il signor Mavros scolpisce a mano e regala alla futura signora Mavros degli orecchini. La galleria Mavros a Harare è un piccolo safari, con gioielli handmade dal design ispirato alla fauna del Paese. Celebre è la Ladies Pangolin Collection, che celebra il grazioso animale recentemente balzato, suo malgrado, agli onori delle cronache internazionali quale possibile veicolo della pandemia. Da anni Mavros è impegnato nella battaglia contro il bracconaggio dei pangolini in Zimbabwe, molto ricercati nel mercato clandestino internazionale per le sedicenti proprietà afrodisiache delle sue scaglie.
Sul fronte del design, e a breve distanza dalla Mavros Gallery, la coppia danese composta da Allard & Esther Ilsink ha da pochi anni aperto la Kumba Home and Gifts, che propone accessori e oggetti per la casa molto ricercati, fatti a mano in Zimbabwe, il cui design rappresenta un punto d’incontro fra Europa e Africa.
Una visita a Harare non può essere completa senza un passaggio per i mercati. L’Upmarket di Bottom Drawer è un sofisticato mercato di prodotti alimentari locali, nel quale l’artista Enok Kolimbo espone regolarmente i suoi lavori: arazzi tradizionali con design moderno eseguiti con tecnica batik. Imperdibile è poi l’Avondale Flea Market, dove l’inventiva degli artigiani permette di comprendere appieno il significato del termine Shona “kukiya-kiya”, traducibile con “darsi da fare per arrivare a fine mese”. Come in una fiera delle invenzioni, vi si trovano oggetti molto curiosi, spesso kitsch, ma con una indiscutibile utilità, come le simpatiche giraffe di perline porta-carta igienica.

Nell’atelier di Gareth Nyandoro a Ruwa, Harare. Photo Bongani Kumbula
LA RESISTENZA ATTIVA DELLA NATIONAL GALLERY
Per familiarizzare con la scena artistica di Harare è opportuno cominciare con una visita alla National Gallery of Zimbabwe, immersa nel verde degli Harare Gardens nel centro della città, che ospita una collezione permanente – un connubio fra pezzi di arte europea e africana – e numerose esposizioni temporanee.
Fondata dall’amministrazione coloniale britannica nel 1957 con il nome di Rhodes National Gallery, la galleria esemplifica perfettamente la capacità di resilienza presente in questo Paese. Istituzione pubblica, negli anni la galleria è sopravvissuta a eventi decisamente destabilizzanti: la tormentata decolonizzazione dal Regno Unito, ottenuta con una controversa dichiarazione unilaterale di indipendenza proclamata dal Governo rodesiano bianco suprematista di Ian Smith (1965), il tramonto della Repubblica di Rodesia e la nascita dello Zimbabwe sotto la guida di Mugabe (1980), nonché il recente colpo di Stato che ne ha provocato la deposizione (2017).
Questi intensi cambiamenti politici sono stati accompagnati da profonde oscillazioni economiche, con ben quattro cambi di valuta in soli quindici anni e la crisi inflazionistica del 2009, fra le più gravi che la storia mondiale ricordi. Malgrado tutto, non soltanto la galleria è riuscita a resistere, ma anche ad avventurarsi in diverse iniziative di successo volte a connettere lo Zimbabwe al mercato artistico internazionale.

Helen Teede, Witches, Whores, Feminists, 2021, tintura per tessuto e olio su tela, cm 160×240. Courtesy First Floor Gallery, Harare
SPAZI D’ARTE PRIVATI A HARARE
Accanto alla National Gallery esistono importanti spazi gestiti da privati. Il decano è Gallery Delta, fondata nel 1975. Si tratta di un progetto dell’insegnante Helen Lieros, inizialmente concepito come spazio di esposizione per la scultura locale, divenuto in seguito un centro promotore delle arti visive.
Molto più recente, ma altrettanto rappresentativa della scena artistica locale, è la First Floor Gallery Harare, una galleria di artisti e per artisti fondata nel 2009 e attualmente gestita da Marcus Gora e Valerie Kabov; è un autentico catalizzatore di eventi, formazioni, mostre, talenti, intorno al quale gravitano artisti locali e stranieri. Fra le varie iniziative, la galleria è impegnata a connettere gli artisti dello Zimbabwe fra loro e con quelli di altri Paesi africani. È membro promotore dell’Emerging African Art Galleries Association, che sostiene l’organizzazione strutturata di una scena africana e vuole offrire agli artisti un’alternativa autoctona alle gallerie europee o americane. First Floor ha partecipato, insieme ad altri spazi indipendenti africani, all’esposizione digitale African Galleries Now, in collaborazione con Artsy. Inoltre, First Floor Gallery ha aperto uno spazio vicino alle cascate Vittoria, per connettere gli artisti della zona alla scena di Harare.
In Zimbabwe, come nel resto del continente, le iniziative indipendenti si stanno moltiplicando. Nel 2012, ad esempio, una giovane coppia di artisti, Georgina Maxim e Misheck Masamvu, ha deciso di aprire la propria casa ad altri artisti, fondando la galleria-atelier Village Unhu.
Questi spazi sono catalizzatori di diversità e talento e sanno attrarre persone molto diverse sotto il profilo sociale, economico e razziale, cosa non affatto scontata in un Paese come lo Zimbabwe, ancora profondamente turbato dal recente passato coloniale e post-coloniale. Ma è proprio in luoghi come Harare che si comprende fino in fondo il potere di aggregazione dell’arte, che permette di sgretolare le differenze fra le persone, unendole attraverso la passione comune. Gli artisti stessi sono molto diversi fra loro, ma hanno deciso di uscire insieme dal circolo vizioso delle divisioni e degli stereotipi, comunicando in una lingua differente, per risolvere attraverso le arti visive i problemi che milioni di parole non sono state in grado di curare.

Helen Teede, Leopard’s Kop in August, 2019. Courtesy l’artista. Photo Bongani Kumbula
L’ASTRATTISMO DI HELEN TEEDE
Anche dopo aver ottenuto successo a livello internazionale, la maggior parte degli artisti continua a vivere in Zimbabwe, malgrado le difficoltà del Paese. Il legame con le proprie radici, tema ricorrente per gli artisti zimbabwani, viene declinato in molti modi diversi: mentre alcuni esprimono la fascinazione verso la natura, la magia, la tradizione, altri si concentrano sui sobborghi di Harare per comprendere ed esprimere le dinamiche sociali contemporanee. I lavori degli artisti ci restituiscono un’immagine articolata della società dello Zimbabwe – che lo accumuna con molti altri Paesi del continente africano –, stretta fra il desiderio di connettersi con il mondo e le conseguenze più nefaste della globalizzazione. Abbiamo riflettuto su questi temi con tre artisti di Harare, in diverse fasi della loro carriera.
La natura è sempre stata la protagonista dei lavori di Helen Teede (1988), artista di First Floor Gallery Harare che vive fra Venezia e Harare e i cui lavori sono stati esposti in Italia al Traffic Festival di San Lorenzo in Campo. Helen esplora l’articolata relazione fra la Terra e l’essere umano. I suoi lavori dal sapore astrattista catturano le emozioni suscitate dalla spettacolare natura del suo Paese, le sue riserve, le cascate Vittoria, i tramonti mozzafiato. In Zimbabwe, prima di iniziare una nuova tela, Teede cammina per giorni nei parchi naturali, raccogliendo rocce e altri materiali, in una fase che l’artista chiama il suo “outside studio”. Tornata in atelier, espone la tela bianca alle intemperie per giorni, per poi posizionarla orizzontalmente e disporvi i materiali raccolti durante le escursioni, perché direzionino il colore. Malgrado l’affascinante richiamo alla bellezza misteriosa della natura, le sue opere presentano un elemento sinistro e angosciante. Splendida e accattivante, la stessa terra è anche un catalizzatore di aggressività, non soltanto per la violenza delle piogge o per le intense siccità, ma dei contorti meccanismi di potere che portano l’uomo a cercare di comprenderla, alterarla e possederla, generando conflitti e cambiamenti climatici. L’artista si interroga sulla possibilità di creare nuove forme di dialogo fra l’uomo e la natura, basate su accettazione e rispetto. Spesso tratteggia delle figure umane che si dissolvono fragilmente nel paesaggio, nell’inutile tentativo di comprenderlo, incapaci di dominarlo. L’elemento figurativo emerge più prepotentemente nella sua serie più recente, che Helen ha intitolato Artemisia, ispirandosi alla dea greca protettrice della natura, alla pittrice Artemisia Gentileschi, nonché, curiosamente, al nome di una delle erbe tradizionali dello Zimbabwe. Helen spiega che questi lavori sono una sintesi fra la sua identità africana e la residenza a Venezia e riflettono il diverso approccio al corpo, soprattutto al corpo femminile, che l’artista ha percepito nella cultura italiana rispetto a quella africana e che l’ha spinta a reinterrogare la relazione fra corpo e natura. Helen ricerca un universo femminista, egalitario e orientato verso la comunità, in contrasto con le scelte patriarcali e capitaliste che hanno segnato il nostro pianeta fino ad oggi.

Takadiwa, Land of Coca Cola and Colgate, 2019
LA SPAZZATURA DI MOFFAT TAKADIWA
Utilizzare rifiuti per creare opere d’arte non è certo una novità. Di solito è una scelta, ma per alcuni è una pratica nata dalla necessità e dalla speranza di recuperare fra la spazzatura qualcosa di utile per creare opere d’arte, quando pennelli, carta e colori scarseggiano. È in questo modo che Moffat Takadiwa (1983) ha cominciato a familiarizzare con i rifiuti delle periferie di Harare e ne ha colto l’espressione dello Zimbabwe contemporaneo: il regno del Colgate e della Coca-Cola. La spazzatura di questi sobborghi riflette una società che è stata violentemente colpita dalla globalizzazione e che, pur essendo formalmente decolonizzata, rimane soffocata, letteralmente sommersa, dai grandi brand occidentali, che dominano il commercio e la cultura. Fra i rifiuti di Mbare, un quartiere densamente popolato nella parte suburbana di Harare, Moffat recupera lattine, scatolette, tastiere e le lavora secondo una tecnica di tessitura della tradizione korekore, il gruppo etnico del nordest dello Zimbabwe da cui proviene l’artista. Questa tecnica segue regole specifiche, alternanze e simmetrie che esprimono un altro linguaggio, alternativo ai grandi centri di potere economico globale.
Moffat vanta numerose personali in città come Los Angeles, Parigi, Milano ma, malgrado le molteplici possibilità di scelta ottenute grazie al successo internazionale, continua a vivere a Mbare, con cui ha sviluppato una relazione di interdipendenza. Da un lato, Moffat necessita di questo sobborgo, della sua confusione, dei suoi tre grandi mercati e della sua spazzatura per continuare ad analizzare e interpretare la società. Dall’altro, poiché a Mbare non vi sono molte opportunità per i giovani artisti, Moffat sta trasformando il suo studio in un distretto artistico dove ospitare art residencies e connettere gli artisti locali alla scena internazionale.

Tom Tafadzwa, Bereaved Filaments, 2020
IL GIOVANISSIMO TALENTO DI TOM TAFADZWA
Anche i giovanissimi studenti di arti visive cercano incessantemente un dialogo con la società complessa e contraddittoria nella quale vivono, esprimendo la propria inquietudine per il futuro, resa ancora più intensa e drammatica dagli eventi dell’ultimo anno. Tuttavia, intrattenersi con gli studenti della National Gallery of Visual Arts and Design School nel sobborgo di Mbare, una delle zone meno abbienti di Harare, offre speranza sul potenziale delle nuove generazioni nel Paese.
La scuola è stata aperta nel 1981 con il supporto della British American Tobacco, ereditando l’esperienza della prima scuola d’arte del Paese, istituita da Frank McEwan alla fine degli Anni Cinquanta. La National Gallery organizza regolarmente la Green Shots Exhibition, in cui ospita i lavori degli studenti, guidandoli verso il mercato dell’arte.
Fra gli studenti che abbiamo incontrato nella scuola colpisce il ventenne Tom Tafadzwa, le cui opere presentano crude considerazioni sulla società, dove manca la coesione fra gli individui, rappresentati come enormi mani o grandi piedi, espressione di una presenza nel mondo priva di interiorità e di sentimenti. Nel suo ultimo lavoro, Bereaved Filaments, esprime l’effetto disfunzionale della pandemia sulla società attraverso la metafora della fornitura elettrica, la cui intermittenza è un grande problema per gli zimbabwani. Il giovane artista constata in modo sconfortante che ogni Paese, ma anche ogni individuo, è rimasto solo e isolato nel proprio dolore e lutto, circondato da un’umanità inutile, incapace di trasmettere empatia, come fili elettrici – che Tom ha rappresentato attraverso un collage di fili di lana – che non portano elettricità. L’amara ironia e l’aspetto caricaturale dei suo lavori trasmette solitudine e sfiducia, ma è anche l’espressione di una generazione che, per sempre marcata dalla pandemia, chiede un profondo cambiamento.

Terrence Musekiwa, African Royal (Mambo), 2019. Courtesy l’artista & Catinca Tabacaru Gallery
LA SCULTURA SHONA E LE SANZIONI DELL’ONU
Nel 1965 la Rodesia si dichiara unilateralmente indipendente dal Regno Unito, su iniziativa del Governo rodesiano di Ian Smith. L’ONU lo definisce un “regime minoritario razzista” e adotta sanzioni economiche contro la Repubblica di Rodesia. L’embargo colpisce anche le esportazioni di tabacco, costringendo molti imprenditori rodesiani, fra cui Tom Blomefield, a interromperne la produzione.
Invece del tabacco, Blomefield decide di coltivare il suo hobby: la scultura. Coinvolgendo i braccianti delle sue piantagioni nella città di Tengenenge, a 150 chilometri a nord della capitale Salisbury (ora Harare), Blomefield trasforma il campo di tabacco in un atelier di scultura. I braccianti diventano scultori e la prossimità della proprietà di Blomefield alla Great Dyke – una diga naturale ricca di minerali e rocce serpentinitiche – offre un’opportunità unica per reperire la materia prima. Se Blomefield mette a disposizione spazi e risorse, i braccianti apportano la componente creativa, traendo ispirazione dalla tradizione religioso-spirituale locale, una fusione fra Cristianesimo, misticismo e antico folklore. Le opere degli scultori riproducono i valori solidi propri della cultura locale: il rispetto per le forze della natura, la centralità della famiglia, la fertilità femminile, la saggezza degli anziani
Parallelamente all’esperienza di Tengenenge, anche il primo direttore della Rhodes National Gallery (ora National Gallery of Zimbabwe), Frank McEwan, si interessa alla scultura, fondando un’apposita scuola nei primi Anni Sessanta. McEwan promuove la scultura della Rodesia nel mondo, organizzando esposizioni a New York (La nuova arte africana, MoMA, 1968), Parigi (Scultura contemporanea degli Shona d’Africa, Museo Rodin, 1971), Londra (Scultura Shona della Rodesia, Institute of Contemporary Arts, 1972).
La scultura locale diviene internazionalmente conosciuta come Shona, dal nome dell’etnia maggioritaria dello Zimbabwe, anche se in realtà, sin dagli inizi, molti scultori appartengono ad altri gruppi etnici. Alcuni sono lavoratori migranti, giunti in Rodesia dai Paesi limitrofi in cerca di opportunità, come Amali Malola (1921-2015), partito dal Malawi per lavorare come bracciante stagionale nel campo di tabacco di Tengenenge. Malola non poteva immaginare che, complici le sanzioni dell’ONU, sarebbe diventato uno dei più grandi artisti rappresentativi della scultura tradizionale Shona.
Durante gli Anni Settanta e Ottanta la scultura Shona fiorisce e diviene l’espressione artistica più conosciuta e apprezzata della Rodesia, e in seguito dello Zimbabwe. Le famiglie di scultori si tramandano il savoir-faire di generazione in generazione, mentre il campo di tabacco di Tengenenge non tornerà mai più alla sua originale funzione, nemmeno una volta revocate le sanzioni dell’ONU nel 1979. Ancora oggi è il punto di riferimento per la formazione di nuovi talenti, nonché una meta imperdibile per gli appassionati di scultura. Attualmente le sculture Shona fanno parte della collezione permanente di moltissimi musei, come il British Museum, che espone i lavori di Henry Munyaradzi (1931-1998), appartenente al gruppo di scultori di Tengenenge.
La scultura ha rappresentato il mercato principale per gli artisti locali, fino almeno alla fine degli Anni Ottanta, quando cominciano ad avvertirsi i primi segni di affaticamento. Da una parte il mercato è saturo, dall’altra, fra le nuove generazioni di scultori, alcuni sentono la necessità di introdurre un elemento di criticità e discontinuità con la tradizione. Molti cercano infatti un dialogo con le complessità della società contemporanea dello Zimbabwe, dialogo che è assente nella scultura tradizionale, rivolta esclusivamente a preservare memoria, spiritualità e folklore.
Così, accanto agli scultori “puristi”, alcuni giovani decidono di intraprendere un percorso sperimentale, fondendo la tradizione scultorea Shona con materiali che riflettono la società contemporanea e la vita odierna nelle comunità dello Zimbabwe. Lo scultore contemporaneo più rappresentativo di questa tendenza è Terrence Musekiwa, classe 1990, uno degli artisti che rappresenta lo Zimbabwe alla Biennale di Venezia del 2022. Terrence appartiene alla terza generazione di scultori ed esprime perfettamente il ponte fra tradizione e modernità. Ogni suo lavoro comincia lavorando la pietra secondo la tecnica Shona, a cui però vengono aggiunti oggetti di provenienza industriale come cavi, metalli e plastica, che riflettono lo Zimbabwe moderno e che l’artista raccoglie per le strade. Musekiwa cerca così di tracciare il viaggio del popolo dello Zimbabwe dal recente passato basato su spiritualità e magia alle complessità della società contemporanea, affetta da problematiche politiche ed economiche, ma ancora profondamente legata ai valori tradizionali.
http://www.tengenengeartcommunity.com/

Raphael Chikukwa. Courtesy National Gallery of Zimbabwe
NATIONAL GALLERY OF ZIMBABWE. INTERVISTA A RAPHAEL CHIKUKWA
Inaugurata dalla Regina Madre nel 1957, la National Gallery of Zimbabwe ha avuto una capacità straordinaria di resistere a tutto quello che il Paese ha vissuto negli ultimi settant’anni, preservando una continuità culturale e artistica con il passato, malgrado i conflitti e le divisioni di cui il Paese ha sofferto. La galleria ha oggi tre sedi nel Paese: nella capitale Harare e nelle città di Bulawayo e Mutare. Inoltre, da dieci anni, grazie alla guida di Raphael Chikukwa, zimbabwano formatosi a Londra, il museo sta connettendo la scena artistica locale con il mercato internazionale. Una delle prime iniziative di Chikukwa è stata garantire allo Zimbabwe, dal 2011, una presenza fissa alla Biennale di Venezia.
Anche nel 2022 lo Zimbabwe ha un padiglione alla Biennale di Venezia. Quali sono le challenge per un Paese africano nel partecipare alla Biennale?
La partecipazione dei Paesi africani alla Biennale di Venezia era attesa da molti anni. Spesso ci lamentiamo della mancanza di opportunità, ma dobbiamo anche essere consapevoli che queste opportunità non arrivano senza sforzi e che dobbiamo lavorare per coglierle. Le istituzioni culturali in Africa hanno il ruolo e la responsabilità di sostenere gli investimenti nell’arte e di avviare la volontà politica in questa direzione. Convincere i miei concittadini e le istituzioni della necessità di investire in un Padiglione dello Zimbabwe è stata per me una sfida, ma dopo più di dieci anni di presenza alla Biennale sono orgoglioso dei risultati. Il sostegno alle nostre iniziative è benvenuto, ma vogliamo essere noi a dettare le regole. Saremo per sempre grati a chi ha appoggiato la prima apparizione dello Zimbabwe alla Biennale di Venezia: il British Council, la Missione dell’Unione Europea in Zimbabwe, l’Ambasciata italiana, l’Ambasciata svizzera, Culture France, il Museo di Monaco e Culture Fund Trust Zimbabwe, solo per citarne alcuni.
Quanto è importante l’indipendenza culturale?
L’indipendenza artistica e culturale dell’Africa è stata uno dei principi ispiratori dei padri fondatori del movimento di liberazione africano, ed è tanto importante quanto la nostra indipendenza politica ed economica. Questa indipendenza culturale è stata rivendicata per molti anni dalla diaspora di curatori africani, ad esempio Okwui Enwezor, il primo curatore africano della Biennale di Venezia nel 2015, Simon Njami, Sallah Hassan, Olu Oguibe, Gilane Tawandros e molti altri. Sono felice di vedere così tante iniziative fiorire nel continente negli ultimi anni, attraverso l’impegno pubblico, ma anche con progetti artistici indipendenti, come la First Floor Gallery di Harare, il Nairobi Art Trust, la Biennale di Kampala, la Biennale di Dakar, i Rencontres di Bamako, Cape Town Art Fair, Joburg Art Fair, Art X Lagos e la Biennale di Lagos…
La partecipazione a piattaforme internazionali come la Biennale può cambiare l’immagine dell’Africa?
L’Africa è spesso rappresentata come un bambino povero e bisognoso, ma noi non siamo più i bambini che piangono. Partecipare a eventi come la Biennale di Venezia ci permette di raccontare la nostra storia, che è stata a lungo raccontata da altri. Si tratta di un’opportunità che cambia la vita per gli artisti e i curatori africani, permettendo loro di demistificare i preconcetti sul nostro continente e di mostrarlo sotto la nostra prospettiva. Non vogliamo rimanere passeggeri della nave: vogliamo guidare il nostro destino. Le immagini che vediamo sulle agenzie di news internazionali non rappresentano davvero l’Africa. La partecipazione degli artisti africani a eventi come la Biennale è fondamentale. Non abbiamo mai raccontato la storia dell’Occidente: perché l’Occidente dovrebbe continuare a voler raccontare la nostra storia?
A proposito di indipendenza, ci parli di Zimbabwe41?
Zimbabwe41 è una nuova collezione permanente con tutte le opere che la galleria ha acquisito dall’indipendenza del Paese, quarantadue anni fa, a oggi. All’interno di questa collezione stiamo sviluppando anche una “collezione Biennale di Venezia”, che raccoglie le opere del Padiglione Zimbabwe esposte a Venezia negli ultimi dieci anni. È un modo per celebrare la continua partecipazione dello Zimbabwe alla Biennale. Stiamo anche cercando di ottenere un budget per acquisire opere di altri artisti africani in mostra alla Biennale. Nella maggior parte dei casi, queste opere vengono acquistate da istituzioni e collezionisti occidentali. Desideriamo invertire questa tendenza e far tornare quelle opere in Africa.
Come la pandemia ha influito sul vostro lavoro?
Oltre alla tragica perdita dei nostri cari, la pandemia ci ha privato anche del contatto fisico: ci mancano gli abbracci, ci mancano i baci, ci manca incontrarci alle fiere e alle biennali di tutto il mondo. Ma è stata anche una chiamata per il mondo intero, un’opportunità di rinascita, di ripensamento, per riflettere e agire fuori dagli schemi. Per noi la pandemia ha rappresentato una spinta per recuperare il ritardo con il resto del mondo nel campo della digitalizzazione. Ad esempio, abbiamo potuto partecipare a eventi virtuali con istituzioni come il MoMA e Art Basel, cosa che sarebbe stata molto più complicata e costosa – per noi e per l’ambiente – prima della pandemia. Abbiamo anche avviato una serie di discussioni online chiamate Harare Conversations e lanciato mostre virtuali sul nostro sito web.
Nel novembre 2021 la National Gallery ha organizzato la terza conferenza internazionale sulla cultura africana. Qual è stata la tematica?
Abbiamo affrontato il lungo, oscuro e doloroso problema del rimpatrio del patrimonio e degli archivi africani, saccheggiati durante l’era coloniale, facendo seguito all’impegno ufficiale del presidente francese di aprire la strada al rimpatrio dell’eredità africana attualmente conservata nei musei occidentali. A volte il contributo dell’Africa alla civiltà viene messo in dubbio e veniamo etichettati come un “popolo primitivo”. Se così fosse, allora perché i musei in Occidente non sarebbero disposti a restituire i nostri oggetti? Questi oggetti ci appartengono e il loro significato per il popolo africano non è stato pienamente realizzato a causa della loro prigionia nei cosiddetti “musei” in Europa e in America. L’accessibilità di questi oggetti per gli africani è limitata perché affrontiamo restrizioni di viaggio, la necessità di sottoporci a una complessa procedura di visto, umiliazioni alle frontiere… Ricercatori, artisti e curatori africani devono dichiarare i loro parenti, cani e gatti, compresi i loro antenati morti più di duecento anni fa solo per ottenere un visto di una settimana o un mese.
Si tratta di un discorso “limitato” alle opere d’arte?
Ci interessa anche la questione del rimpatrio dei resti umani attualmente conservati nei musei della scienza in Occidente, spazi che potrebbero essere descritti come “scene del crimine” di quanto accaduto durante la colonizzazione. Il loro rimpatrio può contribuire al processo di guarigione delle cicatrici coloniali. Dovremmo anche pensare al trattamento di questi resti mortali una volta che ci saranno restituiti, fornendo loro una degna sepoltura. Sarà importante affrontare questa discussione a Harare, poiché faciliterà lo scambio di idee all’interno del continente e la crescita di un dialogo continuo africano, su chi siamo come africani. A volte ho l’impressione che io e i miei colleghi africani ci incontriamo più in Europa che in Africa… Credo nella connessione Africa-Africa, che è la chiave per realizzare i nostri sogni, piuttosto che i sogni altrui.
‒ Paola Forgione
https://dev.nationalgallery.co.zw/
Versione aggiornata dell’articolo pubblicato su Artribune Magazine #61
Abbonati ad Artribune Magazine
Acquista la tua inserzione sul prossimo Artribune
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati