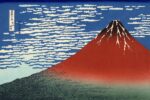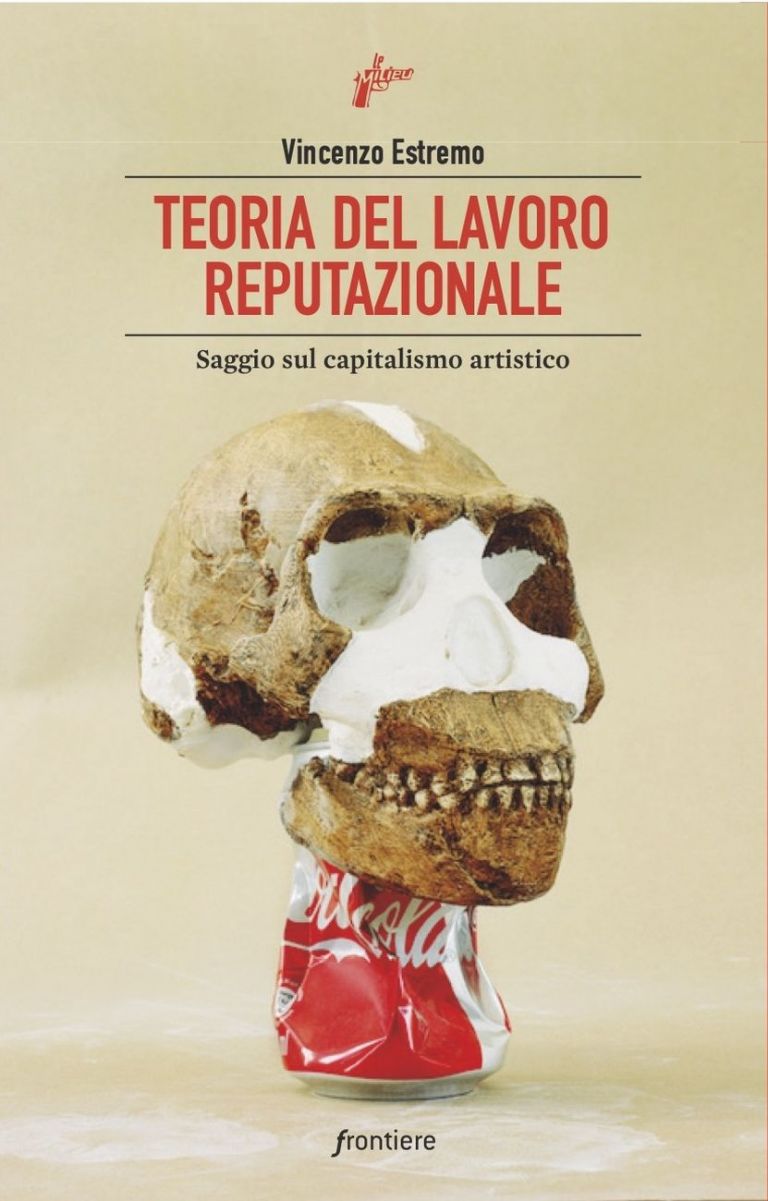Un libro sul lavoro nell’arte. Intervista a Vincenzo Estremo
Vincenzo Estremo (Caserta, 1980) è un teorico dell’immagine in movimento, docente di teoria dei media, curatela e fenomenologia dell’immagine presso la NABA di Milano, co-dirige la collana editoriale Cinema and Contemporary Art (Mimesis International) ed è tra i fondatori e caporedattore di Droste Effect. Nel suo libro Teoria del lavoro reputazionale affronta i problemi relativi […]

Vincenzo Estremo (Caserta, 1980) è un teorico dell’immagine in movimento, docente di teoria dei media, curatela e fenomenologia dell’immagine presso la NABA di Milano, co-dirige la collana editoriale Cinema and Contemporary Art (Mimesis International) ed è tra i fondatori e caporedattore di Droste Effect. Nel suo libro Teoria del lavoro reputazionale affronta i problemi relativi ai lavori culturali che, nel tempo, stanno perdendo professionalità in favore della visibilità e della reputazione personale. Supportato dalla rivoluzione tecnologica sviluppata negli ultimi anni, il capitalismo si sta sempre più insediando nel settore della cultura promuovendo nuove forme di lavoro deleterie e incerte.
INTERVISTA A VINCENZO ESTREMO
Con Teoria del lavoro reputazionale volevi generare una riflessione attorno alle precarie condizioni del lavoro contemporaneo, esaminando la dinamica in cui ci muoviamo. Quali sono le riflessioni personali che ti hanno spinto a produrre un’opera teorica su un lavoro ormai diventato il simbolo dello sfruttamento?
Ho provato a raccogliere le esperienze di lavoro precario nel settore dell’arte contemporanea e a metterle in relazione con la crescente deregolamentazione dovuta alla platformization e più in generale all’ingerenza dei media globali sul lavoro. Inoltre, partendo da una posizione privilegiata di lavoratore dell’arte che è passato attraverso crisi finanziarie che hanno prodotto un terremoto nel mondo delle tutele del lavoro, ho provato a fare una sorta di autoetnografia dell’incertezza professionale di un settore che punta molto sulla retorica della specializzazione professionale.
Ovvero?
Sono partito dall’erosione dei diritti provando a capire in che modo l’arte contemporanea avesse sistematicamente anticipato alcune delle tendenze di precarizzazione basate sulla deresponsabilizzazione dei datori di lavoro e la costante affermazione di un’ideologia imprenditoriale da far gravare sul lavoratore stesso. L’arte è un settore ampio e multiforme e tutta la moltitudine di lavoratrici e i lavoratori che ne permettono l’esistenza spesso sognano una stabilità e una garanzia professionale che viene invece svilita da una retorica reputazionale. Proprio intorno al nucleo tematico della reputazionalità ho, infatti, provato a costruire il filo conduttore del testo.
In che modo?
Si tratta di comprendere come, in una società ampiamente occupata dalle logiche del neoliberalismo e altamente basata sull’immagine così come quella dell’occidente post-industrializzato, la reputazione diventi strumento di occultamento del potere, come diceva Machiavelli. Ho provato quindi a costruire una piccola teoria dell’opacità mediatica attraverso le riflessioni di teorici e artisti. Un testo che da un lato era una necessità personale di racconto e dall’altro uno sprone verso una critica istituzionale del lavoro artistico.

Vincenzo Estremo – Teoria del lavoro reputazionale (Milieu Edizioni, Milano 2020)
SCRITTURA PER L’ARTE E FUTURO
Nel libro parli anche di un cambiamento radicale nei confronti della scrittura per l’arte. Anche se sappiamo quanto l’arte contemporanea abbia quasi totalmente eliminato la concezione estetica del prodotto, per i non lavoratori del settore risulta spesso inaccettabile che l’arte si occupi di politica. Nel libro hai cercato di dare un senso politico a una questione rinchiusa nel ramo artistico ma che, in fondo, ci riguarda tutti. Secondo te ci sono effettive prospettive di miglioramento per il futuro lavorativo?
Credo che cambiare registro nella scrittura per l’arte sia una necessità, quantomeno credo che lo sia in Italia, perché altrove l’art writing è già una realtà. A dire il vero qualcosa sta già accadendo, è una di quelle cose positive che derivano da un’attitudine a scrivere e a leggere sul web. Non sempre la rete è deleteria. Per troppi anni si è fatta critica delle forme, e credo che la complessità della contemporaneità non possa essere solo una cosa semiotica, ma debba essere necessariamente una teoria sinergica, perché è l’arte stessa a essere divenuta una teoria critica. Una consapevolezza politica del proprio ruolo di lavoratrice e lavoratore passa necessariamente da una comunicazione differente, etica e di lotta. Per quanto riguarda la scrittura, credo che debba funzionare come dispositivo di confronto, magari abbandonare sempre di più una dimensione autoriale e diventare uno strumento di crescita collettiva. Per anni abbiamo sottolineato quanto la socialmedialità avesse riposto la scrittura al centro della nostra dimensione pubblica: se questo è successo, allora dobbiamo ripensare al ruolo della scrittura anche nella ristrutturazione e nella riaffermazione di prospettive di lavoro diverse da quelle in cui siamo impigliati.
E per quanto riguarda i miglioramenti?
I miglioramenti nelle prospettive di lavoro vorrei tanto che ci fossero, ma questo è il momento di non cedere ai, o accettare i, ricatti. Quello della salute innanzitutto, quello della crisi, quello del “sono tempi difficili”, è il momento di fare quadrato, magari stabilire alleanze. Io per esempio guardo con interesse a quello che negli anni recenti hanno fatto i lavoratori e le lavoratrici della gig-economy, dagli ingegneri di Google ai rider di Glovo e Just Eat, c’è molto da imparare sul come combattere il nemico della piattaformizzazione dell’economia. Certo tutti i settori oggi sono a rischio di auto-convincimento reputazionale, con il rischio per i lavoratori di farsi invischiare in una retorica individualista che li rende frutti inconsapevoli di un’ideologia neoliberale. Convinti che essere visibili li renderà ricchi, famosi, di certo migliori e, chissà, forse anche belli!

Nicholas Korody, Domestic Standard, 2020, still da video
ARTE E CAPITALISMO
Nel libro si parla di moltissimi artisti, toccando temporalità e territorialità differenti. L’aspetto più interessante emerge dalla considerazione che fai sul rapporto tra arte e capitalismo e di come siano strettamente legati. Esiste quindi, per te, un modo in cui nel futuro si potrà produrre un’arte slegata da dinamiche capitalistiche, magari sfruttando i nuovi media?
È vero, ho analizzato la contemporaneità dell’arte provando parallelamente a leggere il capitalismo in uno dei suoi stadi che, se ho definito artistico, è perché ho voluto sottolineare il modo in cui funzioni parassitariamente proprio a partire da pulsioni che solo l’arte riesce ad attivare. Questa enorme macchina del consumo, che orienta le nostre passioni e i nostri desideri a proprio vantaggio, funziona da catalizzatrice e proprio sulla sua forza magnetica bisogna agire. A partire da questa presa di coscienza, credo sia necessario proseguire a lavorare sulle possibilità e dare seguito agli sforzi migliori che in questi anni si sono susseguiti, per proporre una struttura di pensiero che nell’arte sia capace di accogliere e dare continuità alle lotte. Innovare e rendere critico quello che ha perso il suo potere sovversivo perché “non si tratta di introdurre ex novo una scienza della vita”, come sosteneva Antonio Gramsci, ma di innovare e rendere critici degli strumenti che esistono già.
E sul fronte mediatico?
Credo sia oramai più un discorso di media ecology che di nuovi media, ed è in questa direzione che credo si debba guardare, riflettere sul modo contraddittorio in cui la tecnologia sforna aspirazioni sempre più universali – dal cyberspazio a Internet – e su come in realtà funzioni per segregazioni. Se non c’è tanto da combattere contro le grandi piattaforme dell’immagine, è anche vero che le si può capovolgere, o almeno si può rovesciare la logica con cui funzionano. Credo che uno dei ruoli dell’arte stia proprio nella continua ricerca di un’alternativa antiegemonica, di trasformare e ridistribuire, di rovesciare le logiche produttiviste dell’algoritmo. Come fare ciò? Ripartire dal contingente, preferire il tattico allo strategico, riacquistare potere contrattuale. Se “inventare il futuro”, come suggeriscono Srnicek e Williams (2015), è necessario, farlo partendo dal conflitto è obbligatorio.

Christian Jankowski, Telemistica, 1999, still da video
INTERNET E LE IMMAGINI
Internet è un mondo che ha creato molte spaccature nel tessuto sociale della realtà, abbiamo visto negli anni nascere nuovi fenomeni che sfruttano l’apparente immaterialità dei dati, delle personalità e delle idee; nel libro spieghi come questi inganni siano stati accettati dalla società perché occultati e mascherati dietro a tecnicismi e omissioni di molte dinamiche come quella del Cloud Computing. Pensi ci sia una via di scampo dal controllo sociale attraverso questi sistemi mediatici, oppure andremo verso un mondo che governa e controlla attraverso una sorta di “Grande Fratello”?
Con tutto quello che è successo in questo ultimo anno, a volte credo che, pur provando, mi sarà difficile pensare qualcosa di più distopico della storia recente. Quindi, più che pensare al futuro, credo che osservare (e magari analizzare) il presente mediatico in cui siamo possa essere utile. Il controllo a cui fai riferimento è un dato di fatto, qualcosa che deriva dal passato ma che se ne discosta. La governamentalità algoritmica è diversa da quella centralizzata e disciplinare del Grande Fratello. Diciamo che alla logica del vertice controllore si sono sostituiti i device che fanno da cellule periferiche, quindi più che parlare di governo del controllo dovremmo parlare di innervazione del controllo. La capillarizzazione delle informazioni sta ovviamente trasformando la società, dalla politica alla ricerca scientifica, dai rapporti sociali alle forme di lavoro, in modo opaco. Una sorta di oligarchia paradossalmente fondata sulla partecipazione di tutti, un incanto collettivo e irresistibile in cui collettivamente affidiamo a pochissimi gruppi privati la possibilità di determinare processi su scala globale.
Le vie di fuga esistono, immagino che sempre più spesso sentiremo parlare di spazi e luoghi della disconnessione, o semplicemente di attitudine alla disconnessione, che non vuol dire anarcoprimitivismo, ma semplicemente gestione dei flussi di informazioni e capacità di ragionare fuori dalla connettività, o viceversa un pensiero sinergico con la tecnologia, anche in questo caso, magari non alla Musk con i sui microchip, ma una integrazione post-biologica dell’umano con la macchina.
Nel libro si parla anche di immagini. Gli artisti utilizzano ormai largamente sistemi digitali per diffondere immagini ma, allo stesso modo, stanno facendo grandi aziende e multinazionali. Pensi ci sia un modo reale per imparare a leggere correttamente le immagini o l’umano ne sarà sempre soggiogato?
La partita dell’immagine è più aperta che mai. Se è vero che gli studi visuali da tempo si occupano di immagine in senso allargato, è altrettanto vero che il pregiudizio secondo cui vi siano delle classi valoriali dell’immagine è altrettanto vivo. Credo, e lo dico esplicitamente nel libro, che l’immagine sia diventata uno strumento al servizio del capitale. Parlo di Immcoin come di una moneta di validazione non estetica ma reputazionale. Lo spazio in cui viviamo è saturato dall’immagine, il nostro mondo si definisce in relazione alla propria possibilità di essere visibile. Questo processo è l’ennesimo parossismo del tardo-capitalismo: le traveling images, per citare Steyerl e Demos, stanno scrivendo una nuova storia della nostra civiltà, una storia che coniuga circolazione e mercificazione, immagine e sguardo. Il cannibalismo dell’immagine ‒ niente meglio della visualizzazione iconica ha funzionato nella transcodifica culturale del digitale ‒ ha inglobato ogni cosa. Dalle icone dei sistemi operativi al cinema (il grande conduttore di sguardi) alle tecniche contemporanee di eye-tracking che monitorano ogni movimento dei nostri occhi, sino alla termografia, tutto contribuisce a una teoria dell’intersezione tra immagine ed economia. In questo scenario di ecologia dell’immagine mediatica è ovvio che sia importante imparare a leggere l’immagine. In realtà penso che sia sempre più necessario aggiornare alcune discipline didattiche con seminari intensivi di analisi dell’immagine, e, di nuovo, non ne faccio una questione estetica, ma una necessità politica e sociale, una alfabetizzazione visuale che spesso manca e che in una società come la nostra produce enormi disuguaglianze. Una politica democratica delle uguaglianze, oggi, passa necessariamente dalla capacità collettiva di conoscere e orientarsi nella galassia dell’immagine.
‒ Lucrezia Arrigoni
Vincenzo Estremo – Teoria del lavoro reputazionale. Saggio sul capitalismo artistico
Milieu Edizioni, Milano 2020
Pagg. 176, € 15,90
ISBN 9788831977487
www.milieuedizioni.it
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati