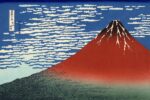L’ultima lezione di Chris Burden
È morto il 10 maggio Chris Burden, uno dei più importanti artisti del secolo scorso. Memorabili le sue performance estreme, ma la sua eredità è ben più vasta. La riflessione di Marco Senaldi.

LA SINDROME DI VAN GOGH
Viviamo in tempi davvero strani. Siamo talmente convinti che non esistano più eroi, che ci rendiamo conto del contrario solo quando ne scompare uno. È solo allora che, con un soprassalto di incredulità, ci chiediamo perché – perché questo eroe non lo abbiamo seguito più da vicino, perché ci siamo distratti quando era vivo e poteva ancora risponderci, perché non ne abbiamo celebrato apertamente il mito, perché… Ma tutte queste domande arrivano quando ormai è troppo tardi.
Non che Chris Burden, nato nel 1946 e morto il 10 maggio 2015 all’età di 69 anni, abbia lasciato qualcosa di inespresso, oppure non sia stato apprezzato a sufficienza dai suoi contemporanei. Tutt’altro: quando iniziò la sua carriera artistica, la “sindrome di van Gogh” aveva già reso gli adepti dell’artworld talmente ipersensibili anche al minimo accenno di genio incompreso che chiunque avrebbe preferito fare dei madornali errori di sopravvalutazione piuttosto che doversi pentire per aver ridotto a martire anche solo una promessa.
E nel caso di Burden le cose andarono davvero così: pochi mesi dopo aver ottenuto la laurea, diede vita a una serie di performance che ben presto si colorarono di leggenda e, lungi dall’essere rifiutate come anti-artistiche, contribuirono a fare del loro autore uno tra i più giovani protagonisti della scena mondiale dell’arte.
PERFORMANCE ESTREME
Del resto, ripensando alla sua “tesi di master” alla University of California at Irvine, Five Days Locker Piece (1971), in cui rimase chiuso in un armadietto per cinque giorni bevendo solo dell’acqua, o a Shoot, dello stesso anno, in cui, con l’aiuto di un assistente, si fece sparare addosso da distanza ravvicinata, ferendosi a un braccio, o a Doomed (1975), dove rimase immobile per 45 ore sotto un vetro in una sala del MoCA di Chicago, si resta davvero colpiti dall’eccezionale precocità delle sue intuizioni e insieme dalla maturità con cui erano condotte.
Si potrebbe dunque riassumere la parabola di Burden in poche righe, dicendo che fu uno dei più estremi sperimentatori di una nuova forma d’arte, in cui impiego del corpo, pericolo e spettacolo si riunivano in quell’insieme dai contorni definiti che oggi chiamiamo performance. Eppure, benché contenga degli elementi di verità, questo sarebbe un riassunto evidentemente riduttivo, per non dire del tutto fuorviante: non solo perché le sue performance restano un esempio veramente unico nel variegato panorama della Body Art internazionale, ma soprattutto perché, senza venir meno ai suoi rigorosi presupposti estetici, a partire dagli Anni Ottanta Burden ha saputo trasfondere la sua tecnica espressiva in una incredibile serie di installazioni e sculture.

Chris Burden, Dead Man, 1972
UNO STILE PROTOCOLLARE
Si dovrebbe quindi cominciare col dire che il tratto epico delle sue gesta iniziali è largamente dovuto a una interpretazione alimentata da quei pochi scatti sfocati, quasi da cronaca nera, che circolavano su riviste e cataloghi del periodo. In realtà, Burden si differenzia dalla gran parte dei body artisti coevi, soprattutto europei, proprio per l’assenza di ogni ingrediente drammatico e di ogni sottotesto narrativo; più che racconti simboleggiati da un gesto (come nel caso di Marina Abramovic, Gina Pane o Urs Luthi) quelle di Burden sono performance “sperimentali”, veri e propri test di resistenza.
Non a caso, a fronte del rischio a cui spesso si esponeva per realizzarli, l’artista si limitava sempre a indicazioni quasi protocollari, che risultano perciò ancor più sconvolgenti. La descrizione di Deadman, un’azione in cui Burden, coperto da un telone, si collocava nel mezzo di una superstrada a Los Angeles, è di questo tenore: “Alle 8 p.m. mi sono sdraiato su La Cienega Boulevard [a Los Angeles] coperto completamente da un telo impermeabile. Due torce da 15 minuti erano poste accanto a me come segnale per le auto. Poco prima che le torce si esaurissero è arrivata un’auto della polizia e io venni arrestato per procurato allarme”.

Chris Burden, 747, 1973
PROTAGONISTA È LO SPAZIO
Questo stile impersonale si collega a una costante riflessione sulla de-soggettivazione dello spazio, che, nelle sue molteplici accezioni, è il vero protagonista delle azioni di Burden. Sia che esse si svolgano in luoghi reclusi (da un armadietto universitario al locale caldaie come in The Visitation, 1974), in contesti urbani (da Main Street a L.A., di Through the Night Softly, 1973, all’aeroporto di Los Angeles di 747, 1973, in cui sparava a un aereo di linea) o in dimensioni imprecisate (il deserto attraversato con la sua B-Car o il mare di Ghost Ship, 2005) è lo spazio, per Burden, a costituire il vero centro di antagonismo, conflitto e contraddizione.
Quasi spontaneamente dunque la traiettoria di Burden (che di fatto proveniva da studi in architettura) è transitata dall’essere un’azione nello spazio all’impiegare lo spazio come azione – spazio insidiato da movimenti, relazioni, sguardi, che possono sempre trasformarsi in minaccia, rischio, catastrofe. I suoi lavori, anche quando sembrano semplicemente “scultorei”, non si rivolgono allo spettatore come semplice testimone, ma lo chiamano in causa come corresponsabile: in Samson (1985), a Seattle, Burden aveva installato un enorme crick da 100 tonnellate fra le parete portanti della galleria, collegato a un tornello di modo che, ogni volta che un visitatore entrava per vedere la mostra, il passaggio aumentava leggermente la spinta, fino a minacciare un potenziale crollo.

Chris Burden, Trans-fixed, 1974
ALLIEVI TROPPO ZELANTI
Ma, a onor del vero, va detto che anche gli eroi, per quanto grandi e preveggenti come Burden, hanno i loro limiti (im)personali. Nel 2004 infatti ebbe luogo un episodio sconcertante che lo portò alle dimissioni dal suo posto di docente alla UCLA: durante un seminario sulla performance, un suo studente giocò alla roulette russa con un revolver, prima puntandoselo alla tempia e poi, fuori dall’aula, facendo esplodere un colpo – col risultato di terrorizzare gli altri compagni e sollevando un notevole scandalo. Diversamente da quanto ci si sarebbe aspettato, l’autore di Shoot (risalente a oltre trent’anni prima) e 747 non solo non prese le difese del suo allievo, ma ne condannò il gesto come irresponsabile e pericoloso. Più tardi, Joe Deutsch – oggi artista agli esordi – ha rivelato che si trattava solo di una pistola giocattolo e che il colpo udito in aula era dovuto a un petardo – una spiegazione che sembra inscrivere il suo “lavoro” effettivamente nel solco delle più tipiche provocazioni à la Burden.
Come interpretare dunque questo episodio? L’opera di un talentuoso allievo che tenta di superare il maestro al suo stesso gioco, come starebbe a dimostrare la reazione di “autentica paura” dei compagni di fronte a una messa in scena tanto abile quanto finta – o invece la nefasta mania di un vero e proprio stalker “artistico”, come prova il fatto che nell’ultima performance da Human Resources (L.A., 2011) Deutsch si è trafitto una mano, proprio come Burden in Trans-Fixed nel 1974? La malaugurata conseguenza dell’insegnamento dei “cattivi maestri” o il delirio dell’instabile psiche di un “cattivo allievo”? Ma soprattutto: la presa di distanza di Burden è un legittimo sentimento di salvaguardia dell’“autonomia” dell’arte, o è un segno dell’inevitabile conservatorismo che prende anche i più grandi provocatori quando fanno carriera, un irresistibile pompierismo che, a una certa età, assale anche i più convinti incendiari della prima ora? Forse, né l’una né l’altra cosa.

Chris Burden
LA LEZIONE DI CHRIS BURDEN
Forse, la vera lezione di Chris Burden è un’altra ancora: il pericolo è insito nella convivenza ed ogni relazione (persino quella fra maestro e allievo) è potenzialmente violenta, ma l’arte ha ancora la possibilità di tradurre esteticamente questa condizione, di darle forma.
Burden ci è riuscito, e i suoi lavori ne sono la testimonianza più chiara. I suoi allievi, invece, devono ancora dimostrare di saperlo fare.
Marco Senaldi
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati