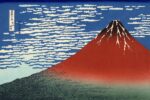The Whale. Il film di Darren Aronofsky con un Brendan Fraser da Oscar
Arriverà nelle sale italiane solo il prossimo 23 febbraio ‘23 la pellicola presentata al Festival di Venezia e già campione di incassi in America. Adattamento di una pièce teatrale, il film è favorito alla cerimonia degli Oscar dell’anno che sa iniziando

Il viaggio inizia da un tassello nero e una voce calda e suadente, che ci introduce nel mondo dell’immaginazione. Per un attimo ci separiamo dal corpo – dall’idea che possa esistere il corpo – e diventiamo puro sentire. Siamo dentro al dramma, e sarebbe stato bello restarci più a lungo, per entrare in maniera lenta e progressiva nell’intimità di Charlie (interpretato da Brendan Fraser), l’inglese protagonista del nuovo film di Darren Aronofsky, già in concorso a Venezia 79. La sceneggiatura, scritta da Samuel D. Hunter, autore della pièce originaria, vira invece bruscamente verso un’altra strada: mostrare subito quel corpo, per costruirci sopra un castello di menzogne, di ricordi, ma soprattutto per prenderne distanza attraverso la commedia. Del resto, siamo pronti per addentrarci nell’intimità di un essere umano, che agli occhi degli altri e di se stesso risulta disgustoso? Decisamente no. Sarebbe troppo respingente e doloroso. Ci obbligherebbe a confrontarci, in maniera troppo violenta anche se soft, con quel primato che ci distingue e ci rimpicciolisce: la vista.
THE WHALE: IL CORPO TRAGICO
Il corpo come oggetto, idea dalla quale non riusciamo e non possiamo separarci, è infatti il muro che continua a dividerci, che ci separa prima di tutto dalla nostra interiorità. La storia è costruita su questa incrollabile certezza. Tutte le persone che entrano nella stanza angusta in cui vive Charlie devono confrontarsi innanzitutto con la sua carne, perché quel corpo, deformato dall’obesità, deborda e sconfina dal regno dell’umano a quello del mostruoso. Possiamo amare quella carne? Possiamo accarezzarla, possiamo prendercene cura, possiamo accettare di sentirla vicina o addosso al nostro corpo? La distanza è sicuramente l’atteggiamento che contraddistingue tutti i personaggi, eccetto uno. Ma non possiamo svelare il perché. Il tragico, dietro al comico, non riguarda la backstory di Charlie, che è ciò su cui insiste la narrazione per empatizzare con lo spettatore. A dire la verità poco importa dell’abbandono della figlia, e altrettanto poco della motivazione di questo allontanamento, non accuratamente esplorata, che invece è il focus del suo fautore, apertamente gay. Il tragico dietro al comico si risolve in una semplice domanda: siamo in grado di connetterci in maniera emotivamente pura, apertamente carnale, con questo essere umano?
THE WHALE: LA DUPLICE FERITA
Il basso continuo della storia è sicuramente questo e purtroppo sono poche le scene (le stesse in cui ritroviamo piacevolmente la cifra stilistica del regista: quell’ossessione per l’eccesso, quella bulimia, quella follia sfrenata che ci avevano affascinato già ai tempi di π – Il teorema del delirio e Requiem for a Dream) in cui Aronofsky ci consente di esplorare i limiti e le potenzialità di questo corpo. L’incapacità di gestirlo, anche nelle azioni più banali della vita quotidiana – dall’esperienza di una chiave che cade in terra all’espletare i bisogni primari, tanto quanto il suo farsi oggetto, nel senso di contenitore, plagiato dalla voracità della bocca.
Un corpo la cui forma si imprime nella memoria attraverso un’immagine ausiliaria, quella di Moby Dick (The Whale appunto), il romanzo di Melville, amo lanciato nel mare della riconciliazione con l’adorata figlia. Samuel D. Hunter preferisce infatti scegliere la strada delle relazioni, della duplice ferita che affligge il protagonista. L’abbandono della figlia per amore di un uomo, la morte di lui e il conseguente bisogno di ripristinare un rapporto con lei, e così riportare alla luce un tempo in cui Charlie abitava un corpo diverso, che diventa ricordo, pace, sogno.
THE WHALE: LA RICERCA DI NOI STESSI
Quando scegliamo di diventare noi stessi, infatti, la vita va in pezzi e potremmo passare tutto il resto dei nostri giorni nel tentativo di rimetterli insieme, lasciando che il nostro corpo diventi quel campo di battaglia che non sarebbe mai stato se a un certo punto non avessimo scelto di lottare per la nostra identità. Una lotta senza copione, che lascia sul corpo i suoi segni: una ruga, una malattia, un incidente, l’obesità, perché il corpo è il primo luogo che abitiamo, quello in cui nasciamo e moriamo.
Carlotta Petracci
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati