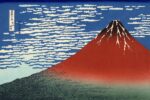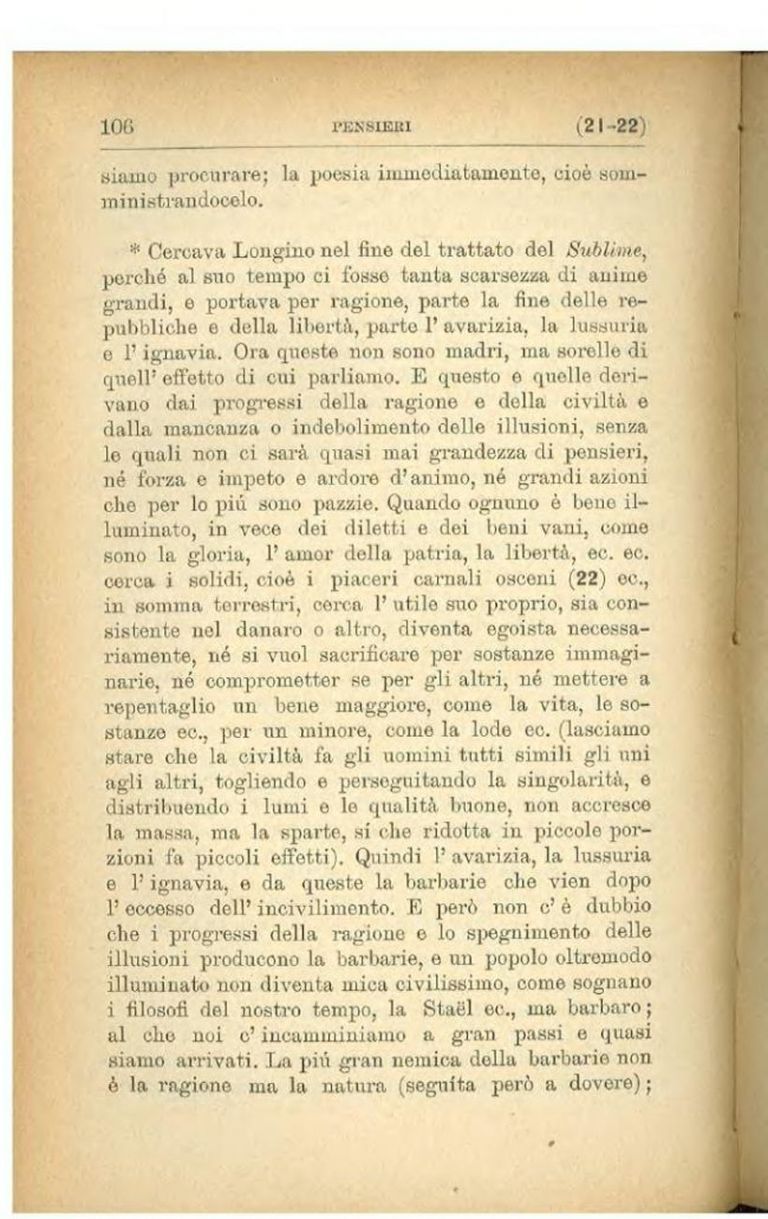L’illusione, Leopardi e le uova di Woody Allen
A quarant’anni da “Io e Annie” e dal suo straordinario finale, una riflessione sulla poetica di Woody Allen e sull’importanza dell’illusione come strumento per alleggerire la vita quotidiana. Che nei secoli ha avuto diverse letture e applicazioni, dall’Antica Grecia a Giacomo Leopardi.

“E io pensai a quella vecchia barzelletta, sapete, quella dove un tizio va da uno psichiatra e dice: “Dottore, mio fratello è pazzo: crede di essere una gallina”. E il dottore gli chiede: “Perché non lo interna?”, e quello risponde: “E poi le uova chi me le fa?”. Credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti uomo-donna: e cioè che sono assolutamente irrazionali, e pazzi, e assurdi… ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova”. Con queste parole si chiude Io e Annie, uno dei film più divertenti e poetici di Woody Allen (New York, 1935) girato quarant’anni fa. Con uno dei finali più arguti e profondi della storia del cinema, il regista newyorkese tocca il nervo scoperto di quella bizzarria umana che già la letteratura russa di fine Ottocento aveva ampiamente indagato e raccontato. Perché Woody Allen non è soltanto un regista; è anche un filosofo e un antropologo, profondo conoscitore dell’Europa Orientale da cui, almeno spiritualmente, proviene. E con il poetico finale di Io e Annie apre il discorso sulla necessità dell’illusione nell’esistenza dell’individuo.
UNA QUESTIONE DI ESTETICA E DI ETICA
Già gli architetti dell’Antica Grecia avevano scoperto l’importanza degli effetti ottici artificiali, attraverso la rastremazione delle colonne degli edifici, in particolare dei templi, cosa che creava la cosiddetta entasi, ovvero quei “rigonfiamenti” delle sezioni che facevano percepire all’occhio umano il medesimo spessore della colonna al variare delle altezze (senza rastremazione, le sezioni più alte sarebbero sembrate più larghe, con conseguente perdita di armonia estetica). L’illusione può quindi essere considerata una correzione dello stato della realtà, per riportarvi quell’armonia che per l’essere umano è una condizione irrinunciabile del sentire etico. Secoli più tardi, il Rinascimento riscoprì la bellezza platonica, intesa prima di tutto come armonia del corpo sociale, composto da individui dotati di libero arbitrio e di senso critico. Nel rilievo in bronzo dorato Il miracolo del figlio pentito (1449 ca.), per l’altare della Basilica del Santo a Padova, Donatello costruisce una prospettiva incentrata su molteplici punti di fuga, creando una serie di piani sfalsati che superano la classica prospettiva lineare centrica. Un inganno visivo che è la metafora della capacità dell’uomo di costruire la propria linea visiva, di intendere le cose secondo il proprio senso critico, e dirigere il corso della propria esistenza proiettando nell’etica i canoni dell’armonia architettonica, che diviene specchio della platonica polis.
Tramontata l’epopea rinascimentale, l’individuo si scopre piccolo nell’infinito universo, e l’illusione è quindi necessaria per accettare i limiti del proprio essere e sognare di superarli. In quanto creazione di un’ulteriore prospettiva, illudersi è un gesto di naïveté artistica, che da pittori, scultori, scrittori, drammaturghi, poeti si trasferisce all’uomo comune.

Donatello, Il miracolo del figlio pentito, 1449 ca.
L’ILLUSIONE CONTRO LA MALINCONIA
“Finalmente questo mondo è un nulla, e tutto il bene consiste nelle care illusioni”. Così Giacomo Leopardi in una lettera all’editore Brighenti, del 14 agosto 1820. E ancora scriveva nello Zibaldone di pensieri: “Senza le illusioni non ci sarà quasi mai grandezza di pensieri, né forza e impeto e ardore d’animo, né grandi azioni che per lo più sono pazzie”. L’illusione è necessaria nella Londra cenciosa di Charles Dickens, nella Parigi di Émile Zola, e ancora nella Milano di Giovanni Testori o nell’impersonale città abitata da Marcovaldo, luoghi troppo vasti per essere riempiti, dove l’esistenza si trascina grigia e sempre uguale, avara di soddisfazioni ma parca di solitudine. Un secolo e mezzo dopo Leopardi, Woody Allen si riallaccia al pessimismo del recanatese e, addolcendolo con l’abituale umorismo yiddish, ci ricorda che, in definitiva, l’umanità è assai più semplice di quanto pensassero gli antichi, e poiché l’individuo è un animale sociale, accade che il bisogno di qualcuno si faccia viscerale e spinga a quell’irrazionalità di giudizio che attribuisce agli altri capacità e pregi in soprannumero, nella speranza di vivere insieme qualcosa di straordinario. E a ben guardare, l’umanità è forse più poetica di quanto non sembri dimostrare la prosa quotidiana.
‒ Niccolò Lucarelli
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati