Corpi addestrati, territori forzati. Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 come dispositivo culturale
Attraverso lo sguardo dell’arte contemporanea – da Pirici a Paglen, da Almarcegui a Eliasson – le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 emergono come un’opera totale non dichiarata, dove disciplina, governance, sostenibilità e spettacolo si intrecciano. Un’analisi che sposta il focus dal podio al sistema, dall’evento all’impatto

Non sono solo sport. Milano Cortina 2026 è una macchina visiva. È coreografia, spettacolo, infrastruttura. Un dispositivo che allena corpi, rifà territori, impacchetta la montagna come immagine e la rivende al mondo sotto forma di performance, velocità, sostenibilità, promessa. Lo sport è il pretesto. Il resto è coreografia del potere, dispositivo estetico e politico di scala globale. L’arte contemporanea, da anni, lavora esattamente qui: sul corpo disciplinato, sull’infrastruttura che diventa paesaggio, sul limite come spettacolo. Mettere insieme questi piani non è un esercizio teorico. È leggere le Olimpiadi come un’opera totale, non dichiarata.
Il corpo olimpico: allenato, misurato, ottimizzato
Gli atleti non sono solo pura forza. Sono modelli di efficienza, governance, sorveglianza. Allenamento, disciplina, controllo, performance: una pedagogia del gesto che promette eccellenza e produce obbedienza. Alexandra Pirici (Bucarest, 1982) espone corpi che non performano per vincere. Nelle sue azioni performative, costruite su ripetizioni minime e gesti sottratti, smonta la logica dell’esibizione e il corpo diventa infrastruttura temporanea, non spettacolo, ma dispositivo che accumula memoria e vulnerabilità. È l’antidoto alla retorica olimpica della prestazione fine a se stessa: il corpo come archivio, non come risultato.
Jesse Darling (Oxford, 1981) lavora invece sulla fragilità dell’apparato: tutori, stampelle, strutture di sostegno che ricordano quanto ogni corpo performante, in realtà, sia un corpo a rischio. Le sue sculture, tra metallo piegato e posture instabili, smontano l’eroismo sportivo mostrando ciò che resta quando la performance finisce.
Con Jill Magid (Bridgeport, 1973), il corpo entra nel campo del controllo. I suoi progetti sugli apparati istituzionali – dal sistema di sorveglianza urbana ai flussi di dati biometrici – mostrano come i corpi (anche quelli costruiti per eccellere) siano sempre già tracciati, negoziati, sorvegliati. Mentre Simon Denny (Auckland, 1982) mette in scena la governance della competizione: grafica, brand, regole, sistemi di punteggio. Il linguaggio visivo dell’innovazione e della performance diventa ideologia.
 1 / 4
1 / 4
 2 / 4
2 / 4
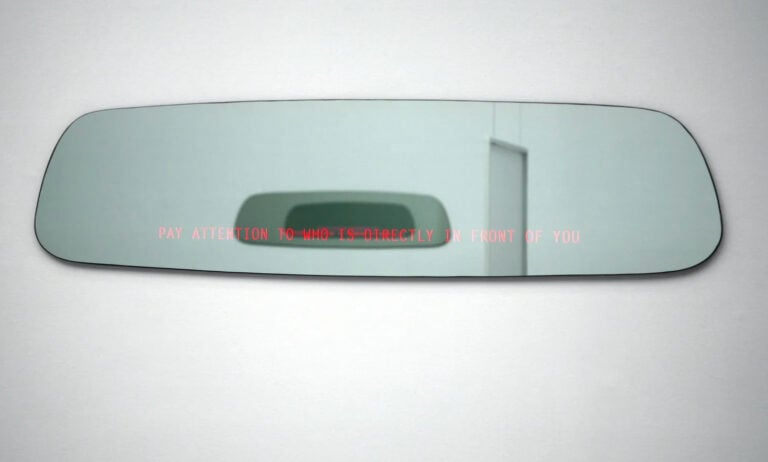 3 / 4
3 / 4
 4 / 4
4 / 4
La montagna, non paesaggio ma infrastruttura
Cortina e le Alpi non sono uno sfondo paesaggistico. Sono un cantiere, terra da scavare, da stabilizzare, da regolare, come nei lavori di Lara Almarcegui (Saragozza, 1972), che da anni si confronta con la materialità del territorio e toglie ogni alone romantico alla terra. I materiali – ghiaia, ferro, pietra – perdono aura e diventano ciò che sono: risorse da modellare per infrastrutture. Nei suoi progetti più recenti la montagna appare come deposito di risorse prima che come paesaggio, anticipando la stessa logica che trasforma le Alpi in supporto tecnico per piste, strade, villaggi temporanei. Anche il collettivo Alterazioni Video si occupa di grandi infrastrutture e ha insegnato a leggerle come monumenti falliti. Infrastrutture incompiute, promesse non mantenute, spettacolo che lascia macerie. La loro riflessione sulle opere incompiute risuona sinistramente con l’eredità che molti eventi sportivi lasciano dietro di sé. Con Ursula Biemann (Zurigo, 1955) il territorio diventa rete di flussi energetici, climatici, politici. Le sue videoinstallazioni dedicate a ecologie estreme e zone di frizione rendono evidente ciò che l’estetica olimpica rimuove: la complessità sistemica che ogni grande opera attiva. Il paesaggio non è bello da guardare, ma è un sistema da comprendere. Mentre Paolo Cirio (Torino, 1979), nei suoi lavori su dati, responsabilità istituzionali e potere pubblico, fornisce la cassetta degli attrezzi critica: chi decide, chi paga, chi beneficia davvero di queste trasformazioni territoriali? La sua arte è policy critica, mappa dei poteri dietro la grande scena.
 1 / 4
1 / 4
 2 / 4
2 / 4
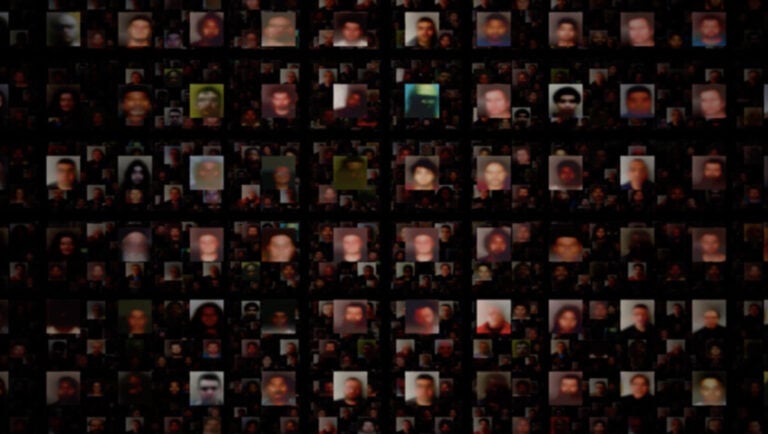 3 / 4
3 / 4
 4 / 4
4 / 4
Velocità, rischio, spettacolo. Tra le Olimpiadi e l’arte contemporanea
Gli sport invernali sono il teatro perfetto del limite controllato: cadere senza morire, rischiare senza uscire dall’inquadratura. Hito Steyerl (Monaco di Baviera, 1966) ha fatto della caduta e della velocità una grammatica politica. Nei suoi lavori più recenti l’immagine accelera, si rompe, perde stabilità. È lo stesso regime visivo della discesa libera: vertigine, controllo tecnico, perdita momentanea di senso. Ed Atkins (Oxford, 1982) porta il discorso sul piano emotivo ed esplora un’umanità drenata. I suoi corpi digitali affaticati, iperpresenti eppure vuoti, esausti, parlano di un esaurimento che lo sport spettacolarizzato condivide con il lavoro contemporaneo: tutto deve funzionare, sempre. Mentre Trevor Paglen (Camp Springs, 1974) preferisce lo sguardo tecnico e incrocia arte e sorveglianza. Con le sue ricerche su satelliti, visione dall’alto e confini invisibili, ci ricorda che la montagna non è solo pendenza, è territorio misurato, tracciato, mappato. La performance non è mai solo fisica, è anche visiva, informativa, strategica.
 1 / 3
1 / 3
 2 / 3
2 / 3
 3 / 3
3 / 3
Sostenibilità: parola o pratica?
Milano Cortina 2026 si presenta come Olimpiade verde. Neutralità climatica, riuso delle infrastrutture, attenzione al paesaggio. Eppure, la sostenibilità, prima ancora che un insieme di pratiche, è oggi un linguaggio. Il duo artistico Cooking Sections lavora da anni proprio sullo scarto tra racconto ecologico e realtà materiale. Nei loro progetti dedicati ai sistemi alimentari e alle politiche ambientali mostrano come la sostenibilità venga spesso incorporata come brand, senza intaccare le logiche estrattive sottostanti. Applicata alle Olimpiadi, questa lettura mette in crisi l’idea stessa di evento sostenibile in un contesto di trasformazioni infrastrutturali massive.
Tue Greenfort (Holbæk, 1973) spinge il paradosso ancora oltre. Le sue opere, apparentemente ecologiche, rivelano l’impossibilità di una neutralità ambientale all’interno del sistema culturale globale. Anche quando l’intenzione è virtuosa, l’impatto resta. Milano Cortina 2026, letta attraverso Greenfort, diventa il caso studio perfetto di una sostenibilità che funziona più come alibi che come soluzione. In questo contesto, anche figure come Olafur Eliasson (Copenaghen, 1967) assumono un valore emblematico. Spesso chiamato a legittimare grandi operazioni green attraverso l’estetica dell’esperienza ambientale, il suo lavoro solleva una domanda cruciale: quando l’arte contribuisce a sensibilizzare, e quando invece finisce per addolcire il conflitto? La retorica dell’esperienza immersiva rischia di anestetizzare.
Epilogo. L’Olimpiade come installazione totale
Milano Cortina 2026 appare così come una gigantesca installazione collettiva. Un’opera diffusa, fatta di corpi addestrati, montagne riconfigurate, immagini accelerate, promesse ecologiche. Temporanea nel calendario, permanente negli effetti. L’arte contemporanea non offre risposte consolatorie, ma fornisce strumenti critici per leggere ciò che spesso resta invisibile: le infrastrutture dietro lo spettacolo, i costi dietro la celebrazione, i corpi dietro le medaglie.
Guardare le Olimpiadi con questi strumenti significa quindi spostare lo sguardo dal podio al sistema, dall’evento al processo, dalla vittoria all’impatto. È in questo slittamento che Milano Cortina 2026 smette di essere solo un appuntamento sportivo e diventa, a tutti gli effetti, una questione culturale.
Chiara Argenteri
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati














