Conversazioni di architettura. Il progetto come costruzione della mente e l’HyperArchitettura
Si chiude il ciclo delle lezioni di Luigi Prestinenza Puglisi con il decimo appuntamento, che racconta l’architettura come costruzione della mente, mentre a Venezia si inaugura la Biennale dedicata

Nelle dieci precedenti conversazioni, concordando con Hans Hollein, abbiamo sostenuto che tutto è architettura. In questa nota finale vorrei provare a parlare di architettura guardandola come costruzione della mente.
Architettura e struttura
La parola architettura, infatti, non necessariamente ha a che vedere con gli edifici. Spesso è adoperata in senso metaforico per indicare insiemi, anche di concetti astratti, organizzati e strutturati. Parliamo di architettura di una società, di una concezione filosofica, di un organismo. La parola architettura indica che le componenti dell’insieme sono relazionate tra loro, secondo un disegno chiaro, preferibilmente sintattico e gerarchico. Ma, non sempre e necessariamente: esattamente come capita per l’architettura moderna, le relazioni possono non essere sintattiche ma paratattiche. Per esempio, l’architettura della pagina di un quotidiano in cui gli articoli sono affiancati tra loro con una certa libertà.
Anche se deboli, come è il caso di queste ultime, è fondamentale che relazioni ci siano e siano organizzate secondo un certo disegno che possa essere individuato.
Il fatto che possiamo tradurre sistemi diversi con una architettura, cioè un disegno comune, è della massima importanza. Perché è proprio ciò che ci permette di comparare strutture tra loro anche apparentemente molto diverse: l’architettura della mente, per esempio, con quella di un testo scritto, l’architettura di una organizzazione aziendale con quella di una società.
Che cos’è l’architettura
È questa traducibilità che ci permette di usare per tutti questi insiemi la parola architettura, che altrimenti dovrebbe essere relegata al semplice campo dell’edilizia. La traducibilità, lo ripetiamo, deriva dal fatto che ogni struttura è facilmente (abbastanza facilmente) riassumibile in un insieme di relazioni che a sua volta può essere tradotto in uno schema geometrico. Per esempio, possiamo pensare alla mente come a una struttura gerarchica oppure rizomatica. Optare per l’uno o l’altro modello comporta un diverso modo di vedere la realtà. La scelta di un modello rispetto a un altro può essere determinato, però, oltre che da complesse questioni gnoseologiche, anche da più prosaiche esigenze pratiche, dal fatto banale che un modello può essere più utile di un altro in vista di un fine. O anche da preferenze estetiche, da un nostro giudizio o pregiudizio di bellezza. Valutando la struttura come se fosse un edificio, infatti, ne apprezziamo o meno la simmetria, oppure il dinamismo, oppure le proporzioni tra le parti (a volte una formula scientifica viene preferita a un’altra solo perché è più elegante). Torneremo su questo punto che, per noi che ci occupiamo di estetica, è della massima importanza.
Architettura e relazioni
Per adesso notiamo che se una struttura qualsiasi -per esempio quella di una organizzazione aziendale o di un nostro ragionamento- può essere tradotta in una struttura di tipo geometrico architettonico, deriva dal fatto che tutte le strutture condividono la stessa sostanza, cioè l’essere costituite da relazioni.
E, dal punto di vista delle relazioni, non vi è alcuna differenza sostanziale tra il modo in cui io sto scrivendo questo articolo e il modo in cui potrei organizzare il carrello della spesa, o il modo in cui, sempre per esempio, potrei concepire una associazione culturale. Tanto che esistono alcune semplici applicazioni, quali per esempio File Maker, che possono essere utilizzate indifferentemente per gestire i volumi della propria libreria, una attività commerciale con numerose filiali, una società immobiliare con proprietà da vendere o affittare in base al fatto che il sistema relazionale che lega le componenti è comune.
Proiezioni in architettura
Se volessimo essere un po’ più rigorosi dal punto di vista scientifico, per effettuare il passaggio da una architettura a un’altra equivalente dovremmo attivare una proiezione che conservi inalterate le relazioni e sia percorribile nei due sensi, come accade con la geometria descrittiva quando usiamo le proiezioni ortogonali. L’ideale è, infatti, avere quella che in gergo matematico si chiama una corrispondenza biunivoca: data una struttura avere una e una sola sua immagine proiettata e, viceversa, data questa immagine proiettata poter risalire a una sola struttura, quella che era all’origine del processo.
Come vedremo, non sempre questo accade. E per fortuna. Nella vita, non applichiamo quasi mai le rigide leggi della geometria descrittiva perché spesso preferiamo usare le proiezioni in modo meno scientifico. Anche se è chiaro che, in linea generale, più la proiezione diventa vaga e ambigua e meno sarà utile.
Osserviamo anche che, quando trasferiamo un sistema di relazioni in un altro, non sempre c’è bisogno di passare per la geometria. Per esempio, le relazioni tra le argomentazioni del testo che sto scrivendo potrebbero diventare uno schema colorato che metta in evidenza l’efficacia retorica del discorso. Schema che potrebbe essere visualizzato dal blu dei momenti meno intensi al rosso dei momenti retoricamente più efficaci. Grazie a questo artificio, che mi fa vedere attraverso colori ciò che altrimenti sarebbe stato invisibile, potrei decidere di calibrare meglio l’ordine delle argomentazioni, in modo da rendere il mio testo più efficace.
Da Steven Holl a Peter Eisenman
Non tutte le proiezioni possibili, infine, sono utili. Potrei per esempio mettere in relazione la retorica di una poesia con le temperature degli ambienti di un edificio. Credo però che questa operazione non avrebbe senso. O forse potrebbe averla per un architetto fuori di testa che vuole che gli utenti sentano attraverso la sensazione di freddo e caldo di abitare spazi leopardiani o carducciani. Ma direi che si tratterebbe di masturbazioni intellettuali. Che tuttavia registriamo nella storia della disciplina architettonica, per esempio quando si è proiettato un sistema in un altro per realizzare ibridi concettuali come architetture musicali, architetture mentali, o architetture rigorosamente arbitrarie. Esempio di architetture musicali sono quelle di Steven Holl ottenute proiettando una struttura musicale in una architettonica. Esempio di architettura mentale è la casa di Wittgenstein per la sorella. Esempio di architetture arbitrarie sono i giochi compositivi di Peter Eisenman quando per esempio utilizza la logica delle strutture del DNA per dare forma ad alcuni complessi edilizi da lui progettati. Operazione quest’ultima che, a pensarci bene, non è molto diversa da quella delle temperature leopardiane e carducciane che stigmatizzavamo come masturbazione intellettuale.
In genere, è importante e utile proiettare un sistema in un altro quando la proiezione può servirci a meglio capirlo. E non necessariamente con operazioni complesse. Spesso anzi con attività che sono diventate tanto naturali da farle senza troppo pensarci. Per esempio, proiettiamo il passare del tempo, cioè la dimensione temporale, sulle lancette che incessantemente girano nell’orologio, cioè sulla dimensione spaziale. Il tempo sarebbe infatti molto difficile da percepire se non fosse proiettato in un movimento che avviene nello spazio. Oppure seguiamo il download dell’aggiornamento del software del nostro computer grazie a un indicatore che cresce progressivamente sino a raggiungere una posizione, la quale indica che l’operazione è completata al 100%. Visione questa che ci tranquillizza dicendoci che tutto sta andando per il suo verso. Le infografiche sono utilissime, infine, per visualizzare relazioni che altrimenti correrebbero il rischio di sfuggirci.

Memoria e architettura
È interessante a questo punto rilevare che civiltà del passato, quali la sumera, l’egiziana, la babilonese, la maya, la greca e la romana avevano intuito che il cosmo ha una sua architettura e che è possibile copiarne le relazioni. Anche se, probabilmente, per fare questo occorreva essere custodi dei segreti della scienza sacra, cioè essere figure sacerdotali. L’architettura del microcosmo, diventando l’immagine del macrocosmo, ci aiuta a meglio comprenderlo e quindi a gestirlo nei momenti drammatici, in particolare per affrontare la morte, che è il momento critico per eccellenza. La piramide, per esempio, rappresenta le quattro direzioni del cosmo e, attraverso l’asse ideale che lega la tomba del faraone con il vertice, l’albero della vita e l’asse del mondo. È, insomma, una specie di astronave cosmica, un ascensore verso l’al di là.
Si potrebbero addurre una infinità di altri esempi: non c’è edificio importante dell’antichità che non sia carico di riferimenti simbolici e che non si possa considerare un modello che rappresenta le relazioni perfette del macrocosmo e quindi un viatico contro l’angoscia della precarietà dell’esistenza (per coloro che volessero approfondire esiste una infinita quantità di studi e di pubblicazioni scientifiche o meno che trattano queste simbologie a partire dai magnifici testi di René Guénon). Tutto, infatti, nelle architetture antiche ha un significato simbolico: l’orientamento del percorso, l’uso dell’edificio, il numero dei piani, i materiali scelti, i rapporti proporzionali tra le parti, il modo in cui sono distribuite le funzioni. Non c’è epoca in cui le simbologie vengano meno. Ma è nel rinascimento che la corrispondenza tra la struttura del microcosmo terreno e dell’universo è ripresa, rilanciata, teorizzata attraverso la filosofia e l’arte, partendo dalla consapevolezza che lo stesso corpo umano è un sistema di relazioni che riflette principi universali. E, difatti, l’uomo di Leonardo è proporzionato attraverso cerchi e quadrati, cioè secondo le stesse regole di perfezione che si trovano nell’architettura e quindi nell’universo. Viceversa, un edificio o una città ideale (e non mancano disegni dell’epoca che lo esplicitano) possono essere disegnati come un corpo umano. Siamo pronti per il passaggio successivo: che è la mente stessa, e non solo il corpo, a essere organizzata come una architettura. E difatti, sempre con maggior frequenza, si elaboreranno i sistemi filosofici – si pensi per tutti a Hegel-immaginandoli come architetture del pensiero ben fondate e strutturate, adoperando così due metafore – la fondazione e la struttura- riprese dal mondo della costruzione.
Spazializzare i concetti
Se l’architettura spazializza i concetti, trasformandoli in edifici, lo fa non solo per motivi simbolici e religiosi ma anche conoscitivi e pratici. La spazializzazione come abbiamo visto rende, infatti, più visibili e quindi gestibili i concetti stessi. Permette di vederli concretamente. Trasformandoli in oggetti tridimensionali.
È interessante a proposito ricordare le tecniche che nell’antichità si utilizzavano per potenziare la memoria. Diversamente da oggi, in cui possiamo travasare le informazioni che intendiamo conservare in numerosi supporti, a partire dalla memoria del telefonino (e, difatti, se lo perdiamo siamo disperati), nel passato, quando la carta non esisteva o era preziosa, occorreva fare affidamento su se stessi, cioè sulla propria memoria che andava quindi aiutata.
La tecnica era di organizzare le cose che si volevano ricordare all’interno di una simulazione spaziale, cioè in un edificio virtuale composto da un numero adeguato di stanze. All’interno di ciascuna delle quali venivano riposte delle informazioni simboleggiate da situazioni o da oggetti. Ripercorrendo le stanze e riguardando gli oggetti lasciati in esse, era abbastanza facile ricostruire le informazioni che la memoria doveva conservare.
Va da sé che più la memoria doveva ritenere informazioni, più la struttura spaziale doveva essere articolata sino a formare una costruzione virtuale di un certa complessità e forse anche di un certo interesse estetico. E questa potrebbe essere una altra ragione per la quale, per esprimere concetti astratti tra loro collegati, utilizziamo il termine di architettura.
Scambiare
La vita è scambio. Come nota Jean Baudrillard, senza scambio non potremmo fare né conoscere alcunché. Saremmo monadi isolate e autistiche, Per capire una cosa abbiamo bisogno di un’altra, per comprendere una parola dobbiamo definirla con altre parole, per afferrare un concetto lo dobbiamo tradurre in un altro equivalente. La nostra opera di traduzione del mondo è incessante e continua.
Alcuni scambi sono arbitrari, frutto di una convenzione delle cui origini abbiamo perso le tracce. Non c’è niente, per esempio, che leghi la parola italiana gatto a quella inglese cat. Altri, invece, avvengono per somiglianza. Individuiamo, per esempio, che un animale è un gatto perché condivide con gli altri gatti determinate caratteristiche. Che gli scienziati hanno codificato. Ma che noi riscontriamo in maniera semplice, intuitiva e immediata. Se dobbiamo infatti individuare un gatto non prendiamo certo il trattato sui felini e analizziamo una per una le caratteristiche che contraddistinguono l’animale ma lo facciamo sinteticamente attraverso la nostra innata abilità di vedere il mondo tramite caratteri comuni. Abilità che ci permette sempre (quasi sempre) di trovare relazioni tra le cose. Non solo vediamo subito che quel tal animale è un gatto. Ma a volte vediamo che anche un asciugamano piegato in un certo modo o una macchia nel muro rassomiglia a un gatto. Cioè troviamo in un oggetto relazioni tra le forme simili a quelle che vediamo nell’animale. Grazie a queste relazioni individuiamo una struttura. Azzardando, potremmo dire che la figura dell’asciugamano potrebbe essere una proiezione sufficiente a farci pensare a un gatto. E che quindi il nostro cervello riconosce il mondo esterno non solo attraverso proiezioni numerose e ineccepibili, ma anche poche e vaghe. Permettetemi di chiamare queste proiezioni con il nome di metafore. Anzi, meglio, di chiamare metafore tutte le proiezioni, includendo anche quelle scientificamente ineccepibili.
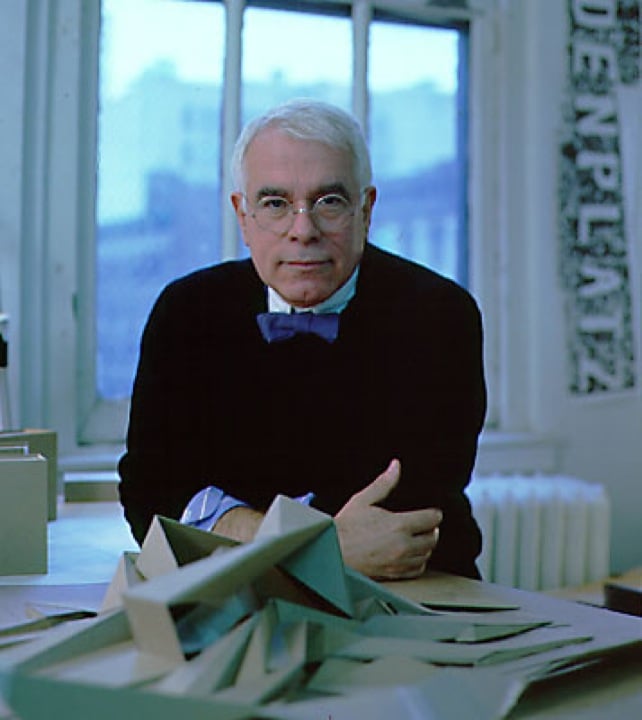
Metafore
Per capire cosa sia la metafora dobbiamo prima sgombrare il campo da alcuni equivoci. Che la fanno considerare una figura retorica melensa e poco utile. Ecco, per esempio, la definizione che il dizionario ci fornisce: Sostituzione di un termine proprio con uno figurato, in seguito a una trasposizione simbolica di immagini: le spighe ondeggiano (come se fossero un mare); il mare mugola (come se fosse un essere vivente); il re della foresta (come se il leone fosse un uomo). Se la metafora fosse solo questo, ci servirebbe a poco. In realtà è molto di più di una semplice e vaga trasposizione di immagini. Le metafore individuano strutture, cioè sistemi di relazioni (architetture) comuni. Per esempio, un albero genealogico mostra che tra i rami di un albero e la discendenza di una famiglia ci sono forme in comune. Oppure, se voglio pensare al tempo, ho bisogno di immaginarmi il movimento dei granelli di una clessidra o, come dicevamo, l’uniforme girare delle lancette di un orologio. Altro che immagini del leone, delle spighe o del mare che sono vaghe e di scarso interesse. Il mondo è popolato da metafore più utili e interessanti, attraverso le quali avviene lo scambio e cioè la continua traduzione del reale con se stesso, di cui parlava Baudrillard. Sintetizziamo: lo strumento per individuare le forme del mondo traducendole tra loro è la metafora. È tramite l’immediatezza della metafora che gli uomini individuano relazioni, proiettandole da un oggetto a un altro. Come dicevamo, vi sono metafore molto banali: hai un viso di pesca indica una relazione vaga che ci dà poche informazioni sul viso dell’amata. L’ albero genealogico di cui parlavamo è già una metafora più utile che ci può aiutare a capire come si è articolata una storia familiare nel tempo. La finestra di un computer è una metafora operativa che serve a farci organizzare razionalmente il lavoro, osservandolo come se fosse un paesaggio nel cui interno gli oggetti si relazionano. La cartella nelle quali conserviamo i file sono metafore utili per spingerci a fare ordine, attraverso la logica della cassettiera (ordinare le cose per cassetti cioè attraverso una logica paratattica). Metafora è la mela che cade sulla testa di Newton, perché se no la avrebbe mangiata e invece ci ha scritto una teoria. Metafora è l’immagine del serpente Uroboro che si morde la coda e che rappresenta per Nietzsche la struttura ciclica del tempo e del mondo, e il fatto che ogni fine costituisce sempre un nuovo inizio. Le leggi matematiche sono metafore che trasformano in rapporti tra numeri le relazioni che esistono tra le cose.
Metaforica è una TAC che trasforma le parti del corpo in colori che a loro volta ci danno indicazione delle eventuali patologie in atto. E metaforiche sono le radiografie delle facciate che ricorrendo ad accorgimenti sostanzialmente simili a quelli di una TAC, ci mostrano i ponti termici. Insomma, e per farla breve: tutto è metafora. Che poi è un modo poetico e quindi metaforico per dire che tutto si può relazionare, e quindi scambiare, con tutto.
Poesia
Secondo Benedetto Croce, che aveva ripreso il concetto da Giambattista Vico, sono proprio le immagini che hanno permesso agli uomini di conoscere il mondo e che ci consentono di farlo ancora oggi, attraverso il linguaggio.Gli uomini, infatti, adoperano il linguaggio poeticamente cioè metaforicamente. Quello che tutti noi parliamo è, infatti, fondato su questa capacità primigenia di esprimerci, di farci essere creatori di immagini. Un passato al quale ritorniamo quando ci muoviamo in campo artistico. Per Croce è questo ritorno l’aspetto primario. mentre è secondario il mezzo e cioè se, per esprimerci, ricorriamo a una pittura, a una architettura o a un poema.
Importante è che l’intuizione poetica sia ben formulata e generi una immagine compiuta ed efficace. Una intuizione non chiara, infatti, non è una intuizione ma un guazzabuglio, e un pensiero non è tale sino a che non è ben articolato. Il bello è il pienamente formulato e il brutto è il non raggiungere questa compiutezza. Pertanto, un contenuto senza forma non esiste perché è la forma stessa che è il contenuto. Tutte le discipline, comprese quelle considerate non artistiche, condividono di essere il prodotto della intuizione e della fantasia, cioè della capacità esclusivamente umana di raccontare il reale attraverso l’immaginazione. Anche se Benedetto Croce evita di farlo, la logica conclusione del suo discorso è che tutto è metafora. Solo attraverso le metafore, vaghe o scientifiche che siano, possiamo infatti rifornire di immagini il nostro linguaggio.
Platone
La metafora è finalizzata, dicevamo, a una traduzione. Ma ogni traduzione avviene grazie a una proiezione. Che le proiezioni stiano a fondamento della nostra conoscenza lo racconta Platone. È il mito della caverna. Gli schiavi rinchiusi nella grotta, leggono il reale attraverso le ombre che il mondo esterno proietta all’interno. L’uomo non può vedere la verità senza filtri e può solo farlo attraverso le ombre, cioè le immagini, che mediano il suo rapporto con il mondo. Queste, per quanto siano per alcuni versi figure non definite, “non chiare”, sono tuttavia proiezioni in senso matematico: dati un corpo e una sorgente di luce, esiste una sola ombra. Quindi possiamo immaginare che gli schiavi dentro la caverna abbiano un resoconto abbastanza preciso, se non altro dal punto di vista geometrico,della realtà che si svolge all’esterno. È interessante notare che, per raccontare che il mondo è fatto di metafore, Platone ricorra a una immagine e cioè a una ulteriore metafora. Insomma, il messaggio è chiaro: possiamo conoscere solo attraverso queste. D’altra parte, se osservate come è costruito anche questo scritto che state leggendo, vi accorgerete che per parlare dell’importanza della metafora siamo partiti da una metafora: quella dell’architettura del pensiero. Dalle immagini non si esce. Esattamente come non si esce dal linguaggio dove per spiegare una parola dobbiamo ricorrere ad altre parole attivando un perenne girare in tondo o, se preferite quest’altra metafora, una spirale senza fine. Anche il termine proiezione, del resto, è una metafora, Ovviamente una metafora più stringente, meno vaga di quella che ci fa dire che la nostra amata ha un viso di pesca.
La costruzione del doppio
Il digitale, attraverso un incessante gioco di proiezioni, traduce la realtà in relazioni pure, in informazione. Cioè in byte, ovvero in sequenze di sì e no che, proprio perché si comportano come gli elettroni nei circuiti elettrici (i circuiti elettrici sono circuiti logici fondati sulla logica binaria vero-falso, aperto-chiuso, acceso-spento che operano come macchine tautologiche) possono viaggiare alla velocità della luce e, quindi, come si suol dire, avvenire in tempo reale. Possiamo vedere i computer come macchine tautologiche e proiettive sempre più potenti in grado di svolgere questo lavoro di smaterializzazione della realtà, simulandola attraverso modelli sempre più sofisticati. Il lavoro di traduzione è reso più facile dal fatto che gli strumenti che adoperiamo per smaterializzare e ricostruire la realtà in bit di informazione sono anch’essi metaforici. A cominciare dall’ interfaccia dei computer che ricorre alla metafora delle finestre e delle cartelle. Metafora che- vi ricordate il DOS? – ha permesso di abbandonare sistemi operativi altrimenti astrusi e utilizzabili solo da specialisti. Con l’elettronica assistiamo al gioco della matrioska: una metafora facile da manipolare traduce una più difficile, che a sua volta traduce una più astratta che a sua volta traduce relazioni pure, cioè si o no che possono essere processati come byte di informazione, i quali corrono con la velocità della luce nella corrente elettrica. Da qui il progressivo ridimensionamento dell’hardware a favore del software, e cioè della costruzione di un sistema sempre più volatile e astratto di relazioni. E difatti le macchine di un tempo erano piene di ingranaggi, i computer di oggi sono pieni di applicazioni.
Notiamo, per inciso, che la digitalizzazione ha avuto una notevole ricaduta nel nostro modo di vivere lo spazio. Infatti, lo ha smaterializzato trasformandolo in un mondo di pure essenze platoniche. Potremmo con una battuta, dire che ci ha fatto scoprire che è più facile operare con le ombre della caverna che con i corpi reali, o quantomeno che ci ha insegnato a utilizzare le prime per manipolare i secondi. Le chiavi di casa sono diventate numeri e password. Il denaro pure. Gli individui codici identificativi: identità digitali, spid. Gli uffici si sono trasferiti negli schermi dei laptop. Le nostre attività si sono domiciliate nel telefono e perderlo è come smarrire metà del nostro cervello. I luoghi in cui viviamo la maggior parte del tempo non sono più gli spazi reali ma quelli virtuali della mente. Il risultato è che frequentiamo un universo sempre più evanescente fatto da alias, di doppi più facili da gestire. Cioè metafore che non pesano, che non occupano spazio fisico, che non hanno corpo, che si possono manipolare e inviare in tempo reale in ogni capo del mondo. Frequentare i mondi paralleli della virtualità ha infiniti vantaggi. Aiutandosi con un buon modello sono possibili interventi complessi, per esempio operazioni chirurgiche che prima sarebbero state molto più difficili e pericolose. E, ai tecnici che progettano, permette di sperimentare a basso costo soluzioni alternative, con modelli che gli utenti possono verificare attraverso simulazioni sempre più verosimili. Si possono produrre infinite copie e ricostruire ciò che si è perduto. Ma, soprattutto, si possono realizzare figure artificiali che hanno le caratteristiche umane perché ne riproducono l’architettura: gli automi.
Automi
Per creare un automa servono due ingredienti: l’intelligenza e un corpo. Abbiamo entrambi, anzi di più perché sia l’intelligenza che il corpo artificiale che possiamo produrre, emulano e superano quelli umani. L’intelligenza artificiale, in particolare, progredisce a passi di gigante. Si chiama AI. Come funzioni esattamente, credo che non lo sappia nessuno. La si è ottenuta e basta. Procede per metafore attraverso accostamenti relazionali, esattamente come quelli che facciamo noi. Ma, con una facilità e velocità che a noi è vietata. Molti accostamenti sono inutili, erronei, inefficaci. Questo poco importa. D’altronde, nel mondo biologico, tra milioni di spermatozoi solo uno raggiunge l’ovulo. L’importante nel nostro caso è che si ottenga una alta natalità delle idee e che si generi e sviluppi un certo numero di metafore che funzionano. E in questo, come dicevamo, la AI è imbattibile.
Il secondo ingrediente è il corpo. Ormai di automi ce ne sono molti e perfettamente funzionanti tanto che prima o poi li confonderemo con gli umani, come accadeva negli androidi nei film di fantascienza. Tra qualche anno saranno milioni se non miliardi, come noi. Ogni famiglia, accade già con gli elettrodomestici, ne avrà almeno un paio. Forse, come gli elettrodomestici avranno specializzazioni diverse. Che vanno dall’automa che imita le forme umane con le sue fattezze e movimenti e che terrà compagnia alle persone sole, all’automa volante che sostituirà i droni e avrà la possibilità di trasportare passeggeri o di andare in guerra. O, forse, come i computer saranno versatili: lo stesso automa potrà fare cose diverse cambiando l’app e qualche terminale. Cosa succederà quando delegheremo loro la gran parte delle attività che attualmente svolgiamo noi? Per esempio, il lavoro in fabbrica o in ufficio? La domanda non ha solo ricadute pratiche. Se fosse così, la risposta sarebbe semplice: avremmo più tempo libero, rivaluteremo l’ozio creativo, daremo più attenzione al corpo. Ma cosa succederà quando questi automi acquisteranno coscienza di sé, rivendicando la propria autonomia? Si potrà dire che questo è uno scenario fantascientifico e irrealistico. Non è detto che la AI usi il suo sempre più immenso potere di calcolo per generare una nuova specie più intelligente della nostra che abbia la volontà di sostituirci. Ma non è detto neanche che non lo faccia.
Backup
Il rischio, in ogni caso, viene da noi stessi, non è limitato a quella che potrà essere la volontà di potenza degli automi. Viene dagli umani che, per sfuggire all’ansia della morte, creeranno incessantemente dei doppi nei quali cercheranno di trasferire la propria identità, cioè la memoria del nostro essere stati. Copie di noi stessi, riproducibili all’infinito e così potenzialmente eterne. Occorre però correre più veloci del tempo: solo se si riescono a duplicare le nostre tracce prima che vengano cancellate, si resiste al flusso dell’esistenza e quindi al destino della morte. E, così, mentre prima le metafore di noi stessi erano scolpite sulla pietra e quindi erano statiche e sostanzialmente inefficaci (la piramide, il tempio, la città ideale), oggi sono byte immateriali in grado di muoversi autonomamente nell’infospazio, di mutare e anche di auto riprodursi, come accade con i backup programmati. Nel tentativo di conservarci ad alta definizione, alla massima definizione possibile, i doppi saranno sempre più sofisticati. E numerosi perché di ogni originale, per paura di perderlo, faremo diversi backup. Così ognuno di noi genererà molte genealogie e noi, cioè le nostre copie digitali, saremo i molteplici figli di noi stessi. Moltiplicheremo il mondo, creando realtà parallele le quali, nonostante il nostro desiderio di possederle, aspireranno a sfuggire e alla fine, rendendosi autonome, ci sfuggiranno.
Architettura parametrica
Il destino di ogni proiezione è la simulazione (ogni metafora infatti simula la realtà, come per esempio accade con la prospettiva, con le proiezioni ortogonali o con le ombre della caverna di Platone). Ma ogni proiezione è una mutazione di un oggetto stesso in un altro, verrebbe da dire, una anamorfosi. Prendiamo adesso un albero disegnato con un programma di modellazione avanzato. Possiamo riprodurlo talmente bene da dare l’impressione, guardandolo attraverso un visore, che sia vero e che lo possiamo toccare.A questo punto l’oggetto è anche pronto per essere manipolato e mutato. Infatti, ogni struttura la si può mutare in un’altra struttura: una volta che ne conosciamo i principali parametri, possiamo farlo a piacimento, dando nuovi valori ai parametri stessi. E così questo albero virtuale in un attimo lo possiamo far invecchiare o lo possiamo sollecitare con la luce di un sole altrettanto virtuale, facendolo crescere verso un lato piuttosto che un altro. Non c’è realtà che non possa essere prima riprodotta e poi manipolata.Ecco in estrema sintesi l’architettura parametrica: una mutazione descrivibile attraverso una formula matematica.
Un potere, a ben pensarci, immenso di manipolazione che ci consente una sempre maggiore capacità di previsione e di controllo, e che fa gravare su di noi tremende responsabilità.
Cosa succede se applichiamo la logica parametrica al nostro codice genetico? E cosa succede, in generale, se lavoriamo sui codici che regolano la nostra vita mutandone le relazioni? Se per esempio aggiungiamo potenza di calcolo al cervello o potenziamo il corpo attraverso accorgimenti che gli permettano, per esempio, di volare? Per un uomo del rinascimento non ci sarebbero dubbi. Direbbe che stiamo creando dei mostri, cioè figure che si pongono fuori dall’armonia del mondo. Che non rientrano più nel cerchio e nel quadrato tracciati da Leonardo.
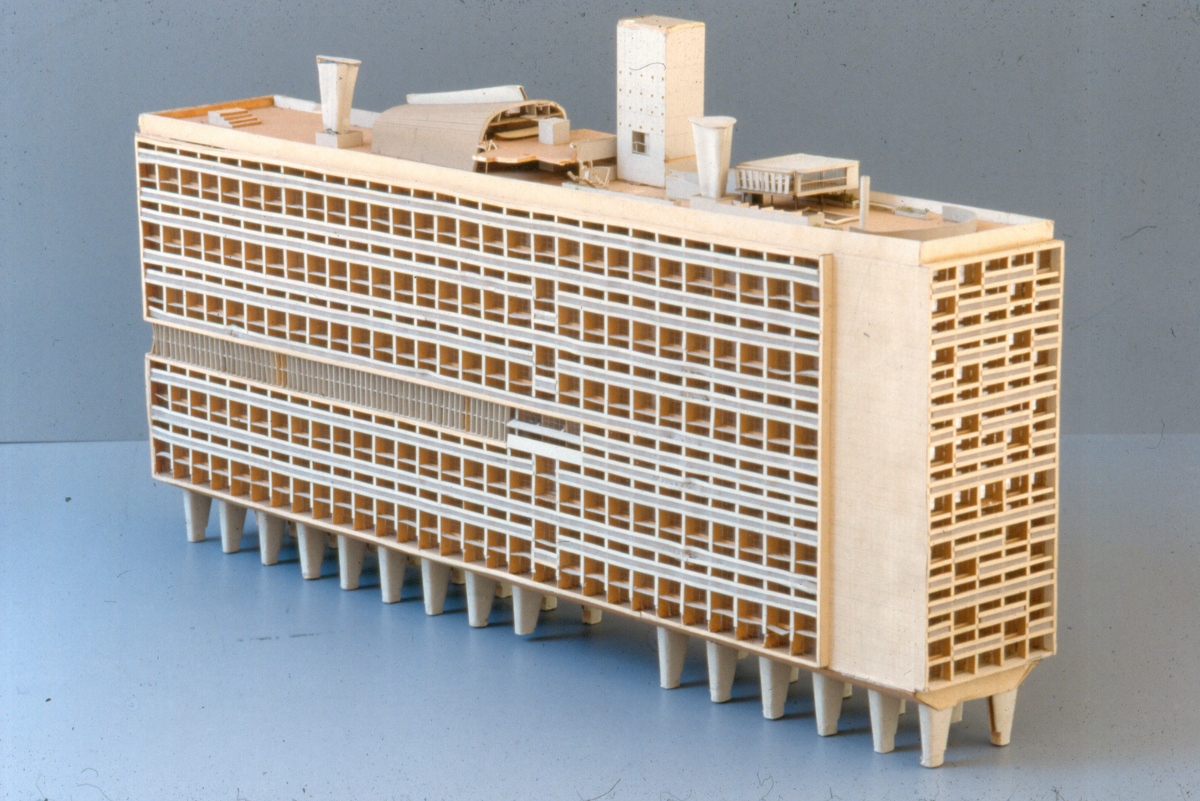
Sette novità
Torniamo all’architettura. Le nuove tecnologie l’hanno trasformata ridefinendola e dematerializzandola. Pensiamo per esempio alla progettazione di spazi nei quali studiare. Questa attività poteva avvenire quasi esclusivamente in una stanza appositamente attrezzata con libri e altri strumenti di conoscenza: lo studiolo rinascimentale, la sala lettura di una biblioteca oppure la stanza di casa fornita di un tavolo e di una libreria. Oggi si può benissimo studiare in un parco o in un luogo destinato a altro, per esempio un bar, portandosi il proprio personal computer e consultando via internet i libri che ci servono. Inoltre, le nuove tecnologie hanno reso obsoleti i vecchi concetti di ordine. Pensiamo all’autonoleggio. Per prendere una vettura in affitto, dovevamo recarci in luoghi ben precisi della città collocati in base a studiati criteri logistici. La macchina la troviamo direttamente in strada. Anzi, possiamo dire che più le automobili sono distribuite casualmente più sarà facile per l’utente trovarne una da noleggiare. Lo stesso accade alle librerie: prima dovevano essere ben ordinate. Oggi la ricerca ce la garantisce una app che i libri ce li fa trovare in un attimo mostrandoci una mappa con la individuazione dello scaffale con il volume cercato e, per evitare di farci perdere tempo, con un riassunto degli argomenti trattati. Si può quindi progettare senza mettere in discussione il caos, anzi utilizzandolo, basta porsi in un livello astratto e superiore di ordine: quello del software.
La terza novità imposta dalle nuove tecnologie riguarda la perdita dell’hic et nunc dello spazio. Siamo fisicamente in un luogo ma allo stesso tempo connessi a un database localizzato in una nuvola e in contatto telefonico o videotelefonico con persone che si trovano altrove. Per molte attività -lo ha dimostrato il telelavoro- il luogo è insignificante. Mentre sono sempre più indispensabili wi-fi e antenne.
La quarta novità è la nuova dimensione del controllo. Che avviene a distanza e spesso all’insaputa, come per esempio accade con i telefonini che registrano i nostri comportamenti e le parole che pronunciamo per poi mandarci la pubblicità di prodotti correlati. Nel caso degli edifici è oramai banale monitorare il funzionamento degli impianti comandandoli a distanza. E, anche, spiare e origliare le persone che utilizzano in presenza o a distanza la struttura. Registrandone i comportamenti come se stessero all’interno di un panottico.
La quinta novità è il tempo reale che si contrappone al tempo umano dell’architettura tradizionale. Con feed back immediati che ci fanno vivere in una realtà stereofonica. La ha ben descritta da Paulo Virilio con l’esempio di un pilota che vive in diretta la propria morte perché può vedere su un video in tempo reale le immagini del disastro aereo mandate da una telecamera posta a terra. Viviamo, insomma, la vita e nello stesso tempo ci vediamo mentre la viviamo. Cioè viviamo costantemente nella dimensione del pensiero che è quella di riflettersi, guardarsi allo specchio.
La sesta caratteristica del digitale è la moltiplicazione delle immagini. Non è un caso che l’architettura sia diventata sempre più metaforica, perché senza l’aiuto delle immagini ci risulterebbe difficile individuare, percepire e manipolare ciò che sta diventando sempre più immateriale. Ecco perché, per esempio, il nostro portatile non funziona più con il DOS ma con Windows un sistema operativo molto meno astratto (user friendly) che ci fa aprire finestre dentro le quali i nostri file hanno forma di cartelle.
La settima caratteristica è la realtà aumentata. Possiamo vedere da vicino, da lontano, da tutte le prospettive nello stesso istante. Amplificare suoni prima impercettibili, toccare materie inaccessibili. Guardare con infiniti occhi, compresi quelli degli altri. Pensate per esempio alle gare automobilistiche: le possiamo seguire da molteplici telecamere poste nei punti più svariati del circuito, confrontando dati oggettivi rilevati da numerosi sensori e anche con gli occhi degli stessi piloti grazie alle microcamere poste sui loro caschi. Il mondo delle ombre che prima gli schiavi della caverna di Platone vedevano come altro da sé e oggi può trasformarsi nella meta di un viaggio virtuale.
Equivoci
Le sette caratteristiche che abbiamo esaminato nel capitolo precedente confermano l’ipotesi che l’architettura stia cambiando e se ne stia sostituendo un’altra, l’HyperArchitettura, che è l’architettura dell’età dell’elettronica.
Ma, attenzione. Se l’HyperArchitettura fosse solo tener conto delle possibilità tecniche del digitale, sarebbe ben poca cosa. Sarebbe come pensare che l’architettura dell’età dell’automobile si riduca agli schemi di Alexander Klein o agli studi tipologici del secondo CIAM o alla cucina di Francoforte di Margarete Schütte-Lihotzky.
La storia ci insegna, invece, che i cambiamenti tecnologici agiscono con profondità sul versante della ricerca estetica. Per rimanere al nostro esempio, la nuova civiltà della catena di montaggio, del fordismo, della velocità dell’automobile, dello standard, hanno avuto una così importante ricaduta nella storia dell’architettura perché hanno modificato l’intero quadro problematico della ricerca artistica, presentando non solo opportunità ma soprattutto problemi che richiedevano nuove soluzioni. Infatti, le migliori opere di quel periodo furono progettate da coloro che i principi del meccanicismo li intesero in tutta la loro carica emblematica e contraddittoria. Penso per esempio agli architetti espressionisti o organici che lavorarono con registri poetici più complessi di quelli immediatamente funzionalisti. Ma anche agli stessi maestri, quali le Corbusier o Mies che il nuovo mito della macchina lo seppero interrogare, per esempio alla luce della tradizione classica, con risposte sorprendenti.
Occorre sfatare due equivoci. Il primo è che l’HyperArchitettura possa essere limitata al fatto di essere la nuova arte che dà forma all’immateriale. Quindi, per parlare di architettura dell’età dell’elettronica, non basta far suonare un allarme se entro in una zona virtualmente recintata oppure materializzare i flussi, altrimenti invisibili, con forme e colori facilmente percepibili, per esempio realizzando una struttura che cambia aspetto in relazione agli input ambientali. Il secondo equivoco è che l’HyperArchitettura si esaurisca nella parametrizzazione dei suoi volumi. Sia quindi soggetta ad essere trasformata in effetto speciale, cioè in un insieme di forme inconsuete e a volte artatamente cerebrali. Forme che alla fine, possono essere inutili, concettualmente statiche e che non si differenziano granché da quelle tradizionali se non per il fatto di essere molto più complicate.
HyperArchitettura
L’HyperArchitettura, insomma, non è l’esaltazione della nuova tecnologia, ma il confronto con la nostra contemporaneità, segnata dal digitale.E questo anche a costo di mettere in gioco l’intero sistema metaforico nel quale adesso ci riconosciamo.
Il problema principale per il prossimo futuro, a mio avviso, sarà disegnare spazi dove i diversi mondi, gli infiniti doppi che creiamo dovranno in qualche modo cercare di coesisterete tra loro e con noi stessi. Uno scontro che già sperimentiamo nelle apparecchiature di una automobile o di un elettrodomestico di ultima generazione. Si pensi per esempio alla Tesla, concepita come se fosse un computer e che, grazie a un sistema di sensori, nelle situazioni di pericolo entra in gioco automaticamente, cioè a prescindere dalla volontà del conducente. Chi comanda, a questo punto? Chi comanda in una casa dove ogni funzione è regolamentata e monitorata? Si tratta di una questione, a mio avviso, ben più rilevante di quella del decidere se i nuovi edifici saranno decostruttivisti o bloboidaili, neogotici o High Tech. Il problema, più in generale, è lo stress di vivere in una architettura, anzi una HyperArchitettura, dove tutto si proietta, si duplica e si trasforma in informazione. Dove i confini, anche quelli del nostro corpo, diventano trasparenti. E le nostre scelte irrilevanti. Prendiamo, per proporre un esempio paradossale, il diritto di spegnere l’aria condizionata. Nessuno ce lo toglierà mai, spero. Ma a che serve se poi non posso aprire le finestre per non scompensare l’intero edificio? E chi mi salverà dalle ire dell’amministratore di sistema, forse una Intelligenza Artificiale, che scoprirà che il giorno di Ferragosto ho aperto le finestre per tre ore? l’HyperArchitettura, se intesa nella sua accezione negativa, rende, infatti, ogni azione trasparente, uccide la privacy. E quindi può darsi nel prossimo futuro cercheremo più protezioni che nuovi stimoli, certezze invece che dispositivi sempre più sfuggenti, relazioni materiali più che spericolati duplicati digitali. Anzi, tutto ci fa pensare che la prossima architettura tenderà al vernacolare o comunque al regionalismo, si relazionerà sempre più con il contesto, adopererà materiali empatici, favorirà il contatto con la natura, cercherà di recintare zone di protezione che ci facciano da scudo contro i flussi di dati che dilagano nell’infosfera. Si genererà allo stesso tempo molta retorica: Boschi verticali, finte Disneyland, bei presepi. E, come sempre accade, qualche opera indimenticabile. Per tornare all’argomento precedente: è la Casa sulla cascata la risposta migliore che gli architetti del Novecento danno al mito del meccanicismo e non certo i pur utili schemi del Klein. È la leggerezza poetica dell’Asilo sant’Elia di Terragni e non le razionali siedlung disegnate da Gropius in base ai principi della perfetta insolazione. È la poesia danzante della Maison de Verre di Pierre Chareau e Bernard Bijvoet non la ingessata casa sperimentale unifamiliare Haus am Horn di Georg Muche e del dipartimento di architettura del Bauhaus. Vivere la contemporaneità non vuol dire, infatti, ammalarsi di contemporaneità né vestirsi con la tuta da operaio, nel Novecento. o con la tuta spaziale, oggi.
The end
A questo punto abbiamo quasi chiuso il cerchio. Nel primo paragrafo notavamo che usiamo la parola architettura per parlare di sistemi non propriamente architettonici, come per esempio l’organizzazione della mente. In questi ultimi paragrafi arriviamo alla conclusione che viviamo nell’ HyperArchitettura dove vale la legge che tutto è architettura, anche i sistemi della mente. E dove l’intelligenza artificiale cambierà il modo di fruire lo spazio e quindi di rapportarci con il mondo. Tutto fa pensare che questo cambiamento sarà di forte impatto. Non tanto per l’invenzione di un nuovo stile – già viviamo in una dimensione eclettica e di massima libertà linguistica- quanto per le modalità inaspettate in cui nello spazio reale e virtuale si intrecceranno materiali e immateriali, umano e postumano, artificiale e naturale, pubblico e privato, linguaggio colto e linguaggi della comunicazione. E, se è pur vero che tutto è architettura, non è affatto detto che tutto sarà buona architettura. Per dire che toccherà, comunque, a noi scegliere come organizzare e valorizzare i pezzi di questo mondo sempre più ibrido che verrà. Ecco, in sintesi, il progetto della HyperArchitettura oramai alla versione 2.0 o, come mi suggeriva un amico, alla versione 4.0 oppure 5.0 per dire che si tratta di un nuovo paradigma con una lunga storia che parte almeno dalla seconda metà Anni Cinquanta.
Luigi Prestinenza Puglisi
Libri consigliati:
(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





