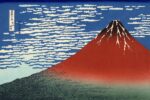Le vite immaginarie dei giovani italiani
Nello scorcio finale di questa estate 2013, stando per parecchi giorni qui al Sud, ho fatto caso (meglio e con più attenzione) a un fenomeno che avevo già notato, ma non studiato. La maggior parte dei ragazzi e dei giovani adulti, nei paesi e nelle città meridionali, sembra vivere esistenze immaginarie. Del tutto finzionali.

Credo che capirete come le difficoltà che incontro nello scrivere,
nessun altro autore nell’arco dell’intera storia umana le abbia
mai incontrate: alcuni scrivevano per i loro contemporanei,
altri per i posteri, ma nessuno mai ha scritto per gli avi o per
esseri simili ai loro avi lontani e selvaggi…
Evgenij Zamjatin, Noi (1919-20)
Mi spiego meglio: quando vedi uno che “fa l’avvocato”, o che “fa il commercialista”, o anche che “fa l’ingegnere”, o persino che “fa l’artista”, hai la sensazione piuttosto netta che quasi mai stia facendo quel mestiere per davvero. Svolgendo un lavoro, infatti, tu vivi e ti guadagni da vivere grazie alla tua opera e alla tua professionalità. Questi invece recitano, continuamente; prendono parte a una commedia che investe praticamente ogni aspetto della loro vita quotidiana.
In questa recita, svolgono un ruolo fondamentale i “macchinoni” (francamente ridicoli e fuori luogo in mano a trentenni in fondo spiantati), le belle camicie, le cene fuori. La domanda che sale spontanea alle labbra in questi casi è: “Ma come campano?” Questi individui di specie nuova (ma non troppo, poi: basta pensare a I vitelloni, o alla figura del genero a tavola in Amarcord…) vengono “campati” dalle famiglie, dai genitori. Non solo al Sud, mi sembra, ma ormai nell’intero Paese.

Federico Fellini, Amarcord (1973)
Si è così venuta costruendo, negli ultimi decenni, una “metafisica della paghetta”, una forma espansa e patologica – ma a suo modo molto sofisticata – di paghetta, che si è estesa indefinitamente nel tempo e nei dominii esistenziali. Pur di assicurare ai figli una finzione di normalità, un’illusione di età adulta, un’autonomia farlocca, questi genitori sono stati capaci di dare vita a una struttura sociale tra le più sbilanciate della storia: una struttura distopica in cui il tuo benessere apparente anche oltre i trent’anni (a volte addirittura oltre i quaranta…) dipende e viene garantito dai tuoi vecchi (e a volte dai loro vecchi) a patto che tu te ne stia buono e non faccia niente di testa tua.
Che non faccia niente, in particolare, per contestare e per contrastare questo stato di cose.
A condizione che rispetti in tutto e per tutto questo patto generazionale scriteriato: “Tu non fai nulla insieme a quelli della tua età, agli altri ‘figli’ come te, per modificare e alterare questa condizione collettiva fallimentare e disastrosa, e noi assicuriamo in cambio a te (sempre e solo come figlio/a singolo/a, mai e poi mai come membro attivo di un gruppo sociale, di una collettività) il necessario per non sfigurare con i tuoi coetanei. E per vivere in compagnia della tua ragazza/o una vita… da sogno”.
In questa società immobile, bloccata, un paio di generazioni hanno saputo quindi “generare” quasi solamente il paradosso terribile e agghiacciante di adulti-bambini e vecchi che recitano la parte di giovani. (Ah, già: nel conto c’è anche il crollo di ogni struttura di convivenza civile.)
Il punto di origine è sempre e comunque negli Anni Ottanta italiani. Lì si compie la mutazione storica e antropologica intravista da Pasolini e ne inizia un’altra, forse ancora più radicale. Da Vermicino alle tv private, i processi trasformazione, rimozione e riflusso si intrecciano e si sovrappongono: nascono i fantasmi che ci visiteranno nei successivi decenni. Il nostro Paese è quindi preda da almeno trent’anni di una forma acuta di dissociazione dalla realtà, di vera e propria schizofrenia: si è raccontato un’altra verità rispetto a quella effettiva, un’altra identità.

George Lucas, THX 1138 (1971)
Ma la dissociazione può anche diventare iper-dissociazione. Oltre a quella dei cinquanta-sessantenni, esiste infatti anche quella dei trenta-quarantenni. Questo distacco acuto e peculiare fa sì che le persone (leader o futuri leader; imprenditori; intellettuali o aspiranti tali ecc.) abbiano magari ben chiaro in mente quello che c’è da fare, le soluzioni da adottare per scardinare per esempio chiusure, corporativismi e protezionismi in tutti i settori della società, e le dicano anche ad alta voce con passione e competenza; ma che poi rimangano, mentre parlano e si esprimono, prigionieri dei linguaggi e degli schemi interpretativi ereditati dalla/dalle generazioni precedenti.
Che rimangano, in definitiva, sequestrate all’interno del “teatro”, dell’eterna commedia delle parti nazionale, che consegna qualunque intenzione al dominio della rappresentazione, e mai invece all’azione nella e sulla realtà. In questo modo, il pensiero non diventa tensione autentica, orientata alla trasformazione del mondo circostante. L’aspetto tragicomico, poi, dell’intera faccenda è che tutto ciò accade proprio in chi è fermamente convinto di essersi messo nella direzione giusta, di essersi finalmente e definitivamente sganciato dall’eterno compromesso e dai comportamenti dei padri.
Christian Caliandro
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati