Rendere visibile l’invisibile. L’arte dei profumi spiegata attraverso alcuni miti
Dal “message in a bottle” di Duchamp agli spazi atmosferici di Eliasson: l’invisibile prende corpo e nell’aria trova un alleato potente. Ma con Lutens, Malle e una nuova generazione di nasi-autori, il profumo cambia intenzione

Da sempre rincorriamo ciò che non si vede. L’arte si guarda? Il profumo si respira? Intanto, l’opera oltrepassa l’immagine e preferisce farsi esperienza. Duchamp, Cage e Eno sono tre maestri della percezione che mostrano come l’opera nasca nell’aria — nell’intenzione dell’artista che diventa attenzione condivisa. Aristotele, nel De anima, aveva già messo in chiaro che l’aria non è vuoto ma mezzo che rende udibili i suoni. E ciò vale anche per l’olfatto: senza aria non c’è esperienza sensibile.
Quando l’opera prende fiato
Nel 1919 Marcel Duchamp sigilla il vuoto con Air de Paris. Nel 1921 rilancia con Belle Haleine – Eau de Voilette: flacone Rigaud, etichetta rifatta, Rrose Sélavy in bella mostra e una scritta che scivola da toilette a voilette. L’odore diventa chiamata in scena e pretende complicità. Trent’anni dopo, con 4′33″ (1952), John Cage toglie la musica e trattiene il silenzio, occupato da respiri, fruscii, odori e rumori di sala. Su un crinale parallelo si muove Brian Eno: musicista-non-musicista e regista di percezioni, costruisce geografie sonore generative, ambienti da abitare.
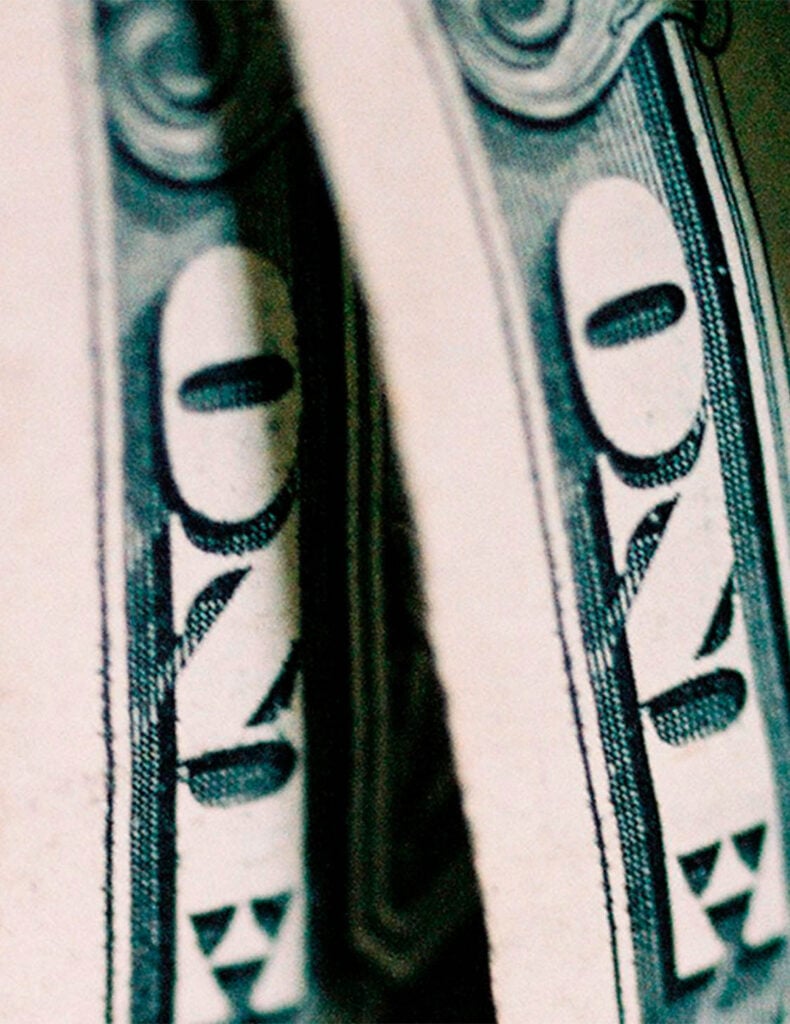
Una nuova generazione di nasi-autori
Tonino Griffero rincara: “I luoghi non sono sfondi neutri, ma spazi sensibili, e sempre, dico sempre, l’olfatto arriva prima dello sguardo”. Su questa eredità si muove una generazione di artisti che usa gli odori come alfabeto vivo. Giuseppe Penone in Respirare l’ombra (1999) crea gabbie d’alloro che si annidano nell’aria in un corto circuito tra presenza e asfissia. Con Olafur Eliasson la dimensione spaziale e il suo “clima” diventano opera stessa. Massimo Bartolini in Mixing Parfums (2000) costruisce due stanze profumate e una porta girevole luminosa che, al passaggio del pubblico, mescola le scie e fa nascere l’accordo olfattivo. Da qui la costellazione si allarga: Ryan Gander con I Need Some Meaning I Can Memorize rianima le navate bianche del Fridericianum con un filo d’aria che cambia umore urtando i corpi; Sissel Tolaas alfabetizza i nasi; Ernesto Neto cuce membrane che respirano spezie; Satoshi Hirose fa del profumo un metronomo del tempo. Nel 2003 Sophie Calle chiede aiuto al naso Francis Kurkdjian per distillare L’Odeur de l’argent: l’eco chimica che resta sulle dita dopo aver contato denaro. E quando nel 2024 a Palazzo Loredan a Venezia, la mostra Invisible Questions That Fill the Air accosta James Lee Byars a Seung-taek Lee, l’opera accade dove l’oggetto arretra e riverbera una domanda. Dave Hickey a proposito di Byars spiega che “vedere non è abbastanza; dovremmo ascoltare le domande invisibili che riempiono l’aria”.
Il profumo Chanel N°5 diventato cult
“Cosa indossa per dormire? Solo due gocce di N°5”. Da quella battuta di Marilyn nel 1952, il profumo esce dalla toilette e entra nell’immaginario collettivo. Dietro il mito c’è un esperimento ardito: Gabrielle Chanel chiede a Ernest Beaux “un profumo che sappia di donna, non di fiori”, lui presenta vari modelli e lei sceglie il quinto. Da allora circola la leggenda dell’overdose di aldeidi: forse esagerata, certo efficace nel dire quel lampo astratto che accende la formula. Accidente o disciplina, da lì nasce un’idea nuova di femminilità olfattiva – Chanel N°5 – e il flacone, severo ed essenziale, la spiega senza parole. Eppure, di Beaux ricordiamo a malapena il nome.

Annusare per credere
Eccoci al punto: il profumo si candida a uscire dallo scaffale e entrare nello status di oggetto artistico. Non come semplice prodotto d’uso che soddisfa, ma come progetto artistico da esperire. Accade quando c’è un’intenzione autoriale chiara — del direttore creativo o del maître parfumeur che non si limita a eseguire un brief— e quando esistono un luogo e un pubblico disposti ad ascoltare con il naso. La traiettoria parte da Edmond Roudnitska: rigore, teoria lucidissima e una sequenza che sposta l’asse della profumeria—Diorama (1949), Diorissimo (1956), fino a Eau Sauvage (1966) con la trasparenza tagliente dell’hedione. Poi, a metà degli Anni Settanta, Jean Laporte con L’Artisan Parfumeur mette in vetrina la creatività —piccole serie (“nicchia”), ingredienti in primo piano. Il profumo smette di inseguire la moda e ritrova la bottega d’autore: un prologo necessario alla dichiarazione di poetica che, vent’anni dopo, Malle porterà in etichetta. È la grammatica dell’arte: sottrarre, dare forma a un’idea.
Il riconoscimento degli autori nella profumeria
Il riconoscimento esplicito degli “autori” arriva solo nel 2000 con Frédéric Malle e le sue Éditions de Parfums: una svolta curatoriale. Maestri come Ropion, Ellena, Roucel compaiono in chiaro sulle etichette, con firma e poetica riconoscibili. In parallelo, Serge Lutens — regia ferrea, estetica anticonvenzionale, culto dell’essenziale — ripensa l’immaginario di Shiseido negli Anni Ottanta e, nel 1992, apre Les Salons du Palais Royal: non una boutique, ma un palcoscenico dove il profumo debutta come opera prima. Su questa scia, direttori artistici come Christopher Chong (gli anni d’oro di Amouage) lavorano per “library” intere con iconografie, intenzioni poetiche e scelte di materie prime mirate: il profumo smette di essere cosmetico e diventa linguaggio.
Il presente e futuro della profumeria
Oggi una nuova leva internazionale spinge la ricerca: Antoine Lie, Prin Lomros, Hiram Green, Antoine Corticchiato (la lista potrebbe continuare) riportano le materie prime al centro con rigore radicale, spostando il profumo dal prodotto al pensiero, e viceversa. Anche l’Italia fa scuola. Lorenzo Villoresi, pioniere della profumeria d’autore, ha messo Firenze al centro di una geografia olfattiva (il suo Museo di Arte della Profumeria lo testimonia) e una metodologia rigorosa sulle materie prime. Maria Candida Gentile porta dal 2009 una voce lirica e mediterranea; Antonio Alessandria, dal suo Boudoir 36 a Catania, lavora il tempo come racconto. Antonio Gardoni spinge sulla fisicità, sull’ascolto ravvicinato della materia; Meo Fusciuni insiste sulla poetica (“il profumo è un’anima che disegna la nostra ombra”). E poi Rubini: direzione creativa mantovana che orchestra team di profumieri e artigiani per progetti corali in cui ricerca creativa, formula e oggetto avanzano all’unisono. È solo l’inizio, il sistema poi si adegua: testi critici, mostre e musei che mettono l’olfatto al centro—dall’apripista The Art of Scent 1889–2012, curata da Chandler Burr (già critico del New York Times e autore de L’Imperatore del profumo), fino alla Pinacoteca di Brera con le didascalie olfattive che introducono un percorso sensoriale. Anche l’ultima obiezione prevedibile, quella sulla riproducibilità (un profumo si produce in serie), perde forza se ricordiamo che anche la fotografia vive di tirature limitate senza per questo essere esclusa dal museo. Non l’odore in sé, ma l’idea dell’odore—e la sua messa in forma come opera.
Federica Bianconi
Libri consigliati:
(Grazie all’affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





