Come leggere il presente senza nostalgia del passato? Risponde Vincenzo Trione
All’indomani dell’uscita del suo ultimo libro “Rifare il mondo. Le età dell’avanguardia”, l'autore ci racconta come ha montato questa cartografia in cui, senza omettere le differenze, individua una certa continuità tra il Secolo Scorso e la contemporaneità

Che cosa resta oggi dell’Avanguardia? In Rifare il mondo. Le età dell’avanguardia Vincenzo Trione prova a liberare il termine dall’abuso e a restituirgli una funzione operativa. Non cerca l’ennesima cronaca dei “-ismi”: interroga un presente in cui l’energia di rottura si è rarefatta nei musei e nel mercato, ma riaffiora come “Avanguardia postuma” a bassa intensità – nelle scritte sui muri, nelle azioni degli attivisti, nelle culture pop e di piattaforma. Il libro costruisce una mappa transdisciplinare senza perdere il filo critico, perché ogni caso è testato su un criterio semplice: capacità di spiazzare lo sguardo e inventare linguaggio. La struttura procede per “età” – dall’oro al ferro – e genealogie, riattivando linee lunghe del Novecento più che celebrandone i miti. Nell’intervista, Trione racconta come ha montato questa cartografia, dove individua oggi reali margini di frizione dentro e fuori le istituzioni, e perché il dialogo con le tecnologie non neutralizza necessariamente il rischio creativo. Una guida per leggere il presente senza nostalgia, cercando dove ancora brucia la voglia di “rifare il mondo”.
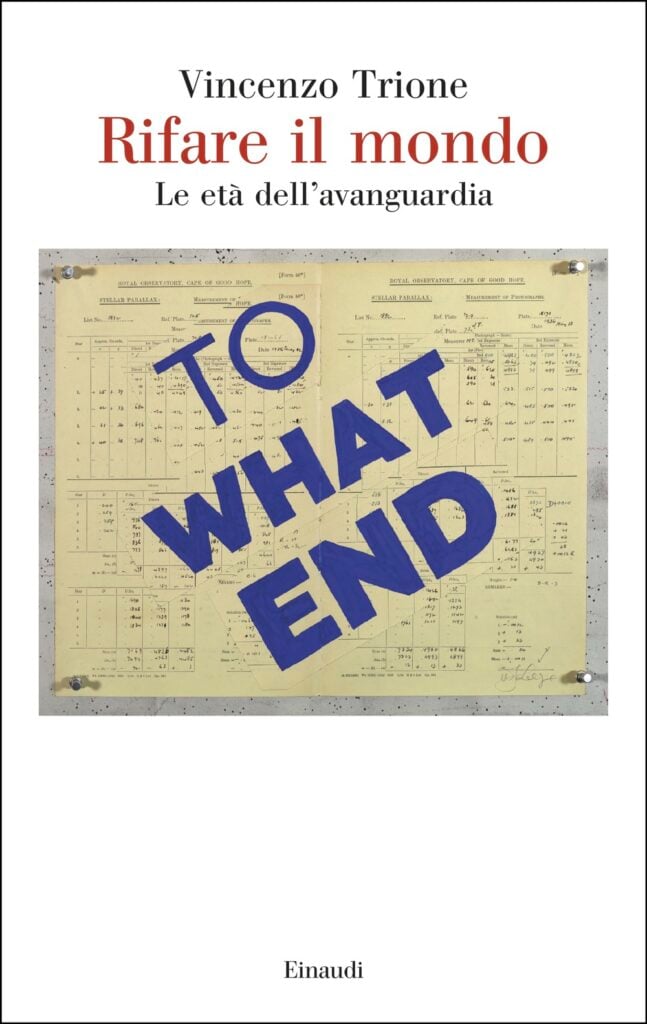
Intervista a Vincenzo Trione
Nel libro l’Avanguardia smette di essere un’etichetta generica e torna categoria operativa. Qual è, per te, il criterio minimo che oggi permette di parlare davvero di avanguardia senza inflazionare il termine?
Diciamo subito che siamo lontani dall’età d’oro dell’Avanguardia, dai primi decenni del XX Secolo, quando artisti attivi in realtà geografiche e culturali diverse in Europa avvertono insieme l’esigenza di trasformare il modo di fare arte, di scegliere il futuro come misura della qualità del proprio intervento e di pensare che l’arte possa essere uno strumento per, come suggerisco nel titolo, rifare il mondo. Questa utopia, anche in qualche modo titanica, si è radicalmente persa nel nostro tempo.
In particolare, a cosa ti riferisci?
Siamo in un tempo in cui il mercato ha mercificato il rifiuto del mercato stesso, il museo ha assorbito tutto e il contrario di tutto; quel museo che era stato demonizzato e attaccato da profanatori, iconoclasti come i protagonisti dell’avanguardia, penso in particolare ai futuristi, ma anche ai dadaisti; abbiamo assistito al dissolvimento di ogni tipo di scandalo, mi pare che ogni giorno celebriamo la sparizione dell’Avanguardia e questo è il fenomeno interessante, una delle più grandi utopie delle Avanguardie, sostenuta da Balla e De Pero nel 1915, era stata quella di avviare la ricostruzione futurista dell’universo; di rifare il mondo nel segno dell’arte; questo mi sembra che in qualche modo si sia compiuto, ovvero siamo in un tempo di una sorta di Avanguardia postuma.
Ci puoi spiegare cosa intendi?
Siamo in un tempo in cui l’arte si è dissolta nella vita e abbiamo assistito all’avvento di un’Avanguardia debole e a bassa intensità; si manifesta ad esempio nelle uscite dei writers, ma anche nei gesti degli attivisti di ultima generazione, è un’avanguardia senza intenzione, che in maniera del tutto inattesa, imprevista, riprende alcune categorie come l’iconoclastia, l’idea di arte e azione che erano state enunciate dai protagonisti delle avanguardie del Secolo Scorso. Infine, alcuni artisti oggi hanno rilanciato, reinventato le idee proprie delle avanguardie, come Thomas Hirschhorn che ha ripreso il gusto caro a Schwitters di assemblage per dar vita dei monumenti anti monumentali, il gusto per la sperimentazione di David Hockney, l’incrocio fra linguaggi e pratiche non contigue di William Kentridge, ma anche al gusto per le invenzioni ardite di Frank Gehry; dunque mi sembra che alcuni autori abbiano rilanciato quella tradizione su un piano e su un registro completamente diverso.
Sposti l’osservazione oltre l’artworld: cinema, moda, musica pop, videogame, writing, attivismo. Come hai costruito questa mappa transdisciplinare senza diluire il concetto? Quali test hai usato per includere o escludere un caso?
Senz’altro, nel libro sono presenti molte esperienze che vivono fuori dal circuito artistico tradizionale, cinema, moda, musica pop, videogame, writing, attivisti di ultima generazione. A me, devo dire, questo approccio manifesta per un verso una qualche insofferenza nei confronti di un approccio eccessivamente verticale, rigido e chiuso, senza anima, che talvolta caratterizza gli storici dell’arte; per un altro verso mi capita spesso di avere una certa insofferenza nei confronti delle proposte che vengono fuori da rassegne internazionali come la Biennale di Venezia, Documenta di Kassel, che nel tempo mi ricordano sempre di più la fortezza Bastiani raccontata da Dino Buzzati nel Deserto dei Tartari, ovvero luoghi chiusi in se stessi, indifferenti a quello che succede intorno a sé, rivolti soprattutto a chi già appartiene a quel sistema. Questa è la ragione per cui già in un libro precedente, che un po’ rappresenta con quest’ultimo un ideale dittico, mi riferisco all’Opera Interminabile, uscito nel 2019 da Einaudi, dove provavo a costruire un canone dell’arte del Ventunesimo Secolo in cui si trovavano a convivere Kiefer, Kentridge, Pamuk, S. Devlin, Bjork e altre figure legate a mondi esterni al sistema dell’arte.
Cosa ti ha spinto a guardare fuori dall’art world?
Una sollecitazione decisiva nel nuovo libro è venuta da un film, Crime of the Future di David Cronenberg, in cui ho trovato più arte contemporanea di quanta spesso mi capita di vedere a Venezia. Ecco il bisogno di guardare fuori e di trovare tracce d’Avanguardia nell’altrove, credo che sia una mia inclinazione naturale, reazione a un certo fastidio nei confronti di un tardo e sterile vuoto concettualismo, gusto per l’arte politica spesso priva di ogni intenzione ideale.
Musei, mercato, piattaforme: ambienti spesso normalizzanti. In che modo l’avanguardia può ancora “forzare il quadro” dall’interno di queste istituzioni senza trasformarsi in stile? Dove vedi oggi margini reali di frizione?
Musei e mercato tendono a normalizzare, a cancellare ogni tipo di scandalo, di profanazione, di irrisione. Si tratta di dispositivi che hanno il potere di cancellare le differenze ed è questa la ragione per cui spesso è opportuno riferirsi ad altri ambiti, come i gesti di attivisti di ultima generazione, autori, ai writers, ma anche ai protagonisti della street art, per cogliere esperienze in grado di disattendere le aspettative. Se dovessi dire in poche parole qual è il senso dell’Avanguardia, direi che si dà come capacità di prendere in contropiede lo spettatore e di inventare linguaggio.
In che senso?
L’Avanguardia deve avere sempre creare una frattura, una cesura, certamente occorre dirlo, i protagonisti di cui parlo anche nel libro dell’Avanguardia postuma sono del tutto privi di quella che era in fondo la dote principale dei protagonisti delle esperienze del Secolo Scorso. Futuristi, dadaisti, surrealisti, provarono a inventare oggi un mondo possibile domani, questa carica mi pare difficile da ritrovare; piuttosto mi sembra possibile ritrovare il bisogno di interrogare da angolazioni diverse le forme del presente.
Dalle genealogie storiche al presente: quali forme di “voglia di rifare il mondo” ti sembrano più fertili oggi (anche in Italia)? E che ruolo attribuisci alle comunità creative diffuse – on e offline – nel rinnovare quella spinta?
Utilizzi una categoria per me fondamentale che è quella di genealogia, che riprendo dal pensiero di Michel Foucault. Ho sempre guardato da una certa distanza coloro che provano ad aderire esclusivamente al presente, credo che il compito dello storico dell’arte, che ha anche una forte inclinazione critica, consista proprio nel cercare di far affiorare le ragioni segrete del presente; in fondo è quello che cerco di raccontare anche nei miei corsi, nei dialoghi con i miei allievi e collaboratori, negli articoli per il Corriere; cerco sempre di vedere come ciò che sta accadendo oggi abbia dietro di sé radici lontane. Ecco, l’aspetto che mi ha affascinato maggiormente in questo libro è vedere come tante delle esperienze che ci circondano nascano dal bisogno di riprendere, rilanciare, riscrivere, riattivare idee, intuizioni nate circa un secolo fa, in modo particolare penso proprio al caso del Movimentismo.
Ci puoi dire di più?
Spesso abbiamo raccontato l’arte del nostro tempo come una geografia caratterizzata, a differenza di quanto era accaduto nel Secolo Scorso, da personalità individuali. Cioè, se nel Novecento gli artisti tendevano a fare gruppo, nella contemporaneità si è spesso detto che gli artisti preferiscono procedere come monadi individualmente; invece, nel libro cerco di dimostrare come esista anche una forma di Neo-movimentismo, ad esempio nel recupero del valore delle comunità diffuso in tutto il mondo, in modo particolare in Africa, in parte ispirato al Movimentismo delle Avanguardie che porta alcuni artisti a coalizzarsi; a pensare la propria azione come parte di piattaforme più ampie, oppure a lavorare in coppie; nel libro ho presentato i risultati di una ricerca che rivela questa cartografia piuttosto sorprendente, segnata proprio dall’affiorare di gruppi e movimenti in tutto il mondo; probabilmente il senso del fare insieme, del fare comunità sta pian piano ritornando in un mondo in cui spesso tendiamo a operare come degli hikikomori.
La struttura del volume attraversa “continenti” storici e approdi contemporanei: qual è stata la tua regola di montaggio tra capitoli, casi e immagini per evitare la cronologia scolastica e tenere invece vivo il filo concettuale?
Il libro è scandito in memoria della classica divisione esiodea che procedeva per età. Dunque, si va dall’età dell’oro, all’argento, fino al bronzo. Questo artificio mi ha consentito di ripercorrere la storia delle Avanguardie tra XX e XXI Secolo. Il libro, pur essendo una trattografia libera, personale, attraversata da rimandi anche autobiografici, segue un andamento storico piuttosto preciso che individua alcuni momenti salienti, la nascita delle Avanguardie, l’esperienza della Metafisica che è una forma di Modernismo Antimoderno, l’età del Postmoderno anticipata dall’esperienza di Andy Warhol, per arrivare fino al nostro tempo; con un andamento che per un verso esplora i ritorni della tradizione delle Avanguardie, in modo particolare la stesura dei manifesti, la ripresa della tradizione del Futurismo, Dadaismo, Surrealismo, Metafisica, l’idea delle piattaforme, delle coppie, dei collettivi; infine le esperienze vagamente un po’ alla Schwitters di Hirschhorn, il gusto per l’intermedialità di Kentridge, per la sperimentazione, anche l’incrocio tra pittura e tecnologia proposto da Hockney. Poi il libro recupera la grande ripresa del Futurismo, come nel caso del Guggenheim, del visionario concerto degli U2 a Las Vegas, The Sphere; infine, tocca due fenomeni di grande interesse: videoclip e videogame e incrocia la sfilata sorprendente di Alessandro Michele per Gucci a tema cyborg.
Quindi come definiresti l’andamento del libro?
Storico, critico ma anche problematico, ogni capitolo parte dallo studio di un caso, da cui deriva una riflessione su un fenomeno. Perché penso che fare storia e critica d’arte non debba mai essere un esercizio teorico astratto; io rispetto la centralità dell’opera o comunque del lavoro preso in oggetto.
Tra algoritmi, IA generativa e culture di piattaforma, l’innovazione corre più veloce delle forme artistiche. Vedi in queste tecnologie un nuovo terreno d’avanguardia o un dispositivo che tende a neutralizzarla? Dove collocheresti oggi la soglia del rischio creativo?
Tocco tangenzialmente il rapporto tra Avanguardia e tecnologia, su diversi fronti. L’idea di fare le cose per la prima volta è un’intuizione che le Avanguardie traggono dalle scienze. Oggi il dialogo con le tecnologie emerge in tanti episodi, per esempio nelle video installazioni di David Hockney, nei concerti di YouTube spesso progettati da S Devlin, in videoclip e, soprattutto, nei videogame. Infine, il rapporto con le tecnologie ritorna nelle sperimentazioni con l’AI, nelle esperienze a cavallo tra arte e tecnologia. Piattaforme come Snapchat riprendono, forse senza volerlo, intuizioni, spunti, sollecitazioni dai protagonisti del Surrealismo.
Come spieghi, sintetizzando, questa situazione?
Credo che in fondo il Novecento non sia mai finito nel mondo dell’arte. Parlare d’Avanguardia significa parlare della grande arte che ha preso il testimone dalla tradizione della modernità e l’ha rilanciato su un registro diverso. In fondo il Novecento è un secolo che non ha ancora smesso di dire quello che aveva da dire. Larga parte dell’arte attuale lo dimostra, esiste una meravigliosa e problematica continuità tra il tempo che stiamo attraversando e quello che Guido Ceronetti chiamava un Secolo Crudele. Certamente sono cambiate tensioni, abbiamo smarrito il senso della profezia. Resta un’Avanguardia che in molti casi vive, lo avevano già intuito alla fine degli Anni 70, prima Umberto Eco e poi Maurizio Calvesi, nei linguaggi di massa.
Dicci di più?
Umberto Eco, interprete di questa svolta, sull’Espresso diceva che agli inizi del Novecento tanti intellettuali erano capaci di leggere le provocazioni di Apollinaire, Breton, Zara, mentre quando si imbattono in esperienze che, senza volerlo, riprendono quelle intuizioni, manifestano un certo disagio o un’evidente incomprensione. Credo che esista una problematica continuità per cui se dovessi dire in una battuta, se le Avanguardie del Novecento avevano provato a uccidere il padre, gli eredi di quella tradizione avviano un confronto continuo, talvolta mimetico, altre volte problematico, con i padri.
Dario Moalli
(Grazie all'affiliazione Amazon riconosce una piccola percentuale ad Artribune sui vostri acquisti)
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





