Dialoghi di Estetica. Parola a Marco Senaldi
Marco Senaldi è critico e teorico di arte contemporanea. Ha insegnato estetica dell’arte contemporanea e dei media in diverse università e accademie, e ha curato mostre tra cui “Cover Theory. L’arte contemporanea come reinterpretazione” (2003), “Il marmo e la Celluloide. Arte contemporanea e visioni cinematografiche” (2006), “Fuori fuoco” (2012). La riflessione sul godimento estetico e il piacere, l’arte in rapporto al cinema e agli strumenti di comunicazione mediatica, la sua natura soggettiva e la relazione con la riflessione filosofica: questi i temi affrontati nel dialogo.

Nel 2003 pubblichi con Meltemi – casa editrice romana che purtroppo ha chiuso i battenti, dopo aver dato un contributo importantissimo alle “scienze umanistiche” – un libro che si intitola Enjoy! Il godimento estetico…
Meltemi, fondata da Marco Della Lena, scomparso troppo presto, e dalla sua compagna Luisa Capelli, è davvero stato un editore in grado di colmare uno di quei vuoti che periodicamente si creano nella trama culturale italiana. Siamo un Paese ingrato e dalla memoria corta, che quindi non riconoscerà in tempi brevi questi meriti; io però, personalmente, non solo non ho alcun rammarico di essere stato l’autore di un editore che ha chiuso, ma ne vado anzi fiero: Enjoy poteva uscire solo da Meltemi. Così come Obversione poteva essere edito solo da Postmediabooks.
Gli editori così detti minori non sono un ripiego rispetto a quelli sedicenti “maggiori”: sono invece, nei casi migliori (e i due citati lo sono), un vero luogo di parola, dove all’autore non viene chiesto (e questo per me è fondamentale) di scendere a nessun compromesso.
Affrontare allora (ma in realtà anche oggi) il tema del piacere nella fruizione dell’arte poneva senz’altro almeno un problema: quello di contrastare un’idea algida della ricezione dell’arte contemporanea. Perché hai ritenuto invece di mettere al centro proprio tale questione?
Perché la questione del godimento è centrale nell’arte contemporanea. Infatti, questo sentimento (chiamiamolo così) impone una piega imprevista alla dimensione estetica classica, dominata dal piacere. Il godimento non è affatto un piacere di grado superiore, ma indica piuttosto il momento in cui il piacere si inverte in se stesso, incorporando il sentimento opposto, diventando piacere nel dispiacere. Se il piacere sottintende una fruizione equilibrata, il godimento trascina con sé eccesso insostenibile e mancanza incolmabile. Godere di qualcosa significa avere con quella cosa una relazione dominata dall’ambivalenza e dalla contraddizione.
Ora, dato che, in senso moderno, la fruizione estetica implica una dimensione riflessiva, ne segue che anche il godimento è un’esperienza estetica che “ritorna” su chi la effettua, generando nel soggetto una sensazione di turbamento e contraddizione. Si tratta però di qualcosa di sostanzialmente diverso dalla provocazione o dallo scandalo: lo shock avanguardista ottiene il suo effetto solo all’interno di un contesto tradizionale, mentre il godimento estetico è un circuito chiuso immaginario dove il soddisfacimento è sempre desiderato, e sempre posposto.
La controparte del godimento, sempre in eccesso, è il desiderio, contrassegnato dalla mancanza. Diversamente, purtroppo, da quanto sostenevano Deleuze e Guattari negli Anni Settanta, il soggetto desiderante non è l’eccezione eversiva, ma è divenuto la norma produttiva, il perno ideale del circuito ipercapitalista attuale. A livello di fruizione dell’arte contemporanea ciò quindi non significa affatto che le opere più sconcertanti, più emotivamente forti (disgustose, nauseanti, disturbanti, scandalose…) colgano meglio la centralità del godimento – anzi è vero l’opposto: proprio quelle opere dove l’orrore è impaginato perfettamente dentro una teca da gioielliere, secondo una logica da “naufragio con spettatore” (il pericolo è lì, ma noi siamo distanti, sulla riva, al sicuro) sono anche le più appetibili dal mercato, sono le merci “normali” del capitalismo culturale. Le opere d’arte che invece riescono a “riflettere” la nostra insicurezza ontologica, generando un contraddittorio godimento, sono, paradossalmente quelle più cerebrali, come l’interminabile cadenza numerica di One Million Years di On Kawara… anche se personalmente penso che la sfida intellettuale lanciata dalla Merda d’artista di Manzoni segni tuttora un culmine teorico insuperato.
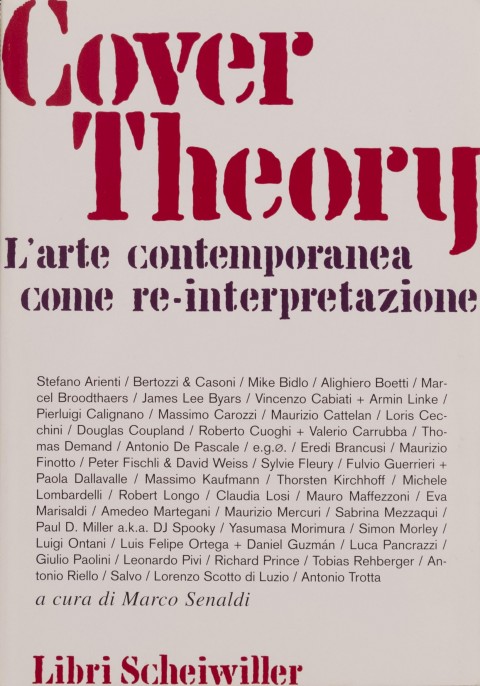
Marco Senaldi (a cura di), Cover Theory
Due nomi ricorrono nei tuoi saggi: Lacan e Žižek. Entrambi sono poco citati nella letteratura critica che verte sulle arti visive, mentre tu ne hai tratto diversi strumenti operativi per leggere l’espressione artistica del nostro tempo. Ci rendiamo conto che non è facile sintetizzare, ma qual è l’apporto che ognuno di loro può dare all’ermeneutica estetica?
Ciò che avevo tentato di fare con Enjoy! era di applicare all’arte contemporanea un concetto, quello di jouissance, che, elaborato psicoanaliticamente da Lacan, era stato esteso alla critica sociale da Žižek, con un libro che (assieme a Critica della Ragion cinica di Sloterdijk, a Opera Aperta di Eco e a Jouir du Pouvoir di Pierre Legendre) ne costituisce un po’ l’orizzonte ideale, cioè Enjoy your Symptom.
In quel saggio (come in numerosi altri, tra cui Looking Awry e Tarrying with the Negative) Žižek rileggeva Lacan in un modo per me del tutto inedito (per cui posso dire di aver riscoperto Lacan dopo e grazie a Žižek, e non viceversa): dietro al Lacan tetramente strutturalista che era passato in Italia negli Anni Settanta riemergeva ora un fine dialettico della soggettività, imbevuto di idealismo classico, le cui teorie, divenute trasparenti, si applicavano meravigliosamente alla società mediale e ai suoi miti, come i grandi racconti hollywoodiani.
Raccontaci di questa rilettura di Lacan. Qual è il punto più rilevante dell’interpretazione di Žižek?
Per me è stata di importanza capitale la curvatura che Žižek ha saputo imporre alla distinzione lacaniana tra reale, simbolico e immaginario: la realtà non ha nulla di (del) Reale, è piuttosto una fragile ragnatela di rapporti appunto “simbolici”, sempre esposta allo strappo o semplicemente alla catastrofe totale. Ho visto personalmente Žižek minacciare (scherzosamente, ma non tanto) di fare cose incongrue (urlare, camminare sulle mani ecc.) per far capire come il patto simbolico tra uditorio e conferenziere sia qualcosa di delicato e instabile (come, se vuoi, il patto tra intervistato e intervistatore…). Questo significa che la dimensione immaginaria non è solo trascendente rispetto al simbolico, ma retroagisce sulla dimensione reale. Se il reale è lacerazione traumatica, l’immaginario è il classico turacciolo che tappa questa falla. Ma lo fa in modo caratteristico, come sovrapposizione irreale, fantasia narcisistica, sdoppiamento spettrale.
Il merito zizekiano consiste nel prendere sul serio questa dimensione, e nel reintepretare la produzione mediale della cultura di massa come una specifica strutturazione immaginaria. È possibile fare lo stesso con l’arte? Secondo alcuni teorici, il contemporaneo è (dovrebbe essere) il luogo del “reale”, ma è facile capire che, in questo quadro, una simile presupposizione rischia di essere mera retorica. Vale quanto detto prima: un’arte di sangue, lacrime o sperma, lungi dal provocare un qualche effetto “traumatico”, è il perfetto sostegno ideologico della società dell’immaginario. Non si tratta affatto di una “educata” controversia accademica: in gioco qui c’è il destino stesso dell’impresa artistica, la sua resa al sistema o la sua riscossa.
Un filo rosso più “tematico” che attraversa tutto il tuo lavoro di studioso è quello del rapporto fra arte e immagine in movimento. E non si tratta tanto e soltanto di videoarte, quanto piuttosto di cinema e televisione. Pensiamo a Van Gogh a Hollywood (Meltemi, 2004), Doppio sguardo (Bompiani, 2008), Arte e televisione (Postmedia, 2009), Rapporto confidenziale (Mimesis, 2012). Cosa ha imparato e può imparare l’arte dai mezzi di comunicazione di massa? Esiste un canale che va nell’altro senso, ovvero dall’arte al cinema/televisione? Se sì, quale tipo di influenza esercita?
Banalmente, credo che non si possa pensare l’arte contemporanea “al di fuori” dell’ambito mediale, ma non si possono nemmeno veramente pensare i media fuori dalla dimensione artistica. Più che di canali, però, che danno l’immagine di flussi unidirezionali, direi che si tratta di colpi di fulmine reciproci: l’arte si innamora periodicamente della muscolatura possente del cinema mainstream, della sua solida struttura narrativa, della sua fluente capillarità comunicativa – ma anche il cinema non resiste alla seduzione dei messaggi cifrati, al fascino metalinguistico, all’irresistibile tentazione concettuale, che promanano dall’arte contemporanea…
I risultati però dipendono dagli innamorati: non tutti sono benedetti dal talento di Michael Haneke o di Albert Serra. Allora l’amore genera mostri: come Birdman, la cui struttura visuale senza tagli non è che una triste e pasticciata parodia del lirismo di Arca Russa di Sokurov, a sua volta però debitore del perfetto meccanismo di Wavelenght di Michael Snow.

Marco Senaldi, Doppio sguardo
Nel tuo libro Definitevely Unfinished (Guerini e Associati, 2012) scrivi che l’arte contemporanea “ha la strana tendenza di spiegare se stessa e il suo ruolo storico”, di manifestare la sua natura soggettiva essendo “definitivamente non-finita”. Secondo te, considerando tale tratto che contraddistingue l’arte, come è cambiato il ruolo dello spettatore?
Il tipico resoconto pseudo-storicista dice che prima esisteva lo spettatore passivo, che si limitava ad ammirare le opere dal suo cantuccio contemplativo, ma poi, con l’avvento dell’arte d’avanguardia, il suo ruolo è diventato sempre più partecipe finché, oggi, la sua presenza “costituisce” l’opera. Balle: all’epoca dei Salon, la gente andava a vedere i quadri dei pittori “contemporanei” per occupare il centro della scena, per deriderli, indignarsi o insultarli, o solo per vedere altri che si comportavano così; pochi anni fa, per vedere un video mi volevano costringere a vestirmi da Pinocchio, ma ovviamente ho mandato a quel paese il guardiasala.
Oggi c’è una certa confusione: la maggior parte degli autori non sono che (ex?) spettatori – come Tacita Dean che va a rifilmare i dettagli dello studio di Morandi… – mentre gli spettatori sono un po’ tutti, in cuor loro, o magari su qualche remota paginetta virtuale, altrettanti “autori”… Siamo condannati a essere almeno due cose alla volta, o una sola, ma doppia – quell’essere bicefalo (e spesso acefalo) che ho pensato di battezzare “spettautore”.
Nelle stesse pagine scrivi anche che tra arte e filosofia si sarebbe compiuta una inversione. Che ruolo ha avuto l’affermazione del concettualismo rispetto a tale cambio di direzione?
Una volta ho visto un manuale di filosofia dove, per illustrare Wittgenstein, avevano usato un’immagine di Kosuth. Bestialità pura: il concettuale non è l’illustrazione di un discorso filosofico, perché è semplicemente filosofia in sé. Un giorno bisognerà pur riscrivere i manuali di filosofia (se ce ne saranno ancora) mettendo il dadaismo, la pop art e il concettuale là dove devono stare, cioè accanto alla fenomenologia, all’esistenzialismo e allo strutturalismo.
Le pagine mancanti nei manuali di storia dell’arte magari potrebbero essere riempite dai film… Le sorprese del futuro deriveranno da una completa e totalmente sovversiva ristrutturazione delle forme e delle classificazioni dei saperi, così come le abbiamo conosciute, e studiate.
I titoli e soprattutto i capitoli dei tuoi libri hanno quasi sempre un tenore ironico, paradossale: il libro del 2001 che hai pubblicato con Antonio Piotti si intitolava Maccarone, m’hai provocato!, citando una celeberrima scena cinematografica con Alberto Sordi, e nel tuo ultimo libro, Obversione (Postmedia, 2014), si legge del Paradosso della bresaola e di Merda, brufolo, preservativo. Si tratta di una scelta comunicativa, di un aggancio alla realtà? Perché in realtà c’è poi un legame sostanzialmente nullo con la cosiddetta “popsofia” nei tuoi libri, che sono densissimi.
Il fatto è che non riesco a reprimere il mio profondo innamoramento per la cultura di massa, nelle sue espressioni più retrive, becere e perfino completamente idiote. Potrei spingermi a considerare prodotti come La pupa e il secchione o Temptation Island come i veri poemi erotici del nostro tempo. Anzi, sogno una versione di Temptation Island in chiave filosofico-artistica, dove un critico d’arte come me, che detesta i fumetti, viene rinchiuso per tre settimane in un harem dove disegnatrici bellissime gli fanno cambiare idea, ma poi in un tragico falò deve confrontarsi faccia a faccia con i suoi ex-amici videoartisti…
Ma la cosa peggiore è che esperimenti simili li abbiamo anche già fatti, come quando, negli Anni Novanta, ci lasciarono realizzare e mandare in onda (!) una serie di puntate di mezz’ora sul “Nulla”, sul “Ritorno del Classico” o sui “Nonluoghi”… Credo che a Mediaset, in quell’epoca, regnasse una sorta di anarchismo situazionista, una specie di potere parallelo, del resto perfettamente tollerato da quello vigente. Questi titoli a cui accenni non sono che un patetico ricordo di quelle bravate epocali, un “colore verbale” per dare un po’ più di risalto allo smorto “grigio su grigio” dell’argomentare filosofico.
La cosa che mi impensierisce però non è di essere “superato a sinistra” dalla pop-filosofia, dai trattati sulla ontologia dei Puffi o sulla semantica di Peppa Pig – è invece il movimento inverso, quando il grigiore mentale arriva a soffocare anche gli ultimi guizzi di sincero colore vitale, come i seriosissimi tomi di porn studies, dove una doppia penetrazione finisce per venire mortificata da puntigliose discussioni accademiche.
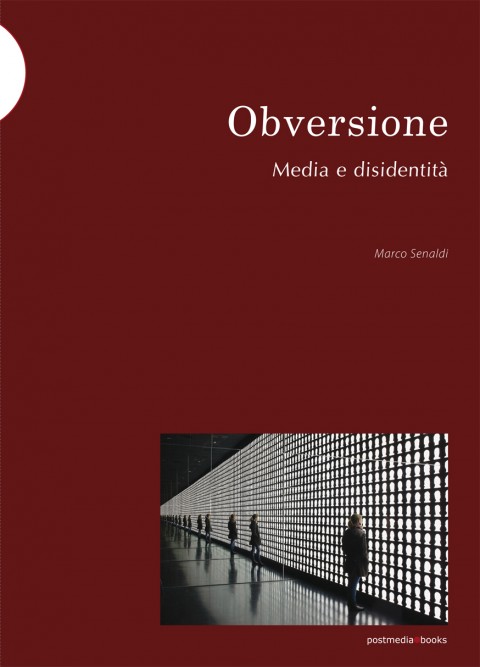
Marco Senaldi, Obversione
Tornando a Obversione: il titolo si riferisce a una figura logica che ha ricadute fondamentali nel concetto di identità individuale, di soggettività, nella propriocezione. Per spiegarne la complessità, illustri un lavoro storico di Bruce Nauman. Ci spieghi cos’è l’obversione e come permette di comprendere, se così si può dire, il nodo della dis-identità?
Con il termine “obversione” ho cercato di rendere l’idea dell’opporsi di una cosa non ad un’altra (ad essa contraria), ma, dentro di sé, esattamente a sé stessa – opposizione che, per giunta, la rende segretamente affine a quell’altra a cui “credeva” di opporsi. Questa condizione di dis-identità generalizzata è stata già colta, molte volte, e definita con altri termini, come paradosso, spettacolo, rovesciamento, condizione ossimorica, “premediation”, o anche perversione… Ma nessuno mi pare davvero soddisfacente.
Prendiamo il termine “perversione” e applichiamolo a un caso concreto, come quello dell’esazione fiscale: non è forse chiaramente una perversione quella per cui, banalmente, lo Stato arriva a esigere dai suoi sottoposti più di qualunque antico feudatario, cioè oltre la metà dei ricavi ottenuti lavorando? Certamente sì. Ma… anche no. Parlare di perversione infatti implica che, prima, vi sia stata una “versione” corretta di questa situazione, quella in cui lo Stato esigeva una equa quota fiscale in modo proporzionato a seconda delle reali possibilità dei contribuenti… Il problema è che non è mai stato così – la fantasia di uno Stato equo è ideologia allo stato puro, ed è un meraviglioso esempio di retorica dell’immaginario il fatto che l’apparato burocratico più odiato da tutti, e da tutti ritenuto il più iniquo, porti un nome che dovrebbe suonare dolcissimo, Equitalia, cioè “Italia equa”… È chiaro allora perché l’Oceania di Orwell non sia più una finzione letteraria, ma sia il fedele ritratto la nostra condizione attuale. Con una differenza radicale però: che nella “nostra” Oceania, che andrebbe ribattezzata “Obversania”, l’opposizione non passa tra due “posti” (Winston e Big Brother, il cittadino e lo Stato, ecc.), ma all’interno di ciascuno di essi; ogni cittadino vorrebbe più Stato (più illuminazione stradale, più Polizia, più efficienza, ecc.), ma anche meno Stato (fisco più leggero, meno controlli, più libertà…); e lo Stato stesso vorrebbe essere meno “statale” (più decentrato, più semplificato…) e insieme più statale (più forte, più monopolista, meno privatizzato…). Ciascun “posto” finisce così per essere attraversato da una contraddizione che, questa sì, lo rende del tutto simile al suo opposto, in una relazione “obversa” di identità-nella-disidentità.
Questa situazione disegna un anello di Moebius “elastico”, che finisce per strangolare chi vi rimane impigliato. Ma non ci sono vie d’uscita o scorciatoie; non esistono ricette di descrescita o di semplificazione: decrescere implica ipercrescere, semplificare implica complessificare… secondo il tipico mantra dialettico: più cerchi x, più ti allontani da x, e viceversa. Mi viene da parafrasare Duchamp quando diceva che “non ci sono soluzioni perché non c’è il problema”; nella condizione obversa, purtroppo, le cose vanno invece un po’ come coi piani tariffari telefonici o con l’arte contemporanea: ne abbiamo talmente tante di “soluzioni” che proprio questo “eccesso” è il nostro problema più grande.
Marco Enrico Giacomelli e Davide Dal Sasso
Artribune è anche su Whatsapp. È sufficiente cliccare qui per iscriversi al canale ed essere sempre aggiornati





